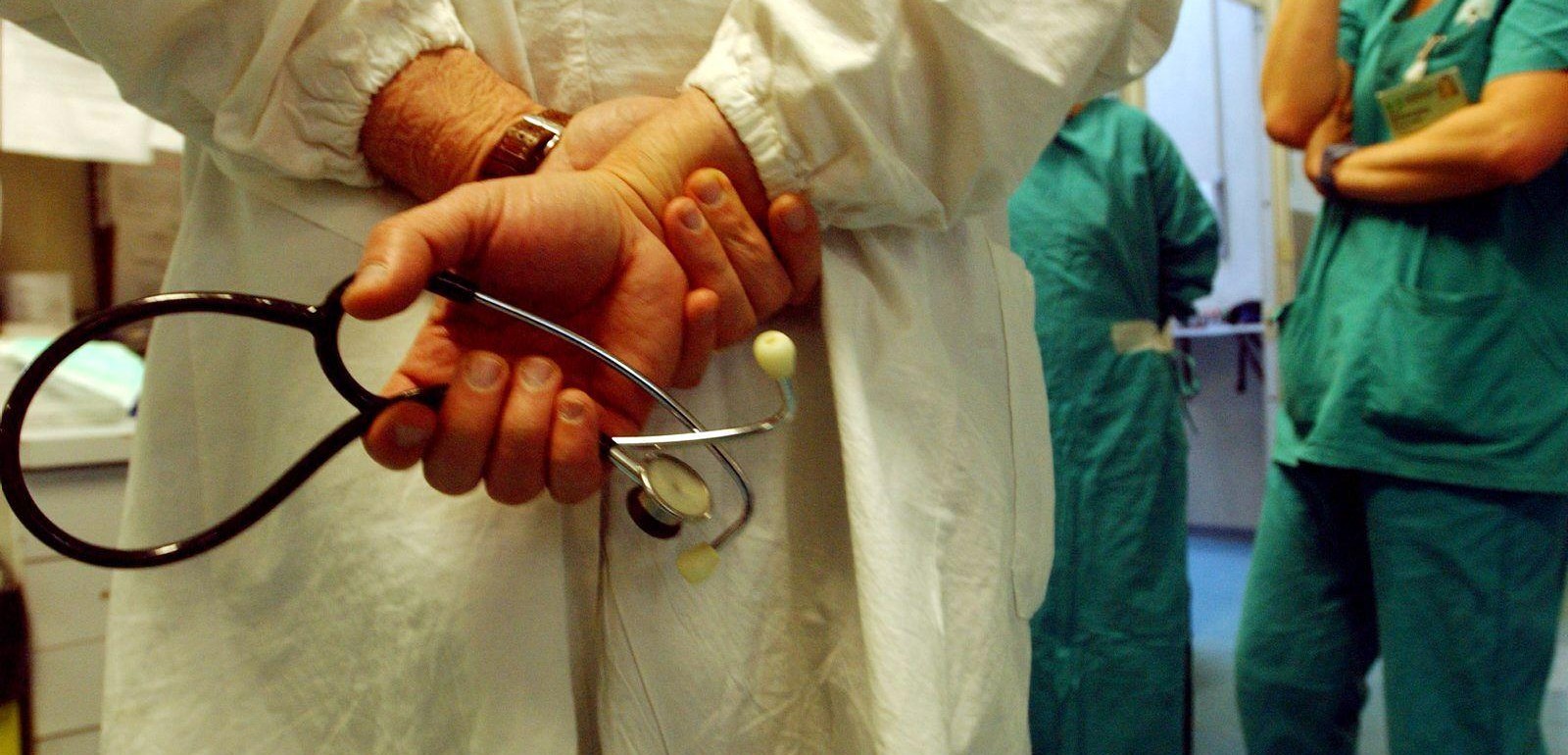di Pietro De Biasi, direttore risorse umane e relazioni sindacali Ilva
Il sistema delle relazioni industriali in Italia si appresta a vivere lo choc dell’epilogo negativo del tentativo di realizzare un nuovo accordo concertativo, dopo quello storico del 1993. Le conseguenze appaiono pesanti, visto, tra l’ altro, che di questa intesa, e della sua assoluta necessità, si discute pubblicamente da circa un lustro, e negli interna corporis di Confindustria da quasi un decennio. A tutto ciò va aggiunta la drammatica, ed a breve-medio termine insanabile, rottura tra Cgil da una parte e Cisl-Uil, dall’altra. In un momento così critico per la situazione economica interna e soprattutto internazionale, il far west che viene autorevolmente evocato sembra essere una prospettiva molto probabile nell’ambito delle relazioni industriali italiane; addirittura ineluttabile visto che la Cgil sembra aver definitivamente voltato le spalle alla concertazione stessa.
Epperò, proprio per la criticità del momento, è più che mai necessario che le parti sociali mantengano lucidità e sangue freddo, non si lascino prendere dal gorgo delle recriminazioni e delle reciproche attribuzioni di colpe, e comincino a ripensare seriamente e freddamente le ragioni profonde di questo fallimento.
Vanno innanzitutto fatte alcune considerazioni preliminari. La posizione di chiusura della Cgil è ben lungi dall’essere una sgradita sorpresa; al contrario, qualsiasi osservatore minimamente addentro alla materia avrebbe tranquillamente scommesso sul niet cigiellino. Chiunque avesse avuto speranze o anche solo dubbi è stato disilluso al più tardi dal soffertissimo e balbettante via libera fornito dal principale sindacato italiano all’accordo sul welfare, negoziato nel 2007 dal governo Prodi per il tramite di un ministro del lavoro di provenienza Fiom, Cesare Damiano. Pensare ad un esito positivo di una trattativa, oggettivamente più ostica, avendo come controparte Confindustria e non un governo “amico” e per di più sotto l’egida dell’ “arcinemico” Sacconi, era davvero pressocchè impossibile. Lo stesso accordo del 1993, a cui sempre ci si riferisce come modello metodologico da imitare, era stato firmato a costo delle dimissioni dell’allora segretario generale Trentin, ed in una situazione di crisi economica e sociale senza precedenti per il paese. L’intesa del 1993 non poteva in realtà svolgere alcuna funzione di riferimento per gli odierni negoziati, perché fondamentalmente diversa era stata la sua logica e la sua funzione autentica: esso era stata il frutto dell’emergenza, realizzata in un’ atmosfera di unità nazionale che non può e non deve rappresentare la norma nelle relazioni industriali di un paese avanzato. Non sarebbe perciò utile a nessuno richiamare la grave crisi economica, che si va minacciosamente addensando, per chiedere in nome del superiore interesse generale, l’adesione di tutte le parti ad un “nuovo” patto sociale (peraltro non pensato per affrontare questa particolare crisi), a prescindere dai suoi contenuti reali.
Quest’ultima considerazione pone in questione la logica stessa degli accordi concertativi. Per avere relazioni industriali efficienti (accordi rapidi e con poca conflittualità) ed efficaci ( coerenti con gli interessi macroeconomici del paese) è davvero necessario dotarsi di un accordo normativo che imponga regole e sanzioni a tutti gli attori collettivi nelle loro diverse articolazioni territoriali, settoriali ed aziendali? La risposta che in Italia si è data più o meno da tutti a questa domanda è sempre stata, almeno fino ad oggi, affermativa. Tale vasta condivisione ha probabilmente contribuito a far apparire superfluo ogni ulteriore approfondimento delle motivazioni di questo consenso. Ed infatti la gran parte dei commentatori si è limitata ad argomentazioni di carattere semi tautologico ed apodittico – l’ accordo è in sé positivo, migliorerà la produttività, aumenterà i salari etc.etc. – senza quasi mai provare a spiegare in maniera convincente come e perché dovrebbero verificarsi tutti gli evocati aspetti positivi.
Inoltre, e per brevità ci si limita solo ad un accenno, la stessa complessità – rectius, farraginosità – del modello concertativo proposto, a partire, ad esempio, dall’indice inflativo, da costruire ad hoc, è forse la prima e più insormontabile critica che gli si può e si deve proporre. Ed infatti la caratteristica essenziale delle norme primarie, che hanno l’ambizione di avere un’autorità costituzionale, dovrebbe essere la semplicità. Ciò sia perché esse dovrebbero essere di comprensione immediata per tutti i destinatari – ed in questo caso il riferimento va innanzi tutto ai milioni di lavoratori, i cui salari dipenderebbero dall’applicazione di questo modello contrattuale-, sia perché un eccesso di regolamentazione e di sofisticazione normativa provoca inevitabilmente una più rapida obsolescenza della norma stessa: la prospettiva che in pochi anni si scopra che il sistema ha di nuovo urgente bisogno di riforma e di una nuova dose di ingegneria “costituzionale” può far piacere solo a delle burocrazie professionali interessate alla perpetuazione di se stesse e del loro potere, non certo al paese.
Ed invero, prima di lanciarsi nella elaborazione di meccanismi e formule dal vago sapore alchemico, sarebbe stato forse opportuno cercare qualche verifica sperimentale. Gli altri paesi, dotati di un’evoluta democrazia industriale e ad alto sviluppo economico e sociale, dovrebbero costituire un interessante osservatorio per verificare appunto la congruenza dei percorsi italiani con gli obiettivi posti di efficienza ed efficacia.
Già un’analisi superficiale dei sistemi di relazioni industriali nei principali paesi (Usa, Gb, ma anche e soprattutto Germania e Francia) mostra che da nessuna parte viene cercata la pietra filosofale del mega accordo che regoli e vincoli l’autonomia negoziale delle parti contrattuali. E l’apparente paradosso è che senza alcuna Grundnorm formalizzata – e senza i sofisticati marchingegni contrattuali escogitati ad ogni piè sospinto dalle nostre parti-, questi paesi hanno minore conflittualità, maggiore produttività e salari più alti. Certo, le ragioni di ciò vanno ben oltre i modelli contrattuali adottati, ma quest’osservazione dovrebbe innanzi tutto far riflettere sull’enfasi ed il peso assolutamente spropositati che si è voluto dare all’obiettivo stesso della riforma degli assetti contrattuali in Italia.
Il realtà lo schema degli accordi quadro neocorporativi, con i quali organizzare e regolare verticisticamente i comportamenti delle parti sociali, è storicamente superato nei paesi più avanzati, mentre trova un’applicazione abbastanza diffusa nelle nazioni a sviluppo non ancora pienamente realizzato. La ragione principale è che, al di là delle diverse forme e modalità, storicamente determinate, nei primi non vi è (più) bisogno di controllare i comportamenti delle articolazioni sociali, perché queste da sole sono in grado di raggiungere di volta in volta un equilibrio tra i diversi interessi, funzionale e coerente con l’interesse generale del sistema economico e sociale della nazione di riferimento. Al contrario nei paesi a democrazia industriale più fragile ciò non (sempre) avviene, rendendo apparentemente plausibile il ricorso a norme di più o meno stringente regolamentazione.
Se ciò è vero, occorrerebbe innanzi tutto riconoscere che l’Italia versa ancora in uno stato di “minorità”; ed infatti se non si fa una diagnosi corretta diventa improbo individuare gli strumenti idonei a rimuovere i problemi. Poi bisognerebbe chiedersi se lo strumento adottato, nella sua forma e nei suoi contenuti, è quello giusto.
Purtroppo la risposta non può che essere negativa. Quel che colpisce immediatamente ad una lettura appena attenta dell’ ipotesi di accordo Confindustria, Cisl-Uil, è la profonda contraddittorietà del tessuto normativo rispetto agli obiettivi ed alle sue premesse; a cominciare dal più importante, l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Come è noto, le strade che conducono all’inferno sono lastricate di buone intenzioni. La trattativa tra le parti si è sviluppata a partire da un nodo cruciale. Confindustria voleva ridurre il peso del contratto nazionale per lasciare più spazio alla contrattazione aziendale, Cisl-Uil potevano accettare, almeno in via di principio, quest’impostazione solo in cambio di una garanzia dell’estensione della contrattazione di secondo livello, non lasciata a semplici impegni programmatici ed a dichiarazioni di buone intenzioni; d’altro canto, la confederazione imprenditoriale non poteva accettare un obbligo a contrarre in quest’ambito, pena la rivolta delle Pmi italiane. Il compromesso raggiunto, forse l’unico possibile, dati gli oggettivi limitati margini, ha determinato un esito completamente opposto rispetto agli obiettivi, apparentemente condivisi.
La creazione di un cosiddetto elemento di garanzia, negoziato nel contratto nazionale, che integra la retribuzione contrattuale per tutti quei lavoratori ed aziende che nel quadriennio precedente non hanno avuto una contrattazione di 2^ livello, lungi da incentivarla, tende a deprimerla perché la rende meramente sussidiaria e residuale rispetto a quanto negoziato a livello nazionale. Ma non solo. La previsione di un ulteriore elemento retributivo, oltre al recupero dell’inflazione, snatura radicalmente la funzione del contratto nazionale così come fino ad oggi si è configurata. Questi, anche grazie alla sua efficacia erga omnes, per via del legame istituito dalla giurisprudenza con l’art.36 della Costituzione, ha sempre costituito la tutela minima, e perciò inderogabile, delle retribuzioni, e dunque dei livelli di vita, dei lavoratori; su questo presupposto si è potuto costruire e sviluppare un secondo ed ulteriore livello di contrattazione. L’inserimento di una nuova componente retributiva, anch’essa per sua natura valida erga omnes, oltre a costituire un aggravio secco per tutte le aziende che nel quadriennio non hanno avuto una contrattazione integrativa (non si pensi che ciò capiti solo nelle piccole e piccolissime realtà, che comunque costituiscono il nerbo del sistema imprenditoriale italiano, ma, ad esempio, solo 2 anni fa sarebbe toccato anche alla Fiat), di fatto apre nuovi (quanto vasti?) spazi di negoziazione a livello nazionale, creando, per un’ impressionante eterogenesi dei fini, un unicum nel panorama europeo: un contratto nazionale valido inderogabilmente erga omnes e tarato tendenzialmente, non su valori salariali di tutela minima, ma, incorporando “a prescindere” almeno una parte destinata altrimenti alla retribuzione aziendale, sui livelli di redditività e produttività medi del settore di riferimento. Quanto ciò mortifichi invece di incentivare la contrattazione di secondo livello, ampliando invece quella nazionale, appare del tutto evidente.
L’altro obiettivo, inespresso forse, ma insito in una regolamentazione così stringente delle dinamiche negoziali, non può essere che quello pedagogico – per non dire paternalistico- di favorire una responsabilizzazione degli attori negoziali, fornendo loro un precostituito quanto virtuoso modello di riferimento. La strumentazione “pedagogico-sanzionatoria”, per quanto attenuata nell’ultima formulazione, è particolarmente ricca. Un elemento risalta particolarmente: in caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro sei mesi dalla scadenza del contratto nazionale, la trattativa viene, per così dire, sottratta alle parti naturali ed avocata, in una sorta di arbitraggio superiore, dalle confederazioni. La buona intenzione in questo caso è che, sotto minaccia dell’intervento dei genitori, i discoli facciano i bravi e si diano da fare per chiudere in tempi ragionevoli le vertenze, evitando di perpetuare le recenti “birbonate” dei metalmeccanici. In realtà, chi conosce “dal di dentro” le dinamiche negoziali italiane, proprio a partire dai metalmeccanici, sa che la prospettiva di interventi esterni e/o superiori (confederazioni, governo) è già stata, anche nel recente passato, la regola, piuttosto che l’eccezione, senza che ciò abbia minimamente inciso sui comportamenti concretamente assunti dalle organizzazioni di volta in volta negozianti. Ed invero, è proprio l’attesa di interventi terzi che deresponsabilizza gli attori contrattuali, spingendoli, invece che a cercare punti di equilibrio e d’intesa, a “ideologizzare” ed irrigidire le proprie posizioni, sia per rafforzarle in vista della mediazione esterna finale, sia per giocare autonome e diverse partite di carattere eminentemente politico all’interno delle proprie organizzazioni, prima ancora che con le controparti.
Questo ulteriore effetto boomerang è rafforzato ancor di più dalla indicazione della retroattività automatica della vigenza contrattuale (sigh!) e dalla previsione del recupero dell’eventuale scarto tra inflazione prevista ed inflazione reale all’interno della stessa tornata contrattuale (meccanismo che peraltro reintroduce surrettiziamente una forma di scala mobile): questi automatismi, di nuovo, rappresentano un chiaro incentivo a non mediare le proprie posizioni di partenza. In sintesi, dato il rigidissimo corsetto di prescrizioni, alle organizzazioni formalmente titolari della potestà contrattuale non resterebbe che abdicare al proprio ruolo, laddove volessero scrupolosamente rispettare i termini dell’accordo interconfederale, giacchè questi di fatto indica già con precisione millimetrica l’aumento contrattuale di volta in volta dovuto (ma, di nuovo, l’inserimento dell’elemento di garanzia rispalancherebbe tutte le finestre, quand’anche si fosse davvero chiusa la porta), oppure riaffermare i propri diritti negoziali violando l’accordo stesso.
Purtroppo anche qui il riferimento non è la Germania, dove l’arbitrato, spesso neppure vincolante, è, di volta in volta, una libera scelta delle parti titolari della negoziazione, ma semmai la Grecia, dove in caso di mancato accordo, un arbitro esterno impone autoritativamente un lodo…..non v’è bisogno di aggiungere quale dei due modelli sia il più efficiente ed il più conforme ad una società matura ed altamente sviluppata.
L’intero apparato conciliativo-sanzionatorio, oltre a non avere apprezzabili riscontri in Europa, ha un duplice e speculare difetto. Da un lato è quanto meno problematico dal punto di vista della piena autonomia sindacale, perno delle moderne democrazie industriali, dall’altro, almeno nelle sue parti più direttamente “repressive”, rischia di essere affatto retorico ed inefficace, presupponendo, per così dire, l’autopunizione del trasgressore: il pentimento è un valore morale cattolico sicuramente commendevole ma quanto mai ostico da prescrivere normativamente. In realtà, o la sanzione viene imposta da una forza terza e superiore, oppure presuppone il riconoscimento della prescrittività della norma, e della sua violazione, da parte del soggetto sanzionato, ma in questo caso la sanzione stessa è superflua. D’altro canto, è evidente che una regola con sanzione eteronoma in questa delicata materia è difficilmente conciliabile con la libera manifestazione dell’autonomia sindacale, e comunque non concedibile da alcuna organizzazione sindacale degna di questo nome. E dunque almeno questa parte dell’accordo, come la più classica delle grida manzoniane, farebbe la stessa fine dell’attuale e vigente divieto del ne bis in idem, previsto dal contratto dei metalmeccanici, tranquillamente ignorato dalla stragrande maggioranza delle piattaforme per la contrattazione integrativa che Fim-Fiom-Uilm hanno presentato nel passato e presentano anche e proprio in questi giorni.
In conclusione, credo che le parti sociali dovrebbero cominciare a riflettere sulle tante, troppe anomalie del sistema di relazioni industriali italiane, a cominciare magari dal doppio livello di contrattazione, altra nostra peculiarità aprioristicamente assunta e mai messa in discussione, e valutare se queste non rappresentino in realtà il problema su cui confrontarsi in futuro, invece che la soluzione dello stesso.
Proprio di fronte all’abbattersi di una crisi economica di carattere eccezionale, quando più necessario che mai è il concentrarsi sulle cose importanti, cercando elementi unificanti piuttosto che divisivi, c’è da sperare che Confindustria non respinga il grande quanto probabilmente involontario regalo di Epifani e, salvando forma e sostanza, non firmi un accordo separato sulle regole con Cisl e Uil.
Questo è infatti il modo più ragionevole per impedire che davvero le relazioni industriali in Italia deflagrino con grave danno per tutti ed è anche l’unico viatico possibile per iniziare quel ripensamento del sistema, innanzi tutto culturale, di cui l’Italia, a maggior ragione di questi tempi, ha grande bisogno.