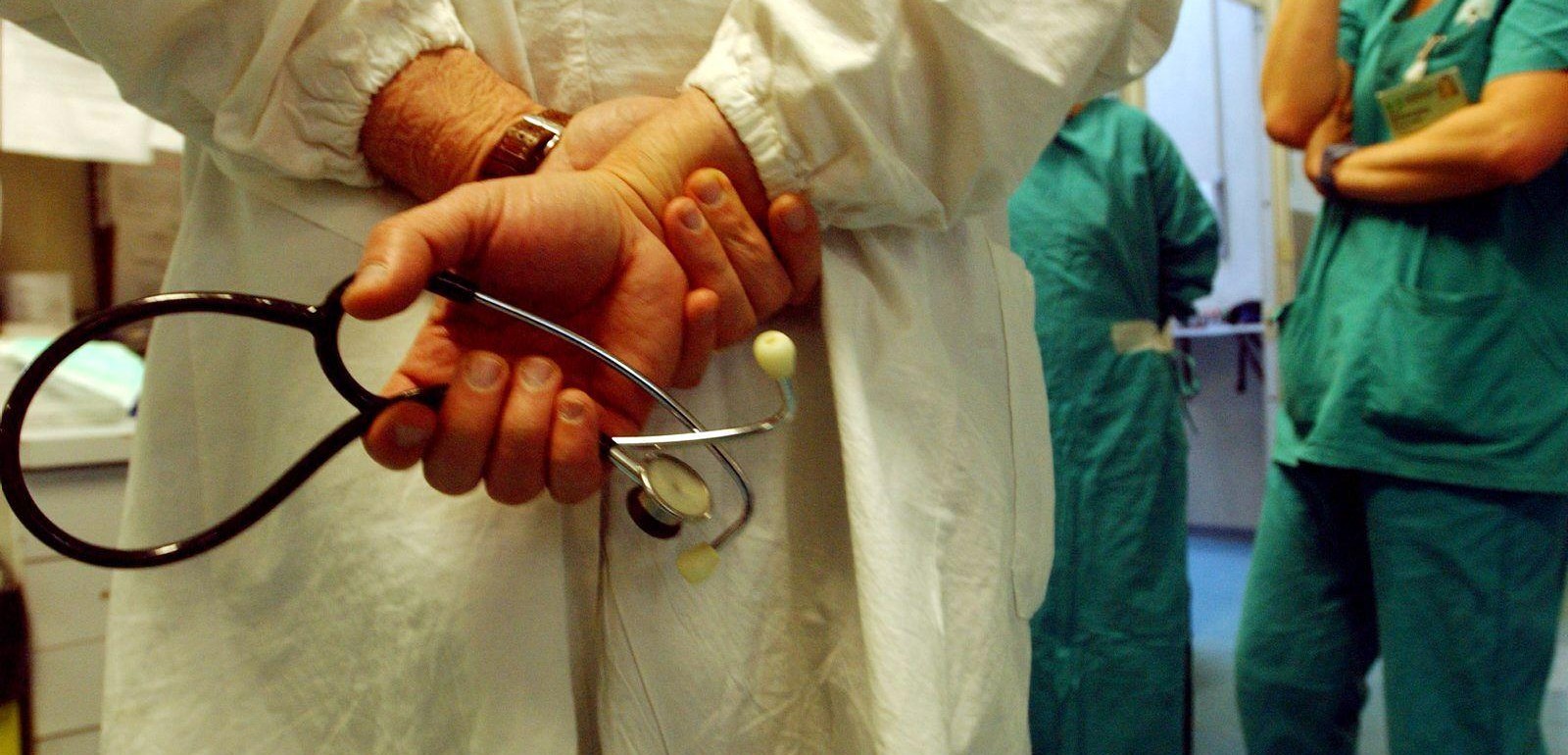di Vincenzo Bavaro – Università di Bari
1. Premessa
Al momento della scrittura di questi appunti non è dato sapere a che punto sono le trattative sul documento relativo alle Linee Guida per la riforma della contrattazione collettiva (da ora LG) sottoscritto da Confindustria, Cisl e Uil. Si proverà a leggere queste LG in controluce rispetto al Protocollo del 23 luglio 1993, del quale le LG modificano il punto 2 sugli assetti contrattual. Nel far questo sarà utile valutare anche il documento unitario sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, col quale questi sindacati si sono presentati alla trattativa, nonché tenere presente il contesto determinato da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria recentemente rinnovati.
Vale la pena, in via di premessa, partire dall’impressione conclusiva cui si perverrà alla fine di questi appunti: la riforma del punto 2 del Protocollo del 1993 presentata nelle LG supera formalmente il modello di concertazione sociale che in quel Protocollo aveva trovato il «trionfo istituzionale del modello di concertazione» (R. Del Punta, Dal Protocollo Giugni al decreto Biagi, in P. Ichino, Il diritto del lavoro dell’età repubblicana, Giuffrè, 2008). La naturale0 conseguenza è quella di ricollocare la questione salariale, dopo un lungo periodo di politica dei redditi, nell’ambito integrale della contrattazione collettiva.
Ovviamente non è questa la sede per analizzare il contesto complessivo in cui si colloca la revisione del sistema contrattuale perché ciò imporrebbe l’analisi dell’intero assetto delle relazioni industriali italiano. Nondimeno, seppur brevi, le prime osservazioni sulle LG suggeriscono di aggiornare le analisi politico-sindacali e scientifico-accademiche sul Protocollo del 1993 sulla base di alcune condizioni oggettive. Fra queste vi è la questione salariale. Non è più sufficiente verificare i risultati dell’attuazione del Protocollo del 1993 attraverso tre direttrici (procedure di rinnovo dei contratti nazionali, intervento legislativo su rappresentanza e mercato del lavoro, politica industriale e di sviluppo) (G. Giugni, La lunga marcia della concertazione, il Mulino, 2002, p. 70-71) sottovalutando gli effetti della Grundnorm di quell’accordo, cioè «contenere le dinamiche dell’inflazione, salvaguardando così i redditi delle famiglie; … risanare la finanza pubblica; … rilanciare la competitività delle imprese…» (così la Premessa alla Relazione finale della Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993).
Partiamo da un punto ormai ampiamente condiviso: esiste una questione salariale che il sistema del Protocollo, ad oggi, non risolve. Sebbene risultati siano stati ottenuti sul piano del contenimento dell’inflazione, non si può dire così per la salvaguardia del potere d’acquisto dei salari tant’è che oggi è una emergenza nazionale. Il Protocollo del 1993 (il suo sistema? la sua attuazione?), dopo quindici anni ha sortito alcuni dei risultati (moderazione salariale in linea con i tassi di inflazione programmata), non ne ha sortito altri (potere d’acquisto reale dei salari ed altro ancora che non conviene qui discutere).
Insomma, è attraverso questo quadro di contesto che si vuol leggere le LG. E difatti, raffrontando queste linee guida col Protocollo ci si accorge della differenza d’impostazione sistematica. L’accordo del 1993 colloca gli assetti contrattuali all’interno di uno schema ampio e articolato sulla politica economica, sul mercato del lavoro e sullo sviluppo e innovazione del sistema produttivo. Le LG si limitano – almeno a prima vista – a modificare solo il sistema contrattuale; eppure, queste modifiche toccano il meccanismo di dinamica salariale contrattuale: in altre parole, toccano il cuore del sistema di concertazione della p olitica dei redditi del Protocollo Giugni. Proviamo e leggere sinteticamente i punti salienti delle LG.
2. Sul contratto collettivo nazionale e aziendale
Ad una prima lettura, i cambiamenti della struttura contrattuale non appaiono significativi. Certo, vi è la modifica della tempistica contrattuale che così racchiude in un unico ciclo negoziale parte economica e normativa con cadenza triennale. Non v’è dubbio che si tratta di un intervento di razionalizzazione finalizzato a non disperdere energie contrattuali nei rinnovi biennali con problemi di sovrapposizione dei cicli. Tuttavia è bene non dimenticare che non è una modifica del tutto indolore sul piano salariale: il recupero sull’inflazione non avverrebbe più ogni due anni ma ogni tre, prolungando il periodo di vigenza dei minimi retributivi durante. Ad ogni modo, tenendo conto della effettiva cadenza dei cicli negoziali si tratta, in fondo, solo di una razionalizzazione dell’esistente. Così vale per le procedure di presentazione delle piattaforme rivendicative che devono essere presentate 6 mesi prima della scadenza con conseguente anticipazione del periodo di vigenza della clausola di pace sindacale.
Ma a parte le novità in materia retributiva (su cui si tornerà fra un momento), non vi è poi molto; sicuramente molto meno di quanto previsto dal Documento unitario sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil (contrariamente a quanto sostenuto da C. Dell’Aringa, Gli elementi positivi delle linee guida, in q. riv., 22 ottobre 2008) e con una propagandata finalità di sostegno della produttività che lascia non poco perplessi.
Prima però va detto che le LG sbiadiscono ulteriormente il già flebile riferimento al sistema di democrazia e rappresentanza sindacale. Le critiche già mosse al Documento unitario sindacale (Appunti su “democrazia e rappresentanza” nel documento unitario CGIL, CISL, UIL, in q. riv., 30 maggio 2008), sono confermate dalla lettura delle LG e da alcune vicende contrattuali che, ancora una volta, portano alla sottoscrizione di contratto collettivo nazionale “separato” (v. in proposito l’intesa di rinnovo del ccnl terziario-distribuzione-servizi col mio commento in q. riv., L’intesa “separata” di rinnovo del settore terziario-distribuzione-servizi, 4 agosto 2008). Allo stesso modo, nessun concreto riferimento a diritti d’informazione sulle politiche settoriali o sui processi di esternalizzazione e delocalizzazione delle attività, né sulla politica di sviluppo delle capacità professionali e delle politiche di formazione permanente, né sulla richiesta di maggiore incisività nelle politiche contrattuali “di genere”. Si tratta di innovazioni di carattere normativo che risentono dello stesso approccio sistematico dei Protocolli di concertazione, ma evidentemente si tratta di altra prospettiva rispetto alle LG.
Ma anche nella specifica prospettiva degli assetti contrattuali le LG abbandonano alcuni dei fattori di maggiore rilievo presenti nel Documento unitario sindacale. Si pensi alla previsione di un 2° livello contrattuale più articolato della semplice riproposizione del livello aziendale o territoriale (cioè il distretto, la filiera, ecc.). D’altronde già la Commissione di verifica del Protocollo del 1993 aveva sottolineato i limiti di un sistema basato su un modello contrattuale di 2° livello quasi esclusivamente di tipo aziendale, perciò destinato ad essere praticato solo nelle imprese medio grandi e di una sola parte geografica del Paese. Discorso analogo vale per la frammentazione delle aree contrattuali. Vero è che nelle LG si ribadisce la volontà di agire per una razionalizzazione di tali aree, ma nulla si dice riguardo ad interventi finalizzati a scoraggiare la tendenza al dumping contrattuale che, opportunamente, il Documento unitario sindacale aveva messo all’indice.
Di novità di assoluto rilievo si deve parlare riguardo alla derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte di contratti di secondo livello, finora praticato solo in un rinnovo di categoria (ccnl chimico-farmaceutico del 10 maggio 2006, art. 18). Nelle LG si legge: «la proposta di riforma affida ancora alla contrattazione di settore la possibilità di consentire che nel territorio le Associazioni delle imprese ed i sindacati territoriali di categoria, possano accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL». Si tratta di una questione di notevole impatto che lascia ancora dubbi sul piano tecnico: non è chiaro come debba essere attuata nelle categorie in cui il 2° livello è solo aziendale; se la deroga deve avvenire con contratto territoriale, allora le LG sembrano prevedere un anomalo livello contrattuale in deroga al ccnl. In ogni caso, si tratta di una modifica profonda all’assetto del Protocollo del 1993 che, invece, attribuisce al contratto di 2° livello una funzione specificativa e integrativa, non certo di deroga al ccnl. Emerge, dunque, la volontà di potenziare il contratto di 2° livello (prevalentemente aziendale) grazie al potere normativo in deroga al contratto nazionale.
Ma la centralità del contratto aziendale appare ancor più evidente se si pone attenzione alla volontà di modificare la struttura (e la funzione) salariale del contratto collettivo nazionale.
3. Sulla retribuzione
Partiamo da quanto scritto nelle LG. La struttura della retribuzione è basata su tre elementi: «gli aumenti retributivi previsti dal contratto nazionale», «l’aumento della retribuzione in funzione della contrattazione di secondo livello… collegata al raggiungimento di obiettivi di produttività ed efficienza» e «l’attivazione di un “elemento di garanzia retributiva”… che rappresenta una “rete di garanzia” a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto nazionale».
Partiamo dall’elemento che si ritiene – almeno secondo la vulgata – essere uno degli elementi essenziali della riforma: il salario di produttività aziendale. Si badi bene: non c’è nessuna indicazione su come incrementare la produttività. Non si parla minimamente di produttività settoriale; ed anche al livello aziendale, non si prende in considerazione nessuno degli elementi che concorrono all’incremento di produttività marginale di tutti i fattori, incluso quella parte del fattore lavoro che attiene alla capacità professionale di chi lavora (capitale umano). Al massimo c’è una banale idea che la produttività aumenti solo coll’aumento delle ore-lavorate, senza pensare che un aumento delle ore lavorate senza un aumento del valore della produzione può determinare anche un decremento della produttività. Ma lasciamo questi argomenti agli economisti.
Il giurista può limitarsi ad osservare che non c’è novità nella struttura della retribuzione variabile connessa al raggiungimento di risultati aziendali rispetto a quanto scritto nel Protocollo del 1993. La differenza riguarda il profilo tributario-fiscale di tale quota di salario (coinvolgente il Governo mediante la conferma della legge sulla de-tassazione della retribuzione variabile aziendale) ma non la struttura retributiva né la dinamica contrattuale. Piuttosto, raccogliendo le critiche sulla scarsa contrattazione aziendale sul salario variabile, si ritiene che ciò possa trovare stimolo nella de-tassazione di quella quota di salario. Si tratta di un assunto che non cambia nulla nelle regole e che porta con sé il rischio di frantumazione della stessa struttura retributiva variabile aziendale agevolando emolumenti retributivi supplementari individuali senza alcun reale ed effettivo collegamento a indici di produttività aziendale.
D’altronde, se non si contratta in azienda è difficile che si possa contrattare salario di produttività; e se non si aiuta la contrattazione aziendale aiutando gli agenti negoziali tutto resta nel vago; ma così torniamo alla questione della rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro. Ciò che potrà accadrà nella stragrande maggioranza dei luoghi di lavoro in cui non c’è sindacato né contrattazione è una pericolosa tendenza alla alterazione della struttura retributiva aumentando la percentuale di retribuzione variabile al solo fine di far fruire il lavoratore dei benefici fiscali. Si potrà considerare, questo, un risultato comunque positivo; sennonché, denota una strana concezione della produttività aziendale.
Sulla scorta del rinnovato contratto collettivo dei metalmeccanici, le LG intendono affrontare il problema della scarsa contrattazione di secondo livello con un «elemento di garanzia della retribuzione». Si tratta di una quota salariale che dovrà essere contrattata al livello nazionale senza che le LG abbiano ancora stabilito alcun criterio di riferimento, perciò lasciata alla pura e sola logica contrattuale di categoria. Le LG non dicono, per esempio, se questo elemento perequativo dovrà tenere conto della produttività media settoriale o di qualche elemento che tenga conto della media degli incrementi retributivi praticati nella contrattazione di secondo livello. Insomma, questo elemento della retribuzione è posto senza criteri predeterminati, perciò tutto affidato alla logica della contrattazione collettiva nazionale.
Logica contrattuale che è integralmente applicata alla contrattazione sulla retribuzione minima del contratto nazionale. Nelle LG si coglie la critica al sistema fondato sul differenziale fra inflazione reale ed inflazione programmata. Ferma restando la critica pressoché unanime al sistema delineato dal protocollo del 1993, le differenze si fanno grandi quando si tratta di definire queste critiche. Innanzitutto, non credo si possa ritenere che il modello del Protocollo stabilisca un meccanismo di recupero automatico (M. Carrieri, La ricerca faticosa di un compromesso per l’innovazione, in q. riv., 29 ottobre 2008) sia perché ciò non era scritto nella lettera del Protocollo sia perché la dinamica salariale dei rinnovi dimostra una perdita del potere di acquisto dei salari. Non sarà mai inutile ripetere che la sola volta in cui si propose di utilizzare lo schema variabile per chiedere la redistribuzione di una produttività di settore in aggiunta al recupero del differenziale d’inflazione, previsto dal Protocollo (L. Bellardi, Concertazione e contrattazione, Cacucci, 1999, p. 119), si arrivò ad un accordo separato (metalmeccanici 2002).
Vero è che il sistema dell’inflazione programmata – normalmente sempre inferiore a quella reale – ha contenuto l’inflazione reale, ma a costo di un peggioramento della condizione salariale. Qui stava la critica del Documento unitario sindacale che aveva proposto di sostituire l’inflazione programmata con una “inflazione realisticamente prevedibile”. Le LG abbandonano l’inflazione programmata e propongono «un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati». Dunque, non solo viene eliminata ogni minima allusione a ripartizioni di produttività settoriale ma si propone un nuovo indice che esclude dal computo i beni energetici importati il cui andamento dei prezzi si presume non dipendere dal sistema produttivo nazionale.
Su questo mi limito a due osservazioni: alcuni beni energetici importati (petrolio?) incidono su un numero notevole di beni di consumo che vanno dell’energia elettrica al costo di qualunque bene arrivi su un qualsiasi bancone di un mercato rionale perché, magari, causa l’aumento dei prezzi del trasporto merci (prezzo della benzina). Sarà davvero interessante scoprire come l’organo terzo incaricato di fissare tale indice potrà depurare il tasso d’inflazione da adottare ai fini contrattuali.
Ma c’è anche una seconda questione. L’adeguamento dei salari all’inflazione ha una funzione di natura costituzionale basata sull’art. 36 Cost. Si tratta di assicurare alle donne e uomini che lavorano un’esistenza libera e dignitosa «in ogni caso» garantendo una retribuzione sufficiente. Un meccanismo di adeguamento dei salari ai prezzi deve essere collocato in questa prospettiva, sicché è l’aumento dei prezzi al consumo il fatto in sé da tenere in considerazione ai fini dell’adeguamento salariale, quali che siano i fattori che determinano quell’incremento. Insomma, che dipenda da un attacco terroristico di matrice islamica o da una crisi finanziaria nel Sud-Est asiatico o da una fattori di politica internazionale, l’aumento dei prezzi al consumo danneggia i salari dei lavoratori. È a questo danno che deve soccorrere l’adeguamento salariale; non al danno “relativo” derivato dal quadro nazionale.
Complessivamente, si tratta di una relativizzazione dell’inflazione che sollecita due ipotesi interpretative. In primo luogo, la complessiva dinamica salariale tende a ridimensionare la retribuzione universale prevista dal contratto collettivo nazionale, finanche depurandola da fattori ritenuti estranei al sistema delle imprese. A compensazione, la tesi delle LG affida la dinamica retributiva alla performance direttamente imputabile a chi eroga quella retribuzione. Voler depurare l’inflazione da fattori esterni denota la volontà di non assumere la responsabilità nazionale di garantire una retribuzione che sostenga la capacità di reddito dei lavoratori; di tutti i lavoratori. Piuttosto, quella capacità di reddito potrà dipendere solo da performance aziendali che retribuiscano di più solo se si produce di più. Si delinea un sistema che nasconde, dietro la chiamata alla corresponsabilità dei lavoratori alla crescita della ricchezza del paese (la produttività), una tendenza alla de-responsabilizzazione delle imprese nella crescita del reddito dei lavoratori, annichilendo la funzione socialmente perequativa del contratto collettivo nazionale.
4. Sulla fine del modello concertativo e sulla natura della contrattazione collettiva
C’è la seconda ipotesi interpretativa di cui si diceva all’inizio. Essa riguarda l’intero sistema delle relazioni industriali e, in particolare, al ruolo del Governo nel modello di concertazione. Collocandomi in linea con una vasta letteratura scientifica, si deve partire da un punto: senza il Governo non ci può essere concertazione. Ebbene, le LG definite da Confindustria, Cisl e Uil delineano – per loro ammissione – «un modello la cui regolamentazione è integralmente affidata all’autonomia negoziale». Se il modello contrattuale del Protocollo del 1993 non poteva essere governato a prescindere dalle politiche economiche, del lavoro e di sviluppo, tant’è che la stessa dinamica salariale dipendeva da un atto fondamentale di politica economica qual è l’inflazione programmata nel Dpef sicché il salario è «una grandezza economica non più dipendente unicamente dai rapporti di forza negoziale» (L. Bellardi, Concertazione e contrattazione…, p. 68), con le LG la dinamica salariale ritorna «integralmente» all’autonomia collettiva.
Non si deve pensare che il ruolo del Governo sia del tutto obliterato dato che la dinamica del salario variabile sembra fondarsi più sulla de-tassazione (per cui occorre l’intervento della legge) che su effettivi incrementi di produttività. Nondimeno, il Governo è del tutto estraneo alla dinamica salariale perché secondo il modello delle LG le parti non hanno più ragione di negoziare col Governo il tasso di inflazione programmata. Non si tratta di mettere in discussione il principio della concertazione ma di riconoscere che le parti sociali firmatarie delle Linee Guida, sul piano del modello di relazioni industriali, propongono un potenziamento della contrattazione collettiva salariale. Si rileggano le pagine magistrali d’inizio ‘990 dei coniugi Webb: «se il livello dei salari di quel dato mestiere deve essere elevato del dieci per cento… questi problemi anche la macchina calcolatrice più perfetta non può risolverli… Dato che la soluzione è lasciata alla contrattazione collettiva, non c’è nessuna questione di principio…» (B. e S. Webb, Industrial Democracy).
Perciò, se è vero che nella prima età della stagione concertativa si riteneva che «la sottrazione all’area del contratto comporta la sottrazione all’area del conflitto» (P. Tosi, Contrattazione collettiva e controllo del conflitto, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1988, p. 459), oggi si deve riconoscere – volenti o nolenti – che la rinnovata sottoposizione della questione salariale all’area del contratto comporta la ri-collocazione nell’area del conflitto collettivo sindacale. Il conflitto che oggi anima il dibattito politico sindacale è un conflitto sindacale sulla retribuzione (più precisamente, sui criteri di determinazione della retribuzione). Verrebbe da dire, niente di più classico. Per riprendere e parafrasare gli Webb, dunque, nessuna questione di principio; solo una classica e genetica questione di conflitto sindacale sul salario.