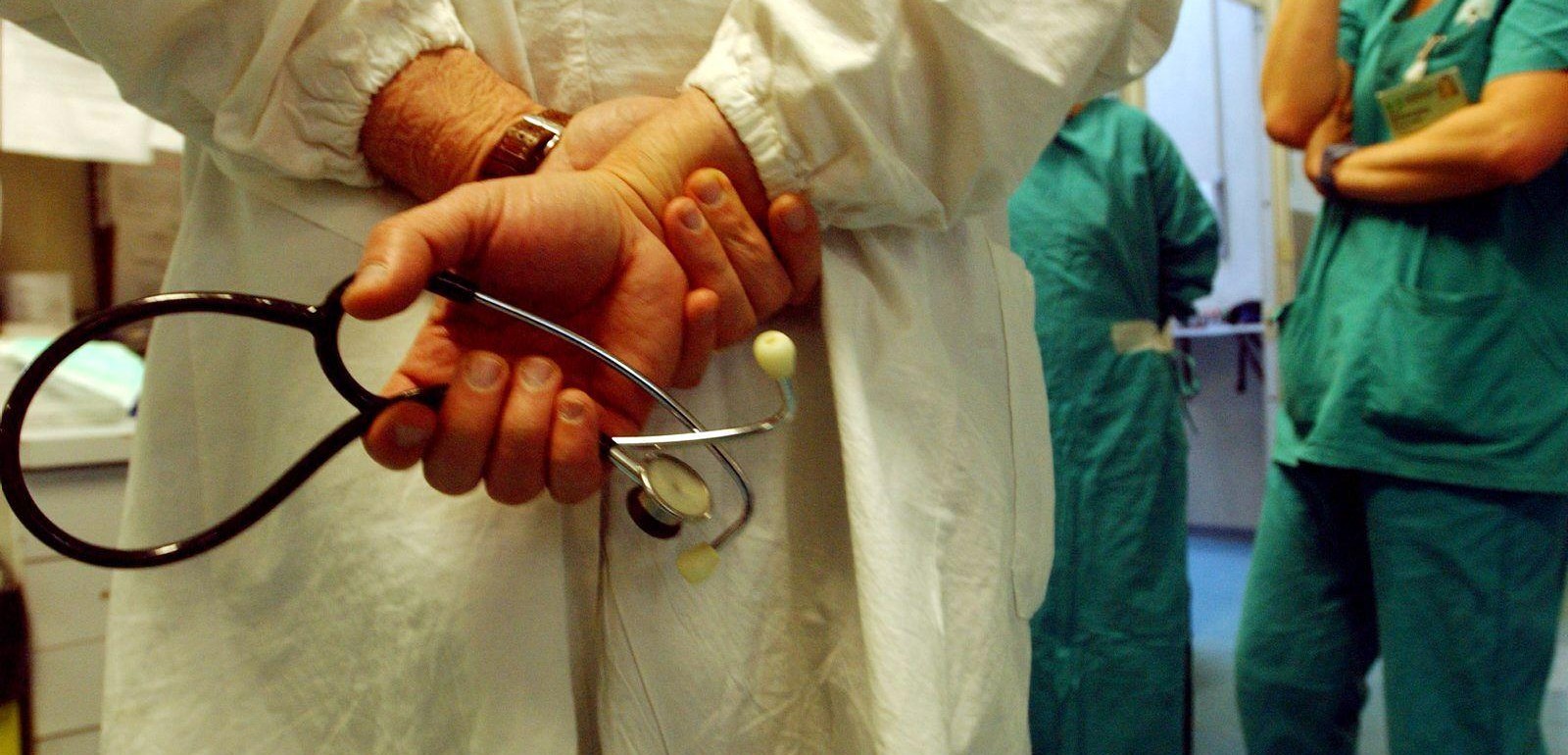Il 2026 sarà l’anno che precederà le elezioni politiche in Italia e quindi sarà, probabilmente, un anno di intensa campagna elettorale, con il rischio di ancora maggiori dosi di propaganda e, da parte del Governo, vere e proprie contro narrazioni rispetto alla realtà dei fatti. Un po’ come sta già avvenendo per questa legge Finanziaria.
Soprattutto però sarà uno degli anni più difficili per il nostro sistema manifatturiero che, piaccia o no, è ancora la spina dorsale dell’economia nazionale (e dei nostri migliori salari).
Perché siamo, certo, un paese dotato di un patrimonio artistico e di un’attrattività turistica come pochi al mondo, ma non possiamo pensare di ridurci alla Disneyland dei ricchi globali. Disneyland non da lavoro a 25 milioni di persone, non da salari significativi, non permette welfare e pensioni dignitose.
Siamo fondamentalmente un Paese trasformatore, una “macina” di semi lavorati e soprattutto di prodotti finiti, privi di risorse naturali e finanche di dotazioni tecnologiche e istituzioni finanziarie comparabili con altre grandi economie (nonostante un grande risparmio privato ma “individualista”).
Per le classi dirigenti, politiche, economiche, accademiche e sociali questo dovrebbe essere il vero assillo, da affrontare con urgenza e determinazione. La priorità a cui subordinare tutto il resto. Perché il nostro sistema manifatturiero è ancora dotato di punti di eccellenza e capacità di resilienza, ma è sotto stress da anni e soprattutto sarà ancora più minacciato nei prossimi mesi da dinamiche inedite: produttive, tecnologiche e finanche di approvvigionamento. Tutti gli indicatori di medio periodo e tutte le proiezioni per il 2027-2028 (da Banca d’Italia al Fondo Monetario Internazionale) sono chiare e gli effetti della fine del PNRR e della sua mole “contabile” non del tutto prevedibili.
Alla difficoltà dei settori metalmeccanici rischiano di sommarsi le difficoltà della filiera delle costruzioni (edilizia ma anche materiali), del tessile, del legno arredo e dell’agro industria. Rischiano di arrivare al capolinea filiere strategiche, dall’automotive alla chimica di base, passando per il collasso di molti produttori di materiali strategici (vecchi e nuovi, acciaio e silicio).
Insomma le nostre quattro A del Made in Italy rischiano di divenire un ricordo sbiadito e il treno dell’IA e dell’Internet delle cose rischia di passare per altre stazioni, con l’Italia che al massimo “pagherà” la customizzazione di modelli altrui, perdendo ulteriori competenze e professionalità (la crisi delle nostre Telco a partire da TIM dovrebbe produrre un grande dibattito nel nostro Paese, ma invece tutto tace).
Anche questa è sovranità nazionale, che tanto a cuore dovrebbe stare a chi si autodefinisce una forza “patriottica”.
Lo stesso mercato interno, per quanto è stato depresso, non sarà in grado – se non vi saranno interventi strategici di dimensioni considerevoli – di reggere il colpo al di là di quanto auspica il Ministro Giorgetti.
La stessa scelta “mercantilista” infine – correttamente denunciata dalla Cgil e dal suo leader – per cui, chi ha fatto profitti significativi in questi anni (prima dalla fase post Covid e poi dal surplus di spesa pubblica) ha preferito premiare gli azionisti e non rinvestire in modo massiccio, si dimostrerà ancora più dirompente per i conti pubblici dei prossimi anni.
I motivi per cui si è giunti colpevolmente a questo punto sono ovviamente vari: a ragioni più contingenti, nazionali ed internazionali (dai dazi Usa alla mancata politica di riduzione dei costi diretti e indiretti dell’energia nella fase “post gas russo” alla diminuzione dell’effetto macro economico del Pnrr; dalle chiusure interne delle economie Ue più forti di quanto si immagini ai colli di bottiglia sulle rotte logistiche mondiali), si sommano i ritardi decennali di una mancata programmazione industriale di medio periodo (ancora rimpiangiamo Industria 2015 di Bersani e finanche qualche intuizione di Calenda) e la mancanza di qualsiasi politica di approvvigionamento garantito di semilavorati e tecnologie strategiche.
E’ mancata e manca cioè una programmazione che faccia i conti fino in fondo con le trasformazioni delle catene produttive e di approvvigionamento che dal 2019 si sono accelerate; una pianificazione che affronti di petto il tema delle dinamiche di accumulazione di tecnologie e saperi connessi.
Il fallimento del Governo Meloni è tutto qui, in una “narrazione irresponsabile” e, parallelamente, nel boicottaggio continuo ad una risposta Europea a carattere straordinario.
Mentre si racconta un Paese che non c’è, mentre si miete consenso cavalcando la paura del futuro, questa destra ha sistematicamente boicottato ogni forma di programmazione e investimenti su scala europea, in particolare proprio su questi filoni ambientali e tecnologici su cui vi sono ancora margini competitivi evidenti, anche nazionali, e per cui le dimensioni di intervento o sono di scala europea o non sono.
La nostra sovranità nazionale e continentale è stata ceduta alla doppia egemonia fatta da “più cortile di casa” e “ più servilismo a Trump”. Si è evitato finanche di capire se e quali spazi, in un mondo più multipolare da costruire fosse solo per ridurre la “febbre delle guerra”, vi fossero e vi siano oltre gli USA. Ad Est, guardando alla Cina o a Sud, guardando al nostro mediterraneo, per partnership strategiche più paritarie.
Si è evitato con cura (al di là della “pantomima” sugli anticipi fiscali) di chiamare banche e imprese partecipate, a partire da quelle del settore energia, ad un ruolo attivo nella promozione e produzione diretta di nuove filiere connesse a innovazione tecnologica, economia dei dati, economia circolare, produzione green ed efficienza energetica nei consumi privati, domestici e di impresa. Magari con un occhio attento anche alle aree interne e al Sud Italia.
Si sono evitate con cura politiche di intervento diretto sul mancato incontro domanda e offerta nelle professioni più richieste, dirigenziali, conoscitive, ma anche operarie e tecniche.
Si è, in sostanza, portato al “paradosso dell’immobilismo” la teoria del “lasciar fare alle imprese” di cui all’intervento programmatico, ad inizio legislatura, della premier Meloni.
Confidando non sul fatto che la formula fosse efficace (il mercato di per sé non regola e non coordina nulla), ma che bastasse parlare di altro.
E mentre si impoverisce la ricerca applicata e si rende più complesso investire in innovazione di processo ancor prima che di prodotto (perché sulle P.A. non si è investito dove occorreva e non si è semplificato dove è realmente necessario) è crollata ulteriormente la produttività di sistema e in particolare la produttività del capitale.
Altro che uso della tecnologia al servizio di meno fatica, più salute e sicurezza e più valore aggiunto, nei beni e servizi: il Governo ha preferito la scommessa del lavoro povero, della svalutazione ulteriore del “costo” del fattore di produzione “lavoro” (Banca d’Italia, rapporto 2025).
La crescita relativa dell’occupazione di questi anni ha avuto questo segno: occupazione povera, con poche ore, con basso valore aggiunto, meno costosa di un investimento in nuovi macchinari o brevetti. Una dinamica tipica dei paesi in via di sviluppo, non di una grande potenza industriale.
Ma bassi salari, precarietà, frantumazione dei cicli produttivi – oltre ad essere ingiusti, oltre ad aver per anni ridotto consumi e capacità di risparmio e contribuito ad una vera e propria “depressione generazionale”– oggi non bastano e non basteranno più per reggere le dinamiche internazionali e per stare, come Italia, nella parte alta della divisione internazionale del lavoro.
Su questo rimando, tra gli altri, al recente articolo scritto per la rivista Italianieuropei da Maria Cecilia Guerra, senza aggiungere null’altro (“Salari bassi, innovazione e politiche del Governo”; n. 3/2025, disponibile anche sul sito della Fondazione).
Ma se questo è lo scenario in cui siamo, allora questo è anche il campo da gioco dove occorre riposizionarsi perché si rompa l’incantesimo di un consenso per cui è bastato e basta, per vincere, promettere che la propria condizione di vita non peggiorerà, come ben ha scritto Emanuele Felice più volte su il Domani.
Questa condizione, questa narrazione della destra, si farà più difficile nei prossimi mesi e tocca allora a chi si candida per essere alternativo a questo Governo approfittarne.
Ed individuare terreni dove proporre non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche al mondo dei saperi, della tecnica, dell’imprenditoria creativa, delle imprese di medie e grandi dimensioni, delle professioni, un altro modello di competizione.
Un modello a tutela oggi del nostro apparato produttivo e del lavoro che c’è, ma che già delinei il come costruire le basi di domani, le nuove frontiere dell’impresa 2030 e promuovere in un “patto esplicito” con le aziende nuove stagioni di crescita salariale, stabilità nel lavoro e riconoscimenti delle professionalità per milioni di donne e uomini.
Una stagione che deve vivere attraverso un’agenda condivisa di poche ma chiare priorità, di finalizzazione mirata di risorse pazienti, economiche e culturali, di scelte praticabili e concrete, e che deve vedere, a mio modesto parere, proprio il PD promotore di una coalizione democratica, progressista e riformista, che assuma questa missione come prioritaria.
Il lavoro avviato dal Partito Democratico con la presentazione del Libro Verde sulle politiche industriali, i primi di Luglio a Roma, da Andrea Orlando e Elly Schlein, è una buona base di partenza per fare ciò. Occorre ora dargli “sostanza politica”, costruirvi intorno alleanze e un’agenda.
Indicando, a mio parere, in modo esplicito due terreni su cui far convergere le migliori energie del Paese.
Il primo terreno: l’esigenza di un nuovo “patto tra produttori”, per mettere insieme investimenti pubblici e privati, risparmi d’impresa e individuali, risorse della previdenza complementare e debito pubblico finalizzato. Investimenti selettivi in innovazione e sostenibilità, con la capacità di accompagnare dentro le aziende e sul mercato del lavoro milioni di lavoratori senza lasciarne nessuno indietro, facendo del passaggio dall’economia “dark” a quella “green” l’occasione per più saperi, più partecipazione (anche nell’organizzazione del lavoro, del come e cosa si produce), più libertà per tutti i lavoratori, in tutte le mansioni occupate, comprese quelle apparentemente più umili o ripetitive.
Con uno scambio chiaro: concentrazione di investimenti, selezione di priorità, aumento della produttività aziendale a cui tutti devono concorrere, in cambio di più democrazia economica, tenendo insieme una legge sulla rappresentanza realmente attuativa dell’articolo 39 della Costituzione con una vera legge sulla partecipazione dei lavoratori in azienda, obbligatoria e con poteri reali (non quel pasticcio di legge varata un anno fa che non ha prodotto praticamente nulla). Questi i primi “100 giorni” del prossimo Governo.
Il secondo: l’impegno a ricostruire le condizioni politiche e materiali per favorire una nuova e moderna unità di azione sindacale tra Cgil, Cisl e Uil, da spendere non solo per più democrazia economica in azienda, per più contrattazione collettiva nazionale ma anche, per esempio, per più concertazione sullo sviluppo territoriale, di categoria e confederale. Ma anche per organizzare e presidiare nuove frontiere della tutela individuale e collettiva nell’epoca del lavoro digitale, delle carriere discontinue, dell’algoritmo da democratizzare.
Penso a nuove forme di mutualismo, della presa in carico di lavoratori e professionisti, con spazi e strumenti nuovi e sussidiari per cui lo Stato riconosce alle organizzazione dei lavoratori una funzione sociale, economica, di protezione e promozione che possa convivere con i modelli classici della contrattazione collettiva e dello stesso conflitto sociale. Conflitto che tutti noi riconosciamo come componente naturale di una democrazia partecipata dei moderni. Conflitto e cooperazione: non due alternative, ma due facce complementari della dialettica sociale e politica.
Una stagione di nuovo mutualismo da riconoscere e promuovere anche su base locale: formazione permanente ma anche tutele nel cambio di lavoro, incontro domanda-offerta, promozione di socialità attiva per i giovani e per chi è anziano. Per cui al sindacato va riconosciuto protagonismo e potere, non solo sui posti di lavoro ma anche nel territorio. Creando così – insieme a forme e strumenti specifici che riconoscano e valorizzino la funzione degli enti locali – veri e propri contro poteri e capacità di negoziare, sul proprio territorio, con i grandi player economici, dell’industria digitale come della logistica, dei media come dei grandi produttori manifatturieri esteri.
La destra che “conserva” può permettersi del resto, anzi può investire (come ha fatto) sulla divisione sindacale e sulla subalternità e corporativizzazione delle organizzazioni dei lavoratori. Non può farlo chi invece vuole trasformare l’esistente attraverso più partecipazione e più redistribuzione. Queste a parere mio le due priorità che il PD dovrebbe assumere.
Consapevoli che attraverso la funzione testardamente unitaria della sua segretaria, questa forza politica potrebbe e dovrebbe rivendicare, senza paure e senza patemi, una funzione di traino non solo nell’espressione delle eventuali leadership governative ma anche e soprattutto nell’essere garante di un “patto per il futuro”.
Dove le diversità non scompaiono ma contribuiscono ad un programma comune che chiami le forze vive del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della pubblica amministrazione e dello Stato, della scuola e della ricerca ad una nuova stagione di riforme, chiaramente ed esplicitamente orientate a implementare democrazia e partecipazione, miglioramento delle condizioni materiali e ambientali delle nostre città e delle nostre aree interne, riscoperta di un senso di comunità e di destino comune.
Una grande opera di redistribuzioni di opportunità e di riforme.
Ed utilizzo la parola “riforme” con grande convinzione.
Riforme “di struttura”, non contro riforme.
Iniezioni di democrazia e partecipazione contro anni di iniezioni di anestetici e bavagli, autocensure e dileggio.
Il riformismo – lo dico ai tanti che a sproposito usano questa parola, magari per autodefinirsi – è una cosa seria: non vuol dire fare cose un po’ meno di destra.
Il riformismo è fare i conti con la realtà e con il possibile ma per guidare le trasformazioni, per rivendicare un uso sociale delle tecnologie e dei saperi, per riaffermare il primato della politica sulla finanza e sui grandi oligopoli.
Il riformismo è guidare i processi verso un orizzonte di maggiore giustizia sociale, redistribuzione, democrazia, pace e libertà.
Il riformismo è il contrario del realismo ed è il nemico del trasformismo e dell’opportunismo.
Il riformismo è contro la paura del domani per cui vince chi si accontenta del presente mantenendo il popolo così nella condizione di sudditi.
Il riformismo è la capacità di sognare un mondo più giusto e la capacità di realizzare quel sogno ogni giorno, un pezzo alla volta, per renderlo concreto per milioni di donne e uomini.
Il riformismo è lotta politica, confronto e conflitto, costanza, speranza, costruzione di alleanze e comunità libere ed emancipate dalla paura, dai ricatti, dai bisogni.
Il riformismo è tenere insieme uguaglianza, fraternità e libertà, perché se manca uno solo di questi termini rischiamo la degenerazione o del mercato sopra tutto o della burocrazia sopra tutti.
Il riformismo è una nostra parola, di noi di sinistra, di noi (o almeno la mia) che abbiamo per esempio sostenuto convintamente Elly Schlein e ne sosteniamo lo sforzo unitario e il percorso politico.
Per questo penso che dobbiamo ridargli un’anima e un senso a questa parola e dobbiamo andarcela a riprendere. Per ricostruire una sinistra politica che si rincontri e si innervi nuovamente con la sinistra sociale, per cui lotta politica e lotte sociali, del lavoro, dell’ambientalismo, vadano insieme, di pari passo.
Senza un’anima sociale la rappresentanza politica e istituzionale si riduce a mera tecnica amministrativa. Senza una forte rappresentanza politica la sinistra sociale si riduce a mera resistenza se non testimonianza.
Riconnettere il pensiero e l’anima, la pratica di governo e la dialettica sociale, riconoscere nuovi spazi di partecipazione popolare vuol dire rimettere al centro la nostra funzione storica, vuol dire dare senso ad una visione generale che parli al Paese.
Perché se si fa il bene del Paese si fa il bene dei lavoratori, dei giovani, dei pensionati. E se si farà il bene dei lavoratori, dei giovani e dei pensionati, dei piccoli imprenditori e delle professioni contro i tanti, troppi, oligopoli che oggi ci dettano l’agenda, si farà il bene della sinistra.
Alessandro Genovesi