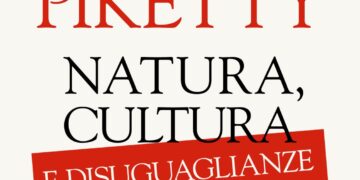Ora che la questione Alitalia approda abbastanza felicemente alla sua conclusione, dopo e malgrado l'infelicissima gestione, che solo nei giorni finali e decisivi ha finalmente cambiato metodo, entrando nel recinto della razionalità dal quale prima si era tenuta deliberatamente lontana, ora è il momento di alcune considerazioni. Necessariamente critiche. Non si può infatti e non si deve dimenticare il cumulo, la vera e propria costellazione di errori che ha accompagnato, segnato, avvelenato, gravemente complicato l'intera vicenda fin quasi alla fine, stravolgendone in certi punti i termini e gli obiettivi, facendola pericolosamente oscillare tra il drammatico e il ridicolo e sfiorandoli entrambi, con sempre sullo sfondo lo spettro del fallimento e del disastro. Valutandola sotto il profilo teatrale (poiché tutto ciò che avviene sulla scena pubblica è anche teatro), può essere tristemente definita un fedele, coerente esempio di perfetta, e perfettamente contemporanea, italianità, una vera commedia di bandiera.
Appunto per questo bisognerebbe ricordarla, non rinchiudersi ancora una volta nel vizio nazionale della dimenticanza, nell'altra italianità, quella della paura e rifiuto di avere memoria delle cose, delle responsabilità, delle colpe. Sarebbe socialmente, politicamente, oltre che moralmente, sbagliato stendere su Alitalia il cupo velo della carità di patria e della pietà (di noi stessi?), meglio, una volta tanto, serbarne consapevolezza, ad ammaestramento. Ma per qualcosa di simile, almeno finora, le premesse non ci sono. Non una voce, non un fiato si è sentito che si alzasse a riconoscere gli errori, spiegarne le ragioni, chiedere scusa: agli italiani tutti, ai lavoratori di Alitalia. E così, ufficialmente, tutto quello che è accaduto, e il modo in cui è accaduto, non ha, in superficie, né verità di cause né verità di nomi. Il silenzio è d'oro, specie quando l'oro è falso. Si cerca di nascondere sotto questo mutismo i caratteri distintivi della recitazione, e che hanno coinvolto, in momenti diversi e in diversa misura, praticamente tutti gli attori. Sopra gli elementi positivi dei quali non si ha diritto né motivo di dubitare – la sincerità delle migliori intenzioni, l'individuazione di alcuni obiettivi corretti, la giusta volontà di difesa di interessi legittimi e diritti dei dipendenti e al tempo stesso la coscienza di dover salvare la compagnia – sono stati scientemente rovesciati gli ingredienti negativi: malafede, nazionalismo provinciale, egoismi politici e corporativi, falsificazione della realtà, invenzione strumentale di un clima di esasperata tensione, sempre al limite delle (false) ultime ore per chiudere. Si è formata in questo modo una miscela alquanto infetta, che nessuno ha saputo, e probabilmente neanche voluto, governare. Soltanto negli ultimi giorni l'aria è stata ripulita, la nebbia diradata, ristabilite le condizioni di base per risolvere la vertenza.
Questo per l'ordine generale dei problemi, vale a dire la prima sostanza della questione Alitalia. Per quanto riguarda l'altra sostanza, la parte strettamente sindacale, il merito della vertenza e gli esiti della trattativa, qui si mette il piede su un terreno scivoloso. Perché in questa vertenza è accaduto un fatto significativo e certamente assai raro nelle nostre relazioni industriali. Due sono stati in realtà gli accordi, e diversi tra loro, il secondo (stesso testo del primo più un protocollo aggiuntivo contenente i cambiamenti) migliore del precedente, e non di poco; il primo firmato da Cisl, Uil, Ugl, l'altro anche dalla Cgil, che ha ottenuto da Cai i miglioramenti che l'hanno convinta a firmare. Siamo dunque di fronte ad una riapertura del negoziato per iniziativa di una sola organizzazione sindacale, che da sola discute e si accorda con la controparte, mentre gli altri sindacati hanno dovuto sottoscrivere una parte dell'intesa che naturalmente condividevano ma sul piano contrattuale non gli apparteneva. Episodio oggettivamente spiacevole per tre confederali su quattro, e si capisce l'imbarazzo, si capisce qualche segnale di nervosismo, si capisce che Uil e Ugl abbiano usato un metodo simile in chiusura del contratto piloti, strappando 40 posti part-time in più. Ma, soprattutto, episodio che chiama il mondo sindacale a riflettere molto seriamente sopra se stesso, sulla propria funzione presente, sul ruolo che deve svolgere in questa repubblica sempre meno fondata sul lavoro. In definitiva, e venendo all'osso, chiedersi cosa significa oggi autonomia, cosa contrattazione.
Nasce infatti il dubbio che i firmatari del primo accordo si siano lasciati trascinare dal clima venato di isterismo in cui era calata la trattativa e abbiano a un certo punto smarrito una percentuale della loro lucidità di giudizio, quindi di forza contrattuale, cedendo alla sindrome degli ultimatum e a quella specie di mantra ossessivo secondo il quale incombeva il fallimento e ventimila senza lavoro poiché nessuno da oltre frontiera mostrava interesse (e poi si è visto come stavano davvero le cose). E allora, alla costante, sacrosanta riaffermazione che il sindacato per sua natura contratta, sarà opportuno affiancare un attentissimo pensiero al modo in cui si contratta, alla qualità della contrattazione, come anche alla qualità dell'autonomia, al senso pieno della parola, del concetto, della pratica.
Quel che è successo nella vertenza Alitalia può avere conseguenze e riflessi, che in questa sede si possono soltanto indicare. Può avere effetti critici sui rapporti unitari, già notevolmente indeboliti. Può avere ricadute negative sul negoziato per la riforma dei contratti, dove le posizioni tra Cgil e Cisl-Uil sono assai distanti e sul quale volteggia l'ombra densa di un accordo separato. Può riproporre il tema della possibilità, oppure no, di riportare oggi alla luce dei fatti la logica di quello che fu il patto per l'Italia. Può infine, porre un interrogativo un po' truce, evocato nei giorni scorsi da un ex sindacalista Cgil ora deputato Pdl: se, come ha deciso da ultimo Colaninno, passa l'idea del niente accordo senza la Cgil, gli altri che fanno? Tutte domande cui tocca rispondere ai gruppi dirigenti confederali, ed è meglio se le risposte arrivano in tempi ragionevolemte rapidi. Non sarà facile, ma anche per questo compiti sono stati eletti. Polemizzando giorni fa con i troppi politici che s'improvvisano sindacalisti, Luigi Angeletti aggiungeva che "forse succede perché i sindacalisti in carica non sono i migliori". Rispettabile dubbio, che gli fa onore, e meritevole di utili approfondimenti. Giusto, comunque, impegnarsi, migliorarsi. La vita, come dicono i gesuiti, è milizia.
29 settembre 2009
Leopoldo Meneghelli