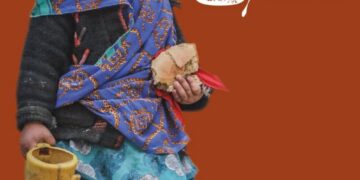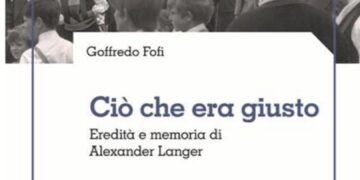Reshoring, il ritorno a casa. Mango, il gigante catalano dell’abbigliamento (2,3 miliardi di euro di fatturato nel 2015) ha annunciato che chiuderà impianti e fabbriche in Cina, India, Bangladesh e Sud Est asiatico per riaprirli in Spagna, Italia e Turchia. Ufficialmente, la decisione è figlia della strategia di accelerare le collezioni: cambiare i modelli ogni due settimane, invece che tre, è più facile se la catena produttiva è più corta. Ma la scelta di Mango è anche il segnale che, nel grande volano della globalizzazione, si sta bloccando un ingranaggio chiave. Nonostante le tante battute d’arresto nelle trattative commerciali e le reazioni populiste all’integrazione, in particolare quando c’è di mezzo l’immigrazione, la marcia della globalizzazione si appoggia da anni su un rete che appariva solidissima: quella delle “value chains”, le catene di valore, l’integrazione produttiva su scala mondiale, per cui i beni vengono assemblati da fornitori sparsi in tutto il mondo: l’iPhone è il risultato di una produzione divisa in dodici paesi. Tre quarti del commercio mondiale passa, oggi, attraverso le catene di valore. Le ha create la spinta all’offshoring degli anni scorsi, la corsa a decentrare la produzione a caccia di bassi salari.
Ma quel processo sembra essersi fermato. Da una parte, molte aziende decidono di localizzare la produzione in un solo paese, per sfuggire alle tendenze protezionistiche che si stanno diffondendo. Dall’altra, l’abbassamento dei costi non avviene più attraverso i bassi salari, ma attraverso la tecnologia.
Il fenomeno è evidente nella più antica delle industrie, il tessile e affini. Le grandi multinazionali come Adidas, Nike, Ferragamo, Zara, Brooks Brothers stanno rimpatriando le produzioni perchè la tecnologia sta rivoluzionando la lavorazione, forse anche più in profondità di quanto avvenga in settori con maggior lustro innovativo. La combinazione dei body scanners, il design automatico via software e – soprattutto in prospettiva – la stampante a 3D consente di ipotizzare la realizzazione di scarpe e vestiti su misura su una scala di massa. L’utilizzazione a tappeto dei cosiddetti “cucibot”, i robot che cuciono pelli e tessuti straccia i costi del personale, ma, secondo gli esperti, aumenta anche drammaticamente la produttività, tagliando in modo drastico i casi di correzioni e rifacimenti.
Su scala mondiale è una rivoluzione epocale, paragonabile a quella che fu l’offshoring: la delocalizzazione delle produzioni portò lavoro e salari in zone del mondo, che erano rimaste tagliate fuori dallo sviluppo industriale, come il Sud Est asiatico. L’Ilo, l’organizzazione internazionale per il lavoro, ha calcolato che, dal Bangladesh all’Indonesia, passando per Vietnam e Cambogia, siano circa 9 milioni i lavoratori impiegati dalle multinazionali del tessile, soprattutto donne. Cucibot e stampanti a 3D rischiano ora di mandarne a spasso 6-7 milioni: dal 64 per cento delle addette in Indonesia a quasi il 90 per cento in Cambogia. La cresta di uno tsunami che, sempre secondo l’Ilo, coinvolgerà, con processi analoghi, gli 800 mila addetti dell’auto, i 600 mila dei call center, i 2 milioni e mezzo dell’elettronica, sparsi nella regione.
Facile mettere in conto profondi rivolgimenti sociali. Ma il reshoring ridarà almeno fiato a classi medie e lavoratori dell’Occidente, impoveriti dagli ultimi venti anni di globalizzazione? Pensarlo significa fraintendere la logica di un reshoring che si basa su un taglio di costi, grazie alla tecnologia, anche rispetto ai bassi salari d’Oriente. Negli Usa, un’azienda che produce cotone e che aveva chiuso i battenti negli anni ’90, la Parkdale ha riaperto la fabbrica in America: produce oltre una tonnellata di filato alla settimana con 140 dipendenti. Nel 1980, per garantire la stessa produzione, occorrevano 2.000 lavoratori.