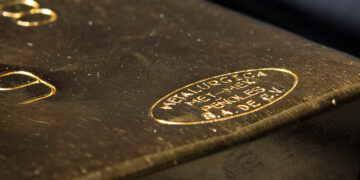Quando si parla di Comitati aziendali europei (CAE), spesso il dibattito resta confinato tra tecnicismi, direttive comunitarie e rimandi al d.lgs. n. 113/2012. La recente ordinanza n. 28790 del 19 novembre 2025 della Corte di cassazione – caso Sofidel – fa esattamente l’opposto: porta il tema al centro della pratica viva delle relazioni industriali, e manda un messaggio chiarissimo a imprese e sindacati, in Italia e in Europa.
La vicenda è, in apparenza, semplice. Sofidel, gruppo multinazionale attivo nel settore della carta, è chiamata a costituire il Comitato aziendale europeo (CAE). Le organizzazioni sindacali – tra cui SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UNI-Europa – chiedono la convocazione della Delegazione speciale di negoziazione (DSN), come previsto dalla legge. L’azienda non dice di no. Anzi: si dichiara pronta ad avviare le riunioni, ma pone condizioni molto precise. La DSN si sarebbe dovuta riunire in videoconferenza, utilizzando esclusivamente la lingua inglese, senza servizio di interpretariato. Solo dopo lo scoppio del contenzioso, e in sede giudiziaria, la società parlerà di disponibilità a forme di interpretariato.
Le organizzazioni sindacali reagiscono con un ricorso per comportamento antisindacale. La Corte d’appello di Firenze dà loro ragione, dichiara antisindacale la condotta aziendale e, soprattutto, accerta la costituzione automatica del CAE ex art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 113/2012. La Cassazione, con l’ordinanza 28790/2025, conferma integralmente questa impostazione, respinge punto per punto il ricorso di Sofidel e mette nero su bianco alcuni principi che avranno un peso concreto nelle relazioni industriali future.
Un chiarimento doveroso: la vicenda non è una crociata contro le tecnologie digitali. La Corte è esplicita nel riconoscere che la riunione in videoconferenza, di per sé, è una modalità del tutto legittima e adeguata per la consultazione e il negoziato in ambito CAE. La modernizzazione degli strumenti – tanto più dopo l’esperienza pandemica – non è affatto vista come un problema. Il problema nasce dal modo in cui questi strumenti vengono combinati con altre condizioni operative.
Ciò che viene bollato come antisindacale è l’imposizione unilaterale dell’inglese come unica lingua di lavoro, senza servizio di interpretariato. In un organismo transnazionale che dovrebbe garantire il confronto fra rappresentanti di diversi Paesi, culture e percorsi, la lingua non è un dettaglio tecnico; è una parte essenziale del potere di comprendere, intervenire, dissentire. Se la riunione si svolge solo in inglese, senza interpreti, una quota dei delegati – meno fluenti o meno abituati a gestire discussioni tecniche in quella lingua – viene di fatto relegata a spettatore. E un delegato che non capisce fino in fondo ciò che si sta dicendo è un delegato che non può negoziare davvero.
C’è di più. La Cassazione sottolinea che una scelta del genere finisce per incidere anche a monte, nella composizione stessa della Delegazione speciale di negoziazione. Se l’inglese è imposto come unica lingua, senza alcun correttivo, le organizzazioni sindacali sono indotte a selezionare i propri rappresentanti non in base alla rappresentatività e alle competenze sindacali, ma in base al livello di competenza linguistica. In altre parole, si sposta l’ago della bilancia: non conta più chi conosce meglio il luogo di lavoro, i problemi, i colleghi, ma chi parla meglio inglese. Il risultato è una distorsione evidente del libero esercizio della rappresentanza.
La società aveva provato a difendersi sostenendo, tra l’altro, che la propria proposta era comunque “adeguata” perché accompagnata dalla disponibilità a organizzare corsi di lingua inglese per i delegati. Argomento che la Corte liquida con realismo: non si può seriamente sostenere che un corso di inglese, per di più programmato in tempi brevi, sia uno strumento in grado di colmare il gap e garantire un effettivo esercizio del ruolo negoziale in un contesto tanto tecnico e delicato. Il d.lgs. 113/2012, peraltro, non parla di corsi di lingua, ma richiama espressamente, tra i costi da sostenere, proprio il servizio di interpretariato. Segno che il legislatore europeo ha ben chiaro che l’uguaglianza di partecipazione si garantisce con interpreti, non improvvisando competenze linguistiche.
Un altro passaggio chiave dell’ordinanza riguarda il tema del rifiuto di negoziare. L’art. 16, comma 1, del d.lgs. 113/2012 prevede la costituzione automatica del CAE quando la direzione centrale rifiuta di aprire il negoziato. Nel caso Sofidel, non c’è stata una dichiarazione esplicita del tipo “non vogliamo trattare”. Eppure la Cassazione riconosce che il rifiuto può ben essere implicito, e si manifesta quando l’impresa subordina l’avvio della trattativa a condizioni incompatibili con i diritti e le prerogative sindacali. Se la DSN può riunirsi solo a costo di accettare una lingua unica non mediata e una partecipazione di fatto diseguale, quel “sì, ma” equivale, sul piano giuridico, a un “no”. Da qui la conseguenza: trascorsi i termini, il CAE si considera costituito automaticamente, con tutte le implicazioni del caso.
La pronuncia ribadisce anche un principio di fondo che interessa direttamente i sindacalisti datoriali: nell’architettura della direttiva 2009/38/CE e del d.lgs. 113/2012, è la direzione centrale ad avere la responsabilità di creare condizioni effettive per la partecipazione dei lavoratori. Ciò significa che la scelta delle lingue, delle modalità di riunione, dei tempi, non può essere guidata solo da esigenze di efficienza o di contenimento dei costi, ma deve confrontarsi con il nucleo minimo di garanzie che rende la partecipazione qualcosa di reale e non di solo formale.
Per chi siede dalla parte datoriale del tavolo, il messaggio non è solo difensivo (“attenti a non farvi dichiarare antisindacali”), ma anche costruttivo. La Cassazione dice chiaramente che strumenti digitali, riunioni da remoto, soluzioni miste sono benvenuti, purché accompagnati da cautele e accorgimenti: interpreti professionali, documenti tradotti in modo comprensibile, tempi adeguati di preparazione. In questo modo, l’azienda tutela sé stessa da contenziosi pesanti, ma soprattutto si dota di un CAE che funziona davvero, capace di affrontare crisi, transizioni e politiche industriali con un confronto informato.
Dal lato dei sindacati dei lavoratori, l’ordinanza offre un repertorio argomentativo prezioso. Non si potrà più dire che il comportamento antisindacale esiste solo quando l’azienda chiude la porta in faccia alla controparte. La giurisprudenza mostra che anche le condizioni “raffinate” – lingua, organizzazione delle riunioni, modalità di convocazione – possono essere sindacate e, se usate per svuotare di contenuto la partecipazione, qualificate come antisindacali. Allo stesso tempo, i sindacati sono chiamati a fare la loro parte, costruendo delegazioni in grado di confrontarsi in contesti transnazionali complessi e imparando a sfruttare, a proprio vantaggio, gli strumenti che la normativa mette a disposizione: interpreti, traduzioni, materiale informativo multilingue.
La sentenza Sofidel, in definitiva, è uno di quei casi in cui la Cassazione entra nel merito delle dinamiche reali delle relazioni industriali. Dice, senza ipocrisie, che la lingua può diventare un’arma di selezione e di esclusione, che la tecnologia può essere usata come barriera e non come ponte, ma dice anche che nulla di tutto questo è inevitabile. Dipende da come imprese e sindacati scelgono di costruire – o di sabotare – gli spazi della partecipazione. E il diritto, quando serve, è lì per ricordare a tutti che certe scorciatoie hanno un prezzo. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 19 novembre 2025, n. 28790 (Sofidel S.p.A.).
Biagio Cartillone