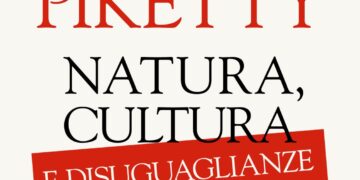di Andrea Ciampani
La discussione circa il significato della produttività oggi si incontra, in modo del tutto particolare, con le decisioni degli attori sociali sul piano della contrattazione. Questa evoluzione, grazie a una maturata consapevolezza del confronto tra i soggetti sociali, sembra suggerire che tale questione possa trovare, infine, una più ampia cittadinanza nella vivace cultura del lavoro.
Per comprendere l’ampio significato politico del diffondersi di una diffusa visione d’insieme della produttività nelle relazioni di lavoro, infatti, è bene ricordare come essa sia stata fraintesa e contrastata quando, in connessione con i grandi processi di trasformazione del nostro Paese, essa venne introdotta in Italia nelle relazioni industriali e nella contrattazione collettiva dalla Cisl degli anni Cinquanta. Si opponevano alla centralità del dibattito sulla produttività nella regolazione sociale sia il maggior sindacato italiano di allora, la Cgil, che la stigmatizzava come “supersfruttamento”, sia la leadership della rappresentanza confindustriale, che la rifiutava come un elemento fondante della contrattazione aziendale un Paese nella fase cruciale della sua industrializzazione. Mentre gli imprenditori italiani ribadivano nei primi anni Sessanta che il premio della produttività apparteneva solo all’imprenditore “che precede, che anticipa e per questo rischia” Mario Romani introdusse la prospettiva di un “incremento della produttività aziendale e del sistema” nel cuore dei lavori della “Conferenza Triangolare” del gennaio 1961 svoltasi tra parti sociali e governo per discutere delle prospettive di sviluppo economico. In effetti, egli additava la strada di una cultura della partecipazione degli attori sociali alla crescita complessiva del Paese, che le altre culture sociali (come gran parte delle culture dei partiti italiani) guardavano con scetticismo. Romani intendeva delineare un processo in cui “la distribuzione del reddito” recasse “vantaggio e non ostacolo al processo di sviluppo”.
Proprio per ricercare le strade per orientare positivamente l’evoluzione di un sistema economico in profonda trasformazione, oggi, con una rinnovata energia torniamo a riflettere, come testimoniano i contributi della rivista “Sindacalismo”. sull’esigenza di collegare il rapporto tra fiducia e produttività ad una rinnovata cultura del lavoro e delle sue relazioni. E’ in tale contesto che emerge l’esigenza di comprensione del significato e degli effetti di tale rapporto sia a livello degli scenari internazionali e di sistema, sia a livello delle dinamiche microeconomiche. Una esigenza, questa, che oggi si può avvantaggiare della possibilità di apprezzare adeguatamente il valore relazionale ed economico della fiducia.
Nel quadro di un ripensamento complessivo di una cultura del lavoro, che voglia considerare il significato dell’impresa attuale e la risorsa che per essa può costituire il dispiegarsi di un maturo movimento sindacale, tutti i fattori e gli elementi di maggiore innovazione possono acquistare maggiore limpidezza. Può essere interessante, ad esempio, verificare ed approfondire il legame fiducia – produttività considerando contemporaneamente il triplice profilo della valorizzazione del capitale umano, del profitto per lo sviluppo economico e della convenienza per l’instaurazione di virtuose relazioni di lavoro. Apparirebbe evidente, allora, il rilievo che assumono il collegamento tra produttività e livelli contrattuali e il nesso tra l’esperienza della rappresentanza (del sindacalista che ha ricevuto il mandato e del lavoratore che l’ha dato) e la realizzazione di relazioni industriali socialmente responsabili.
Lungi da seguire approcci dottrinari e pratiche di governo dell’agire economico-sociale che hanno tentato di imprigionare la cultura del lavoro all’interno di modellistiche sistemiche distanti dall’evoluzione concreta dei rapporti di lavoro, forse è giunto il momento per promuovere una riflessione e (soprattutto) per una formazione comune da parte degli attori sociali: proprio per corrispondere agli interessi rappresentati, sembra possibile proporre una cultura della partecipazione e della responsabilità, in grado di alimentare esperienza di fiducia e produttività nel mondo del lavoro. Un compito che, comunque, deve vedere protagonisti, in primo luogo, i sindacati dei lavoratori d’intesa con le energie civili e intellettuali che possono essere sprigionate nella vita della società civile, per rinnovare una visione complessiva delle relazioni di lavoro.
Una strada è aperta, anche se molto cammino sembra doversi percorrere. Già all’inizio degli anni Cinquanta, Romani osservava ai giovani sindacalisti in formazione: “La logica interna che presiede allo sviluppo dell’economia di mercato, nel senso della ricerca delle vie per l’eliminazione od il contenimento delle quote sempre più alte e sempre meno sostenibili di rischio connesse all’esercizio di un’attività produttiva industriale in regime di libera concorrenza, trova a sua volta nel fatto sindacale che si presenta in dimensioni sempre più ampie e col riconoscimento sempre più diffuso del suo fondamento teorico, un elemento di sostegno. Ma è un elemento di sostegno che a sua volta trova in quella logica (e nella realtà superante la libera concorrenza perfetta che le corrisponde) un incentivo formidabile a ulteriori sviluppi”.