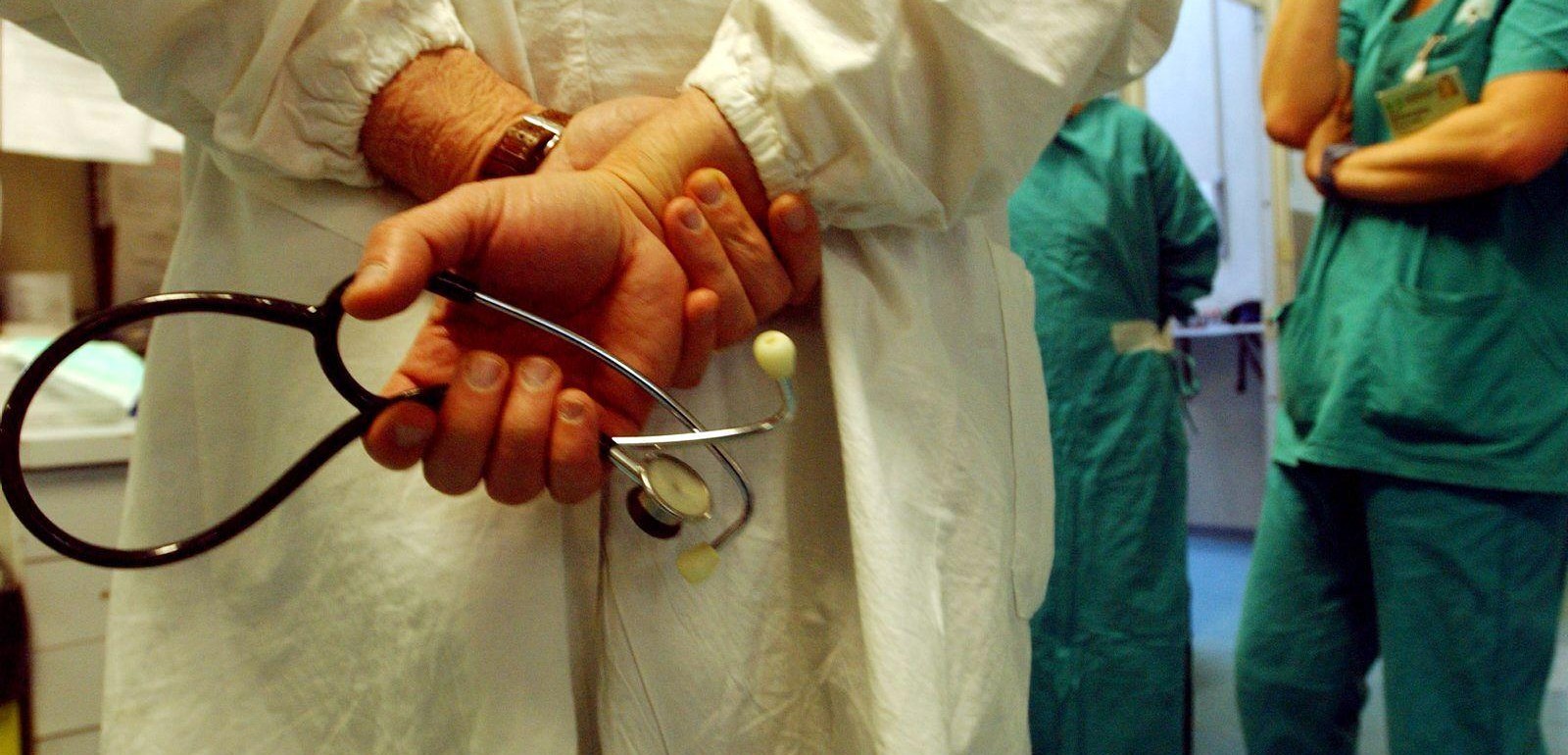Alla numerosa schiera dei critici dell’attuale sistema di contrattazione si è aggiunto sul Corriere della sera Francesco Giavazzi, noto economista, che, non essendo assiduo frequentatore della materia, si è limitato ad alcune osservazioni. Si è detto d’accordo sull’opportunità di una revisione dell’assetto attuale e ha espresso qualche dubbio sulla validità del contratto nazionale. A suo avviso non è in grado di assicurare la tenuta del potere di acquisto dei salari, specie se basati su un meccanismo di valutazione ex post dell’aumento delle retribuzioni. Intervenendo dopo il danno causato dall’inflazione, osserva Giavazzi, questo meccanismo non riesce mai a colmare tutta la perdita subita dai salari.
Il punto è che lo stesso accade con meccanismi che valutano gli accordi sulla base dell’inflazione attesa, come faceva l’accordo del 1993. Perché si calcola cosa avverrà, ma se c’è stato un picco di inflazione, la perdita accumulata è persa per sempre. Giavazzi suggerisce di stabilire negoziati “più rapidi e più frequenti”. Sulla frequenza dei contratti c’è tutta una letteratura. Innocenzo Cipolletta, che oltre a essere un valente economista è stato anche per alcuni anni direttore generale di Confindustria, e quindi di relazioni industriali se ne intende, sollecita da tempo il passaggio a contratti annuali. Se le parti sociali si incontrano una volta l’anno, sostiene, hanno poco margine di errore, perché qualsiasi evento, che l’inflazione salga o scenda, viene presto corretto, a tutto vantaggio dei salari. Una volta gli aumenti salariali venivano rivisti ogni due anni e l’esperienza non fu negativa, ma dopo qualche anno si tornò alla cadenza triennale.
La frequenza dei rinnovi contrattuali, quindi la minor durata dei contratti, non risolverebbe comunque la necessità di intervenire sulla rapidità dei negoziati. Trattative che durano anni e anni sono tutt’altro che un’eccezione. Se il rinnovo del contratto del commercio è arrivato dopo cinque anni di difficile negoziato, l’intesa per il rinnovo del contratto delle Tlc, fresco di questa settimana, è arrivato quasi tre anni dopo la sua scadenza. E parliamo di un settore capace di relazioni industriali molto avanzate, animato da parti sociali di grande capacità. Forse è proprio qui che ci si dovrebbe concentrare, ma una soluzione non sembra a portata di mano. Gigi Marelli nel suo blog su Il Diario del lavoro suggerisce di far intervenire un arbitrato quando le trattative si protraggono troppo, dopo sei mesi o un anno dalla scadenza. Si eviterebbero attese troppo lunghe, certo, ma le parti sociali perderebbero il loro potere di contrattazione, che è l’essenza stessa della loro esistenza. Se interviene una terza entità a dirimere le controversie, le relazioni industriali cambiano natura, o meglio cessano di esistere.
Sicuramente gioverebbe eliminare la concorrenza sleale dei contratti pirata, che rappresentano l’alternativa alle relazioni industriali portate avanti dai sindacati più rappresentativi e dalle grandi associazioni imprenditoriali. Eliminare la loro presenza potrebbe essere semplice, basterebbe una legge che stabilisca, sulla base delle indicazioni dell’articolo 39 della Costituzione, quali sono le parti sociali abilitate a firmare contratti validi erga omnes. Soluzione semplice da indicare, difficile da raggiungere. Perché la Cisl non vuole assolutamente una legge che regoli i problemi propri delle parti sociali.
Giustamente, perché solo le parti sociali sono in grado di elaborare la soluzione adeguata a ciascun problema. Meglio, sempre, affidarsi alla contrattazione. Il problema è che le parti sociali avevano messo a punto tra di loro già nel 2014 un sistema per valutare la rappresentanza, che però non sono state poi in grado di applicare. Quelle regole sono rimaste in fondo a un cassetto. C’è da credere, allora, che una legge non è probabilmente il sistema migliore, ma è l’unica via valida percorribile. Del resto, quando nel 2016 le tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil misero a punto assieme una proposta di riforma della contrattazione e la prospettarono alle controparti datoriali, anche la Cisl era d’accordo sul ricorso a una legge per regolare la rappresentanza. Poi il vento cambiò, l’entente si smaterializzò, tornarono impetuosi i venti identitari e non se ne fece più nulla.
Forse adesso è possibile riprendere la discussione su quella proposta. L’attuale confronto interconfederale tra Confindustria, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil verterà anche e soprattutto su questi temi, e un po’ di coraggio non sarebbe fuori luogo.
Massimo Mascini