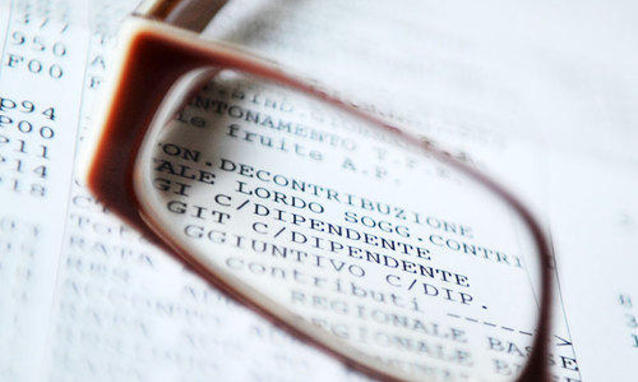Intervista ad Adriano Fabris, professore di filosofia morale all’Università di Pisa
Professore come legge l’iniziativa della Flotilla?
È ormai chiaro che l’obiettivo della Flotilla, più che portare un concreto aiuto umanitario alla popolazione gazawa, era quello di mettere alla prova e delegittimare il blocco navale imposto di Israele e sfidare i governi, compreso il nostro, a cambiare determinate posizioni e rapporti nei confronti del governo di Netanyahu. Quindi un atto politico che non è stato palesato subito ma si è manifestato nel momento in cui si è rifiutata ogni mediazione per far arrivare gli aiuti attraverso altri canali. La Flotilla ha espresso una posizione legittima ossia quella di aprire un corridoio umanitario permanente per aiutare la popolazione palestinese sottoposta a sofferenze indicibili. Ma sul piano diplomatico ha ottenuto ben poco.
E come giudica il legame tra la Flotilla e la politica?
Io vedo una grande polarizzazione nel dibattito politico, nell’informazione e anche nelle manifestazioni della società civile. E questo non porta a dei risultati concreti per i palestinesi. Ovviamente sul piano etico non possiamo non condannare ogni forma di violenza, di prevaricazione del più forte sul più debole, come sta facendo Netanyahu, o quello che è avvenuto il 7 ottobre. Ma se ogni parte continua a evidenziare le colpe e dell’altra non arriveremo mai a una mediazione capace di dare giustizia alla sofferenza. E questa mancanza la vedo molto nella politica, che accentra le istanze, le strumentalizza e che non si sforza mai di arrivare a una posizione comune per provare a dare delle risposte.
Fino a questo momento sono state poche le iniziative che hanno cercato di fermare Netanyahu? Perché? C’è ancora una sorta di debito storico da saldare per quello che è avvenuto nella seconda guerra mondiale?
La situazione del Medio Oriente è estraneamente complessa e gli intrecci sono molti dal punto di vista economico, politico e commerciale. Nella storia di quella terra ognuna delle parti ricorda qualcosa: i palestinesi la Nakba e gli israeliani le varie aggressioni subite dai paesi vicini. La Germania ha un debito storico molto forte, ma usare un fatto come la Shoa, con la sua unicità e drammaticità, come alibi per giustificare le atrocità che sta compiendo il governo di Netanyahu è del tutto sbagliato.
Lei ritiene appropriato l’uso del termine genocidio?
Bisogna capire che cosa intendiamo con genocidio. Il diritto internazionale ne ha prodotto una definizione ben precisa ed è questa che viene adottata da molti Stati per condannare ciò che sta facendo Netanyahu. Più in generale, però, il termine genocidio presuppone lo sterminio pianificato e programmato di un popolo. Ed è sulla pianificazione voluta che le posizioni si dividono. Israele si giustifica dicendo che i morti civili non sono voluti ma sono un effetto della guerra perché non è possibile distinguere nettamente tra Hamas e la popolazione, visti gli intrecci subiti o voluti dai palestinesi con l’organizzazione. È una giustificazione che in molti casi però non regge. Non si può distruggere un palazzo residenziale, con delle famiglie all’interno, poiché si pensa che possa essere usato come torre di avvistamento. Anche perché il diritto internazionale impone la tutela dei civili, che però nei conflitti contemporanei sono sempre più esposti e in prima fila, allo stesso modo dei soldati. Il termine genocidio si può accostare allora a ciò che vuole una parte del governo di Netanyahu, ma non gli accademici o agli studenti israeliani o quella parte della popolazione che si mobilita internamente contro questo governo.
Da Israele agli Usa assistiamo a un rigurgito di forme di estremismo religioso. Che visione della società portano con sé?
Il processo di secolarizzazione iniziato nel’900 non si è compiuto e stiamo assistendo al ritorno di certe espressioni religiose, spesso molto rigide e fondamentaliste, che supportano anche un certo discorso politico. Sono forme che devono, da un lato, dare risposte a tutte quelle domande che la mentalità tecnico-scientifica non è in grado di dare, ma, dall’altro, porsi sullo stesso terreno proprio della tecnologia, e quindi abbiamo predicatori da social che devono veicolare una religione che promette la felicità e il successo economico. Lo stesso Trump si è fatto portavoce di una religione di tal fatta, ma negli Usa c’è un legame molto profondo e storico tra religione e politica. Kirk si è fatto portavoce di questa religiosità, che guarda a una interpretazione letterale della Bibbia ed è quindi fondamentalista, che non dà cittadinanza alle posizioni altrui e che al massimo punta a convertirle.
Kirk è stato un esponente della libertà di parola?
La libertà di parola è una parte essenziale della democrazia, ma deve essere regolamentata e la democrazia deve arginare quelle posizioni che vogliono fagocitare le opinioni altrui o che mettono a rischio le stesse regole del gioco democratico. Ovviamente questo non vuol dire arrestarle o ucciderle come avvenuto con Kirk.
Si può parlare ancora di occidente?
Il concetto di occidente è molto vago e ha subito un forte processo di globalizzazione. Ciò che è successo è che dalla vecchia Europa, culla di ciò che definiamo come occidentale, la democrazia, il progresso tecnico, i diritti sociali, questo concetto si è spostato verso gli Stati Uniti che ne hanno dato una lettura nuova e diversa, che è diventato un modello anche per noi. Per molti anni abbiamo accettato lo stile di vita americano in cambio di una garanzia e di una sicurezza militare. Oggi tutto questo è finito. È quindi tempo che l’Europa si riappropri delle proprie radici e riproponga anche la sua visione della democrazia e di occidente, che è differente da quella statunitense.
Tommaso Nutarelli