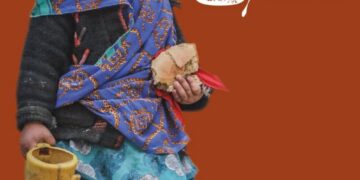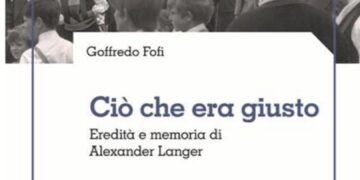L’Italia è in piena recessione: Mezzogiorno alla deriva, aumento della disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne, crescita della disuguaglianza sociale, contrazione dei consumi, propensione al risparmio in forte calo, investimenti in diminuzione a causa delle difficoltà di accesso al credito. Sono questi i temi affrontati dal Rapporto Istat 2012 che sviluppa una riflessione documentata sulle trasformazioni che interessano economia e società italiana, dalle caratteristiche competitive del sistema economico italiano alle disuguaglianze sociali e territoriali.
Il Rapporto evidenzia forti disuguaglianze in tema di povertà relativa: al Sud sono povere 23 famiglie su 100, al Nord 4,9 (dati 2010). Il 67% delle famiglie e il 68,2% delle persone povere risiedono nel Mezzogiorno. Al Sud ad una più ampia diffusione del fenomeno si accompagna una maggiore gravità del disagio: l’intensità della povertà raggiunge, infatti, il 21,5%, contro il 18,4% osservato nel Nord. Particolarmente grave risulta la condizione della famiglie residenti in Basilicata, Sicilia e Calabria. È poi peggiorata la condizione delle famiglie più numerose: in condizione di povertà relativa vive il 29,9% delle famiglie con cinque o più componenti (+7% rispetto al 1997). Nelle famiglie con almeno un minore l’incidenza della povertà è del 15,9% e complessivamente vivono in condizioni di povertà relativa 1 milione e 876 mila minori. I separati e i divorziati, osserva l’istituto di statistica, sono più esposti al rischio povertà (20,1%), rispetto ai coniugati (15,6%). Le ex mogli sono più esposte (24%) rispetto agli ex mariti (15,3%).
A questo si aggiunge, sottolinea l’istituto una “bassa fluidità sociale”: le opportunità di miglioramento rispetto ai padri “si sono ridotte e i rischi di peggiorare sono aumentati”. Questo comporta un aumento delle diseguaglianze nelle opportunità degli individui. Rara la salita sociale: solo l’8,5% di chi ha un padre operaio riesce ad accedere a professioni apicali.
Anche le retribuzioni contrattuali reali non aiutano perché ferme da 20 anni. Infatti tra il 1993 e il 2011 la crescita per le retribuzioni di fatto è stata di quattro decimi di punto l’anno.
Vali negativi anche per quanto riguarda il lavoro. Aumenta il sommerso che in Italia vale fra 255 e 275 miliardi, cioè fra il 16,3% e il 17% del Pil. Il dato è del 2008 e in riduzione rispetto a 2000, quando il peso sul Pil era oltre il 18%. Con la crisi l’area dell’economia sommersa si è “verosimilmente allargata”.
Il nuovo Rapporto annuale dell’Istat rileva che nel 2011 in Italia sono aumentati i contratti a tempo determinato e di collaborazione (+5,3% pari a 136 mila unità), concentrati prevalentemente nelle posizioni alle dipendenze. E, come già nel 2010, è aumentato soprattutto il numero di contratti di breve durata: quelli fino a sei mesi sono cresciuti dell’8,8% (+83 mila unità), mentre è diminuito quello dei contratti con durata superiore all’anno (-32 mila unità).
Gli occupati in Italia sono aumentati tra il 1995 e il 2011 di 1,66 milioni di unità (+7,8%) ma la crescita si è concentrata nel Centro Nord mentre il Sud ha fatto un passo indietro (da 6,4 a 6,2 milioni di lavoratori). Nello stesso periodo, riferisce il Rapporto annuale dell’Istat, l’occupazione nei paesi Ue15 è aumentata di 24,7 milioni di unità (+16,6%). Tra il 1993 e il 2011 gli occupati maschi sono scesi di 40.000 unità mentre le occupate sono passate da 7,6 a 9,3 milioni (1,5 mln in più nel Centro Nord, 196.000 al Sud).
Nel 2012, a due anni dalla nascita del figlio quasi una madre su quattro (il 22,7%) in precedenza occupata non ha più un lavoro. Solo il 77,3% delle neo mamme mantiene quindi il posto di lavoro a due anni dalla nascita del figlio, un dato in calo rispetto all’81,6% del 2006. Rispetto al 2002 le percentuali di licenziamento tra le cause di interruzioni del rapporto passano dal 6,9% al 23,8%.
Aumenta il numero dei giovani che restano in casa: il 41,9% dei giovani tra 25 e 34 anni vive ancora in famiglia contro il 33,2% del 1993-1994. Il 45% dichiara di restare in famiglia perché non ha un lavoro e non può mantenersi autonomamente. Emerge dal rapporto annuale dell’ Istat che il prolungamento della permanenza in casa con i genitori si estende anche a giovani adulti:il 7% fra 35-44 anni vive ancora in famiglia, dato raddoppiato. Si dimezza in 20 anni la quota di giovani che esce di casa per sposarsi.
L’Italia risulta l’ultima tra i 27 stati membri dell’Unione europea per crescita media annua nel periodo 2000-2011, pari allo 0,4%. Consistente il distacco rispetto sia ai Paesi dell’eurozona, sia dell’Unione nel suo complesso (circa un punto percentuale in meno all’anno).
L’aumento della sopravvivenza e la bassa fecondità continuano a rendere l’Italia uno dei paesi più “vecchi”: attualmente si contano 144 persone di 65 anni e oltre ogni 100 con meno di 15. Nel 1992 la proporzione era di 97 a 100. Il numero medio di bambini per donna è 1,42. Alla crescita demografica contribuiscono soprattutto le donne straniere (2,07), mentre le italiane si fermano a 1,33. In generale, si rovescia la geografia della fecondità: le regioni più prolifiche sono quelle del Nord (1,48) e del Centro (1,38).
Nel corso del 2011 la dinamica in volume della spesa delle famiglie per consumi finali ha evidenziato, dopo una stagnazione nel primo trimestre, una continua e via via maggiore contrazione (-0,1% nel secondo trimestre, -0,4% nel terzo e -0,7% nel quarto su base congiunturale). Ad accelerare la caduta dei consumi anche la propensione al risparmio che nell’ultima parte dell’anno ha registrato una leggera risalita (al 9,1%).
Il rapporto rileva poi che nel 2011 gli investimenti fissi lordi sono diminuiti dell’1,9%, sottraendo alla crescita 0,4 punti percentuali. Una modesta attività d’investimento che è stata accompagnata da crescenti difficoltà di accesso al credito bancario. A riguardo, spiega l’Istituto di statistica, “l’indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere segnala come, nella seconda metà del 2011, la percezione delle imprese sulle condizioni di credito sia peggiorata bruscamente: la percentuale di imprese che avverte un inasprimento delle condizioni di finanziamento, in crescita pressoché continua dalla metà del 2010, sul finire del 2011 si è attestata in tutti i settori su livelli compresi tra il 35% e il 45%, valori molto elevati e paragonabili a quelli osservati nelle fasi pi— severe della crisi dell’autunno 2008”. Inoltre, si legge sempre nel Rapporto, “al deterioramento delle condizioni creditizie si è associato, con qualche ritardo, un aumento della quota di imprese che si ritiene effettivamente razionata, soprattutto di quelle che si sono viste rifiutare dalla banca il finanziamento richiesto”.