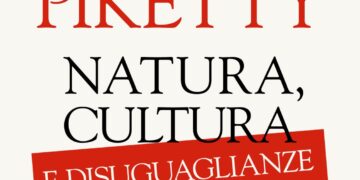Il recente sciopero generale della Cgil con i sindacati di base, ha evocato da parte del governo e di alcuni commentatori politici il pensiero di George Sorel. A cavallo tra ‘800 e ‘900, Sorel fu uno dei più influenti critici del marxismo interprete della storia sociale come evoluzione progressiva naturalmente dialettica dal capitalismo al socialismo, con il richiamo delle tesi sull’”evoluzione creatrice” di Henri Bergson.
In particolare in Sorel vive il mito dello sciopero generale, liberato dalla pura rivendicazione economica e visto come una sorta di catarsi sociale, che produce energie eroiche come forze motrici della storia. Il proletariato passa da classe sociale a idea-forza, il sindacato si fa falange: “alla violenza il socialismo deve gli alti valori morali grazie ai quali porta la salvezza al mondo moderno”.
Sorel, con le sue teorie sulla violenza proletaria fu l’ispiratore del socialismo massimalista di Mussolini – “Quel che sono lo devo a Sorel” disse di lui il duce del fascismo – con al centro l’opera “Riflessioni sulla violenza”, vero e proprio manifesto del sindacalismo rivoluzionario che ispirò personalità come Alceste De Ambris, l’autore della Carta del Carnaro della Repubblica di Fiume di Gabriele D’Annunzio, ma con simpatie anche da parte di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti e del Gruppo dell’”Ordine Nuovo”.
Ma al mito dello sciopero generale come catarsi sociale si attaglia alle iniziative della Cgil ai giorni nostri?
La Cgil, attraverso i suoi leaders, nel dopoguerra non ha mai avuto una vocazione massimalista e rivoluzionaria. Giuseppe Di Vittorio ricordava sempre l’opera del grande sindacalista socialista riformista Bruno Buozzi, segretario generale della Cgdl, affermando che grazie a lui “furono gettate le basi della nostra odierna unità sindacale, onore e vanto dei lavoratori italiani”, per realizzare il Patto di Roma del 1944. E Di Vittorio è opportuno ricordare l’attualità del suo pensiero in materia di diritto di sciopero e, al tempo stesso, di tutela degli utenti, espresso in sede di Costituente: “ll diritto di associazione comporta la libertà d’azione delle singole associazioni, per l’adempimento dei loro compiti e per la realizzazione degli scopi pei quali sono state costituite. Le libertà sindacali, che si riassumono nella piena libertà di riunione, di discussione, di manifestazione, di astensione dal lavoro, ecc., comportano il diritto di sciopero. Dato il fatto che lo sciopero in un servizio pubblico può danneggiare un gran numero di persone estranee alla vertenza, occorre una remora che ne freni l’uso e ne eviti gli abusi”.
E Luciano Lama fu sempre contrario allo sciopero generale a fini politici, anche durante l’aspra battaglia sulla scala mobile, dopo il decreto di San Valentino del 1984 varato dal Governo di Bettino Craxi, attento all’unità interna alla Cgil tra comunisti e socialisti e a quella sindacale, al tempo con la Cisl di Pierre Carniti e la Uil di Giorgio Benvenuto.
D’altronde, il nostro tempo, segnato dalla scomposizione della tradizionale divisione in classi sociali e dal post-fordismo, con l’affermazione del tecno-capitalismo e dei processi produttivi fondati sulla digitalizzazione, rende inattuali teorie e proposte come quelle soreliane, legate alla lotta di classe tra borghesia e proletariato.
E nella Cgil guidata da Maurizio Landini in verità non si scorgono inattuali suggestioni “rivoluzionarie”, semmai l’idea di trasformare il conflitto sociale in opposizione politica, con l’evidente limite segnato dal fatto che perde di vista la partecipazione e la contrattazione su temi come la conoscenza e dei saperi nell’Economia 4.0, il welfare inclusivo, la redistribuzione della ricchezza attraverso il fisco, i bassi salari, contribuendo ad alimentare la contrapposizione tra modelli sindacali, uno conflittuale l’altro collaborativo, segnato dai rapporti con l’attuale governo, senza spazio per le posizioni del riformismo europeo.
Eppure, una nuova unità d’azione sindacale nel pluralismo è necessaria, oltre gli steccati del ‘900, anche accettando di superare le attuali regole in materia di rappresentanza, rappresentatività, per affrontare il tema della efficacia dei contratti collettivi e garantire i principi di libertà e pluralismo sindacali sanciti dall’art. 39 della nostra Costituzione, con una vera “legge sindacale” fondata sull’equilibrio tra previsione costituzionale, autonomia collettiva e diritto vivente, per governare l’emergenza e il cambiamento e per dare una diversa prospettiva al mondo del lavoro e alla società italiana. E, a tal proposito, la recente legge-delega in materia, appare confusa e destinata – se attuata – a infrangersi sugli scogli della costituzionalità.
Il sindacalismo italiano, se intende accettare la sfida dei cambiamenti, deve dotarsi di nuove competenze e interagire con tutti i soggetti che sono produttori di processi di innovazione e di ridefinizione delle regole che sorreggono i modi di produrre, l’economia, la società, che insieme a forme di lavoro dignitoso e regolare richiedono nuovi sistemi di tutele, con una visione culturale adeguata ai cambiamenti in essere, superando divisioni di natura politica e di schieramento.
Maurizio Ballistreri, Ordinario ab. di Diritto del Lavoro, Università di Messina