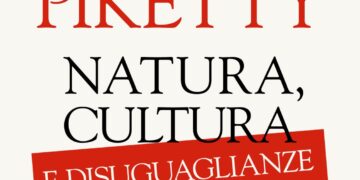"Per noi non ci sono Governi amici". No, non è Raffaele Bonanni che parla, è una delegata di Mirafiori all'assemblea dei metalmeccanici piemontesi, ma il segretario generale della Cisl sarà stato certamente lieto che una voce operaia abbia pronunciato la stessa frase da lui molte volte ripetuta in questi mesi e in cui si esprime un principio centrale del concetto di autonomia della confederazione che egli dirige. Anche se è dubbio che le stesse parole abbiano gli stessi fondamenti. In quelle della delegata, e nel fragore dell'applauso assembleare, si sente il soffio di una brezza che viene dal passato, quel che nelle circolazione sanguigna della non estinta classe operaia rimane come memoria, forse rimpianto, del vento di tramontana che fu l'ormai estinta lotta di classe. C'è l'orgogliosa e rudimentale rivendicazione di cosa dev'essere un sindacato di classe, e insieme l'altrettanto rudimentale certezza che sempre, in un accordo fra sindacato e Governo si annida, per i lavoratori, la predestinazione ad una fregatura.
Comunque sia, autonomia piena da qualunque Esecutivo. Non ci sono Governi amici e non ci sono Governi nemici, non ci sono Governi parenti e non ci sono Governi serpenti, solo Governi con i quali ci si confronta e si tratta, ci si accorda o si rompe, e su questo soltanto si giudicano. Vero e giusto. Ma rispetto ai partiti il discorso dell'autonomia sindacale è per forza di cose diverso. Lo dimostra, a titolo di esempio, quella specie di fiumicello carsico che alle scadenze elettorali riemerge dal sottoterra dell'autonomia e deposita sulle rive dei partiti alcuni sindacalisti pronti per la candidatura, generalmente sicura. E la riva è quella del partito amico, o di riferimento, come si usa dire, avendo ogni partito il suo sindacato di riferimento e ogni sindacato il suo partito. L'operazione avviene come qualcosa di ovvio. Con naturalezza e semplicità, si apre una porta e si passa di là. Il fatto non è soltanto legittimo, esso appartiene alla logica del rapporto tra sindacati e partiti, vale a dire fra istituzioni che per loro natura necessariamente ed inevitabilmente si sfiorano, s'incrociano, si toccano. E sarà interessante, a tale proposito, vedere quali effetti produrrà, sul piano dei reciproci riferimenti, il nascituro Partito democratico, che deve (dovrà, dovrebbe, chissà) razionalizzare lo schieramento di centrosinistra e, per derivazione, di sinistra. Le previsioni dicono che muoverà un po' di acque. Ma tutto ciò, sia chiaro, non mette in discussione l'autonomia, ne mette in luce la relatività della definizione e dei contenuti. Del resto, ben poco di assoluto, per fortuna, c'è in questo mondo, figuriamoci l'autonomia sindacale.
Sulla quale il ragionamento non può finire qui, chiudersi su queste troppo semplici constatazioni. Perché l'autonomia del sindacato, se non va oltre, vive, sì, ma vive incompiuta, non pienamente realizzata, in certo senso mutilata. E oggi, e negli ultimi anni, questa appare la sua condizione. Probabilmente per effetto degli anni berlusconiani, dell'alternarsi in quel triste periodo di momenti alti d'iniziativa sindacale e di fallimenti del cosiddetto dialogo sociale (che fu, e non poteva non essere, tra sordi), così come delle divisioni all'interno dello schieramento confederale, e dei segni che tutto ciò ha lasciato impressi nei sindacati e nei loro rapporti. Fra i quali segni la perdita, lo smarrimento, la rinuncia alla pienezza dell'autonomia, della sua parte più esplicitamente e coscientemente positiva, forte, creativa. Quella che si manifesta nella capacità di agire – su alcuni terreni e obiettivi fondamentali, liberamente, autonomamente scelti – per affrontare, e contribuire a risolvere, problemi che investono il sindacato ed il suo ruolo ma al tempo stesso la società intera; e farlo in maniera tale che l'elaborazione e le proposte siano, e mostrino con chiarezza di essere, il frutto di una sintesi tra gli interessi del sindacato e dei suoi rappresentati e gli interessi generali. In tempi cessati si parlava, illudendosi, di classe generale. La prova suprema dell'autonomia sindacale, e di tutta la sua forza, starebbe nel volersi e sapersi porre come sindacato generale. Non nel senso di sostituirsi ad altre istituzioni e forze ma di dare il proprio contributo – muovendosi all'interno della propria libertà e di questa sola – alla soluzione di problemi della cui soluzione il Paese ha urgente e grave bisogno.
Se ne possono indicare due: la riforma del sistema contrattuale e la riforma della pubblica amministrazione. Qui, veramente, il sindacato può offrire la misura della propria forza autonoma. Senza farsi dettare da nessun altro la strada e il traguardo, resistendo alle tentazioni corporative, al fascino della conservazione dell'esistente, all'attrazione per l'immobilità riposante e tranquilla. Mettendosi in gioco e conquistando l'autonomia anche da se stesso, da quella parte di sé che indulge alla pigrizia e cede alla paura.
Leopoldo Meneghelli