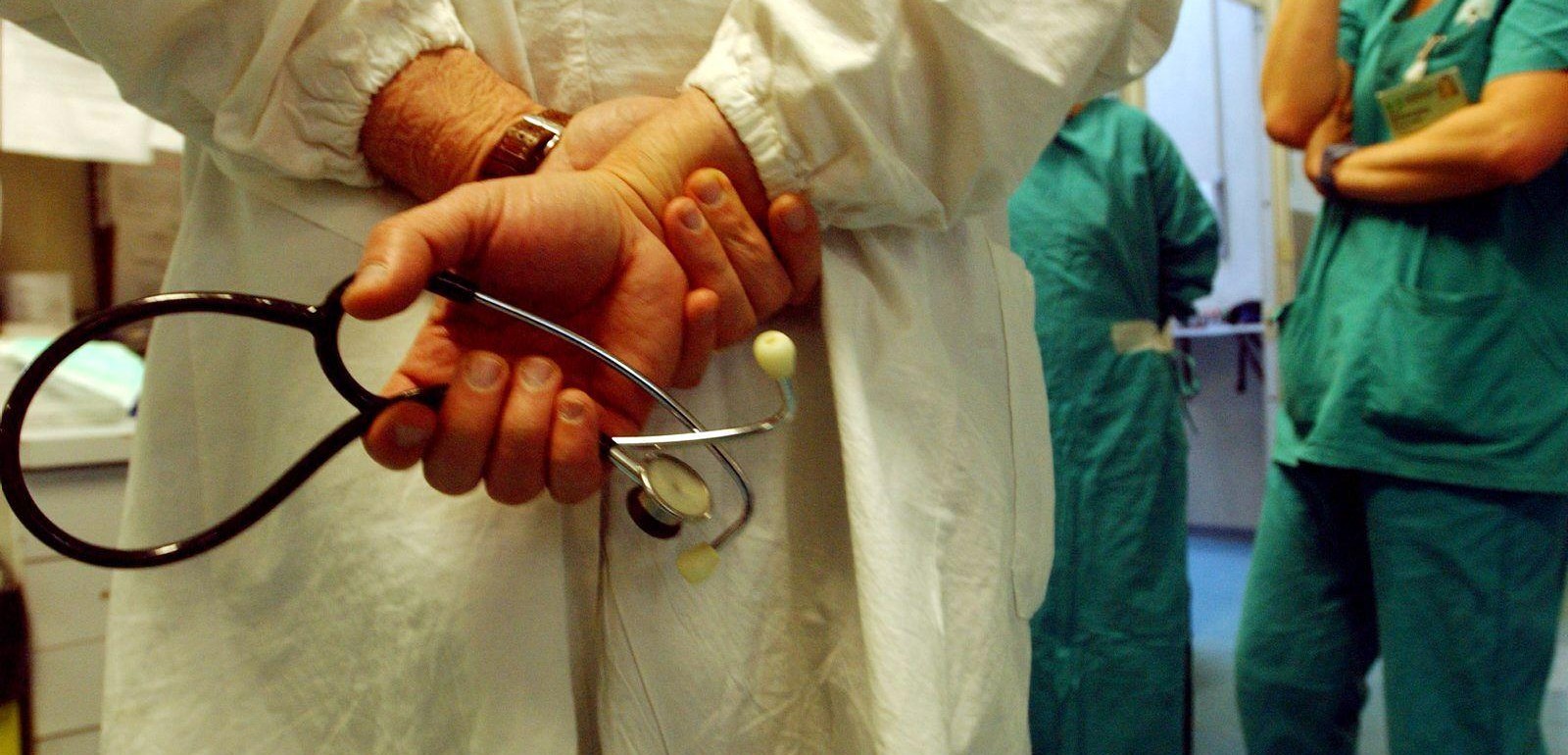Come è giusto che sia, in vista del congresso CGIL crescono le aspettative. Non è detto però che l’assise della Cgil confederale abbia quel carattere millenaristico che qualcuno vorrebbe attribuirgli. Chiunque sia il vincitore, se il documento congressuale è unico è difficile pensare a una sorta di “Bad Godesberg” sindacale e le eventuali divaricazioni di strategie avranno bisogno di tempo per consolidarsi. Le battaglie antirenziane, culminate nella “chiamata alle armi” contro il referendum costituzionale da una specie di “Esercito di Valmy” ha prodotto anche nel sindacato la sconfitta dell’anima riformista. Ma il movimento sindacale rimane un colosso organizzativo che rischia sì di avere i piedi di argilla ma può contare su una rete formidabile di quadri, di delegati, di funzionari, di attività di servizi previdenziali, fiscali, sociali che avviati in una direzione strategica lungimirante, liberandosi dei rituali degli incontri in cui si presentano le interminabili “liste della spesa”accompagnate da comunicati bellicosi e da manifestazioni tradizionali che difficilmente lasciano traccia, potrebbe essere davvero efficace nei confronti dei propri interlocutori. Quali sono gli ambiti in cui dovrebbe cimentarsi questa ricerca di nuove strategie? Prima di tutto la contrattazione dove è necessario rovesciare la “piramide contrattuale” affermando, dove vi sono le condizioni, come asse prioritario il livello aziendale o, laddove realisticamente possibile, territoriale. Il contratto nazionale manterrebbe la sua funzione, quella di determinare le condizioni normative e salariali minime. Questo orientamento non può essere certo determinato da una sorta di “nuovismo” irrazionale ma una scelta consapevole e condivisa sulla base di una più giusta divisione del valore prodotto nelle imprese, nell’interesse del lavoro dipendente. Mantenere una politica di sostanziale centralizzazione, che certo ha interessati laudatores anche nel mondo imprenditoriale, significa attestare tendenzialmente i salari sulle possibilità oggettiva delle imprese marginali che finiscono per costituire un tetto per tutti lavoratori dei settori cui si applica il Contratto collettivo nazionale. Perché non adottare il modello del sindacato tedesco, che difficilmente può essere considerato “al servizio dei padroni” che dispone sì di un contratto nazionale ma prevede anche la possibilità, per le imprese e per i lavoratori che lo vogliano, di uscire da tale ambito per dar vita, come fece il compianto (oggi) Marchionne suscitando un dibattito per molti aspetti lunare, ad un proprio contratto collettivo “nazionale” a livello aziendale. Perché togliere a quelle imprese la possibilità di una contrattazione autonoma che può dare di più perché ha maggiore elasticità, maggiore capacità di adattamento alle caratteristiche specifica del settore e in ultima analisi una maggiore competitività dell’impresa che avrebbe maggiori profitti da distribuire? Si obietta che in questo modo, essendo la realtà italiana composta da imprese di piccola dimensione si abbandonerebbe la grande maggioranza dei lavoratori, particolare del mezzogiorno, a condizioni di bassi salari poiché perderebbero una parte decisiva del potere contrattuale che esercitano in una contrattazione nazionale i lavoratori delle medie grandi imprese. La profittabilità delle imprese, che è il presupposto della loro esistenza, non è però la conseguenza della propria dimensione. Vi possono essere imprese minori di qualità eccellente, così come le recenti vicende hanno messo in luce la fragilità economica di grandi imprese. Il punto è se siamo certi che l’oggettivo contenimento delle politiche salariali a danno dei lavoratori delle imprese più dinamiche (che solo in parte ricuperano attraverso gli integrativi aziendali) possano produrre un beneficio per quelli delle imprese più “deboli”. La risposta è no, e viene confermata dai livelli salariali statici e oggettivamente bassi del nostro paese che sono resi spesso più iniqui da un potere d’acquisto che non è uguale in tutto il paese. Ciò è particolarmente macroscopico nel pubblico impiego dove i modelli retributivi tradizionalmente centralizzati hanno finito per costruire nuove “gabbie salariali”, questa volta a danno dei lavoratori pubblici “nordisti” il cui potere d’acquisto si riduce infatti sensibilmente. La centralizzazione del nostro modello contrattuale, che forse poteva essere giustificata nei primi anni del secondo dopoguerra, è oggi inadeguata anche per i cambiamenti strutturali indotti in primo luogo dalla globalizzazione. Certo si può tornare al protezionismo, una variante economica del cosiddetto sovranismo, o allargare le maglie dell’assistenzialismo, variante sociale del cosiddetto populismo ma, come diceva l’indimenticabile Felice Mortillaro: “Madamina, il catalogo è questo”. Certo non ci si può affidare solo ad una competitività generata da costi (e salari) inferiori, come di fatto avviene in molte realtà. L’obiezione che esiste un problema per le imprese più deboli è comunque fondata, ma per offrire soluzioni credibili occorre partire dalla premessa che l’esistenza di notevoli differenziali retributivi è una realtà che si può cambiare , soprattutto per il mezzogiorno, solo a condizione che si offra alle imprese, anche attraverso la contrattazione con i soggetti istituzionali, un vero ammodernamento infrastrutturale non solo materiale che riesca ad elevare gradualmente la competitività delle imprese più arretrate, favorendo processi che ne aumentino la dimensione, l’innovazione e la capitalizzazione. Naturalmente su tutto avrà un peso determinante la capacità dell’Unione Europea di uscire dalla contraddizione in cui è stretta tra moneta unica e sovranità nazionale e di darsi un nuovo e più adeguato assetto di architettura istituzionale e di politica economica per la crescita.
La seconda questione per il sindacato, inteso come l’insieme delle attuali organizzazioni, confederali ed autonome, riguarda la sua “governance”. Si tratta di avere regole esigibili che siano insieme un fattore di unità del sindacato e di partecipazione di tutti i lavoratori alle decisioni che li riguardano a qualunque livello. In alcuni paesi esistono strutture istituzionali che garantiscono, a tutela degli iscritti, il rispetto di tali regole. Nel nostro paese gli articoli 39, 40 e 46 della “Suprema Carta” hanno sancito non solo la libertà e il pluralismo sindacale ma anche uno spazio rilevante alla autonoma contrattazione delle parti, che si è spinta poi nella legislazione ordinaria fino al vituperato (ma tacitamente utilizzato dagli stessi denigratori a seconda delle circostanze) articolo 8 del cosiddetto Decreto Sacconi del 2011. L’insieme di queste norme, attuate e adeguate dove necessario (le parti sociali si sono mosse su questa strada ma ancora troppo lentamente), possono dar vita ad un’unità sindacale fondata sulle regole, l’unica oggi realisticamente possibile, e garantire la democrazia nei luoghi di lavoro attraverso modelli di democrazia rappresentativa o di democrazia diretta. Una legittimazione formale, al pari della trasparenza, può non garantire risultati di qualità, ma è pur tuttavia una condizione necessaria per ottenerli. Ciò significa anche che regole esigibili, come quelle che ad esempio disciplinano l’elezione degli amministratori dei fondi di previdenza complementare vanno estese anche a tutti i sistemi bilaterali in atto che ormai hanno una dimensione di tutto rispetto e svolgono una funzione universale. Il rinnovamento sempre invocato non può che passare da nuove politiche, da modelli partecipativi efficaci e garantire la contendibilità delle leaderships. Senza una competizione sul terreno della qualità difficilmente il sindacato, in cui oggi più della metà degli iscritti è costituita da pensionati, potrà coinvolgere le nuove generazioni di lavoratori.
Walter Galbusera