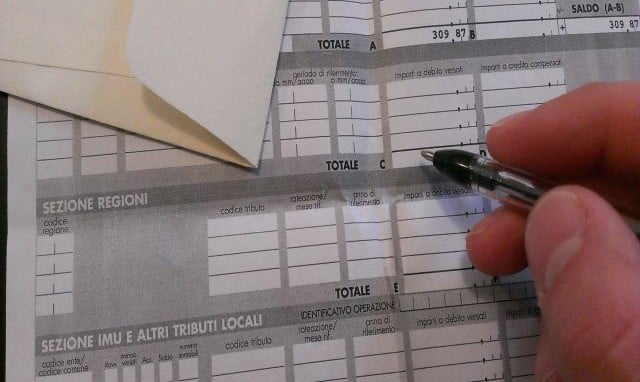di Leopoldo Meneghelli – Il Diario del lavoro
Era questione di tempo, e ora il tempo è arrivato. Lo Statuto dei lavoratori è entrato – a forza, come per la spinta infrenabile di un istinto – nella competizione elettorale. Ha provveduto a farlo Silvio Berlusconi, afferrando al volo, e magari pentendosi di non averci lui pensato prima, quanto era scritto in un editoriale del Corriere della Sera di Francesco Giavazzi. Il quale, criticando il programma del Partito democratico in materia di economia e di lavoro, indicava tra le ‘occasioni perdute’ quella di non aver proposto “di abolire lo Statuto dei lavoratori (del 1970), tutto, non solo l’articolo 18, e sostituirlo con regole moderne, a partire da un sistema generalizzato di sussidi di disoccupazione”.
Il giorno dopo Berlusconi si è impadronito dell’idea, riconoscendone l’affinità profonda, e l’ha ripetuta, ma senza parlare di sussidi. Sul piano politico-mediatico pare, almeno finora, caduta nel vuoto, e speriamo che non esca di lì. Lo Statuto, del resto, è un argomento da prendere con le molle, oggi, anche sul versante politico che sogna di cancellarlo e attende le condizioni favorevoli per metterlo in discussione. Non è stata, quella di Berlusconi, un’uscita estemporanea, ha voluto ricordare che la legge 300 rimane un obiettivo strategico da colpire per distruggerlo. E si può ragionevolmente pensare che se l’idea ha trovato posto in un editoriale del massimo giornale della nostra borghesia, questo significa che essa circola ampiamente negli ambienti economici e politici che il Giavazzi frequenta e di cui, con penna fedele, esprime le posizioni. Possibile, invece, che a lui, alla sua mente, appartenga quella che gli sarà sembrata astuta mossa, senza che ne abbia colto l’elemento comico e surreale: proporre al Partito democratico di realizzare l’impresa che la destra sa di non poter (ancora) compiere.
Ma vale la pena di fermarsi a riflettere su natura e sostanza di quel che l’economista ha proposto: l’abolizione dei diritti, la sostituzione con i sussidi. Formulata in quel modo – con poche parole, senza alcuna articolazione del discorso, deserta di ragionamento, sì che appare sprigionarsi con la violenza di un istinto – l’ipotesi, l’aspirazione, la meta da raggiungere ha il merito innegabile della sincera, perfetta brutalità. E’, limpidamente, sintesi e rappresentazione di una visione dei rapporti sociali connaturata alla realtà dell’economia capitalistica dominante e globale e che l’economia, anche per il tramite della politica, tende, per propria necessità e legge interna, a tradurre nella pratica: la concentrazione del potere nel potere economico e nelle sue emanazioni e ramificazioni, una società tagliata orizzontalmente in due dove a quelli che stanno nella parte inferiore il potere viene negato o ridotto al minimo, quindi negati o ridotti al minimo i diritti, essendo infatti, questi uomini e donne, concepiti ed usati come strumenti – tecnici – dell’economia. A loro spettano, in luogo dei poteri, dei diritti, del lavoro, i sussidi. Gli americani lo hanno definito ‘capitalismo compassionevole’, e ne vanno fieri.
Ci sono, naturalmente, a seconda delle situazioni e dei rapporti di forza, forme, gradi, modi, tempi diversi nell’attuazione di un tale disegno storico. Ma esso si mostra, a chi voglia guardarlo come va guardato, cioè senza illusioni, tendenza inarrestabile. Dunque ogni sacrosanto impegno e lotta per i poteri e i diritti dei lavoratori è oggi, in questo quadro, in questa epoca, un impegno e lotta difensiva, ogni vittoria una vittoria tattica. Coloro che si muovono nel solco del dominio dell’economia procedono con passo sicuro e pesante, forti, purtroppo, di quello che un paio di secoli fa un grande tedesco ha chiamato spirito del tempo.