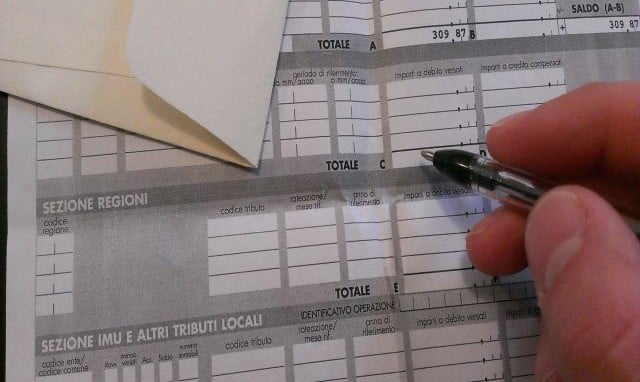di Marco Marazza – Professore di diritto del lavoro all’Università di Teramo
Molto stimolante lo scambio di opinioni sul modello contrattuale tra Carlo Dell’Aringa e Giudo Baglioni. Il primo lancia l’idea dell’assorbimento, secondo la quale gli aumenti retributivi concordati a livello nazionale dovrebbero essere assorbiti dagli eventuali aumenti salariali disposti dalla contrattazione in sede aziendale. Il contratto nazionale prevede un aumento di 100 che entra nelle buste paga di tutti coloro che non hanno contratto di secondo livello. Se in un’azienda il lavoratore percepisce 30 in virtù di un contratto aziendale allora in questo caso il dipendente avrà diritto, con il rinnovo del ccnl, solo ad una maggiore retribuzione di 70. Replica Guido Baglioni che in questo modo si finisce per perdere la fondamentale differenza che deve caratterizzare il primo livello di contrattazione (che deve fissare i minimi salariali) dal secondo (cui invece compete la definizione della parte variabile della retribuzione).
Entrambi, pur tuttavia, danno atto dell’amara realtà. La contrattazione di secondo livello, contrariamente a quanto già previsto dal protocollo del 1993, solo raramente introduce una componente retributiva variabile effettivamente legata alla produttività. Per la tendenza egualitarista dei sindacati a negoziare anche a livello aziendale una parte fissa, anziché variabile, della retribuzione. Per la contrarietà delle imprese ad un sistema di contrattazione destinato a sommare voci retributive fisse di scarso impatto sulla produttività. Pertanto Dell’Arringa propone il raffinato meccanismo dell’assorbimento (che comunque sembra capace di stimolare la contrattazione aziendale). Mentre Baglioni, non rassegnandosi, invita le parti sociali a fare il loro dovere.
Il principale ostacolo non ideologico alla contrattazione di secondo livello è la scarsa presenza sindacale nelle piccole e medie imprese ed il conseguente timore di lasciare molti lavoratori con la sola rete di protezione di un contratto nazionale assai più snello e leggero di quello attuale. Timore in un certo senso ridimensionato dalla proposta di Dell’Aringa, giacché l’aumento del contratto nazionale verrebbe comunque riconosciuto – per l’intero – a tutti coloro che non hanno contrattazione di secondo livello. Ma comunque superabile, anche nella prospettiva di Baglioni (e del protocollo del 1993), con l’attivazione di una seria contrattazione collettiva di livello territoriale. Proprio in questa direzione, ad esempio, il contratto territoriale del distretto del legno di Pordenone ha introdotto un efficace sistema di retribuzione variabile rappresentando un chiaro esempio delle potenzialità di questo trascurato livello di negoziazione. Ma parimenti significativa può essere considerata l’esperienza della contrattazione territoriale nel settore agricolo.
In verità, si può anche ipotizzare una via di mezzo che salvaguardi, da un lato, l’interesse sindacale a tutelare i lavoratori privi di contrattazione di secondo livello e, dall’altro, l’interesse delle imprese ad incrementare la parte variabile delle retribuzione. Basterebbe mettere da parte il dogma – sindacale e non tecnico giuridico – dell’inderogabilità del contratto nazionale. Consentendo alle articolazioni territoriali od aziendali dei sindacati firmatari del contratto nazionale di disporre di una quota predeterminata del salario minimo negoziato al livello nazionale. Ovviamente per trasformarla in retribuzione variabile.
Del resto, dottrina e giurisprudenza già da tempo sostengono che un eventuale contrasto tra contratti collettivi di diverso livello deve essere risolto non in applicazione di un inesistente principio gerarchico. Bensì secondo il criterio della specificità, in applicazione del quale il contratto aziendale o territoriale può prevalere su quello nazionale in quanto più vicino agli interessi da regolare.
Ipotizziamo, ad esempio, che il contratto nazionale venga rinnovato con un aumento di 100 euro in busta paga e che tale somma sia, per esplicita pattuizione, nella disponibilità della contrattazione di secondo livello. In sede aziendale, ove le parti intendano scommettere sulla crescita dell’impresa, si potrebbe convenire che la corresponsione dei 100 euro (o di una quota di tale somma) è condizionata ad un determinato incremento, ad esempio, dei margini di produttività (dell’intera impresa e/o di un reparto e/o del singolo lavoratore). Al raggiungimento del risultato concordato la somma dovrà essere significativamente maggiorata nella percentuale prevista dallo stesso accordo aziendale ed il lavoratore, pertanto, avrà un reddito certamente superiore a quello che gli deriverebbe dalla applicazione del solo contratto nazionale.
In questo modo, è vero che la quota disponibile del salario definito a livello nazionale non è più certa e dipende dal raggiungimento dei risultati concordati dalle articolazioni sindacali territoriali o aziendali. L’atteso incremento di produttività produrrebbe pur tuttavia per il lavoratore un reddito superiore. Chi non ha contrattazione di secondo livello applicherebbe comunque i nuovi minimi definiti dal contratto nazionale ed analogo sarebbe il risultato per il caso in cui a livello aziendale le parti non riescano a trovare un accordo. Il meccanismo avrebbe un ulteriore pregio: quello di far finalmente decollare anche la contrattazione territoriale. Su impulso delle piccole aziende e delle rispettive associazioni datoriali, certamente interessate a trasformare una parte del salario fisso in variabile.
La finanza pubblica potrebbe ulteriormente incoraggiare il meccanismo con un intervento mirato sul cuneo fiscale da destinare – in misura certamente più consistente ed efficace di quanto previsto nella Finanziaria per il 2008 – alla sola parte retributiva resa variabile dalla contrattazione di secondo livello. Premiando la trasformazione del salario da fisso in variabile in piena coerenza con gli ulteriori interventi funzionali al recupero di competitività del sistema economico.
La derogabilità del contratto nazionale ad opera della contrattazione di secondo livello potrebbe inoltre consentire un recupero di produttività anche sotto diversi profili. Ad esempio, consentirebbe al contratto aziendale di disciplinare alcuni aspetti essenziali del rapporto di lavoro in deroga al contratto nazionale (orario, permessi, malattia, preavviso, ecc.). Ond’è che anche il complessivo livello di protezione del lavoratore potrebbe variare in modo proporzionale all’andamento dell’impresa e, comunque, l’intera disciplina del rapporto di lavoro potrebbe più agevolmente essere adeguata, con il consenso dei sindacati presenti in azienda e nel rispetto di una cornice minima di regole inderogabili, agli interessi concreti del lavoratore e del datore di lavoro.
Da non sottovalutare, infine, è anche la possibilità di rivalutare il ruolo della contrattazione individuale diretta tra lavoratore e datore di lavoro. Non per tutti, ovviamente. Ma per le professionalità più elevate (e non solo per quadri e dirigenti) che la contrattazione collettiva stessa riterrà di indicare. In mancanza di una contrattazione di secondo livello il contratto nazionale di lavoro potrebbe infatti affidare alla contrattazione diretta tra datore di lavoro e singolo lavoratore la definizione della parte variabile della retribuzione anche autorizzando, nei limiti e con le modalità inderogabilmente concordate dalle parti sociali (dunque anche nel pieno rispetto dell’art. 2113 cod. Civ.), la disponibilità di una quota del salario contrattuale minimo.
Il lavoratore potrebbe così scegliere tra due alternative. Essere retribuito con il minimo salariale definito dalle parti sociali per tutta la categoria oppure trasformando una quota di quella retribuzione in un compenso variabile legato ad un criterio di produttività (questa volta individuale) da lui stesso concordato con il datore di lavoro. Al fine di guidare l’esercizio della contrattazione individuale il contratto nazionale, mancando una contrattazione di secondo livello (sia essa aziendale o territoriale), dovrebbe prevedere:
a) la possibilità di disporre tramite accordo individuale di una percentuale della retribuzione predeterminata dal contratto nazionale (ad esempio, max 10%, 15%, 20%, 25%);
b) sempre tramite l’accordo individuale la quota di retribuzione disponibile viene sostituita da un valore economico che compensa l’unità di risultato prodotto dal lavoratore (prodotta secondo caratteristiche e tempi predeterminati nello stesso accordo individuale). Si può trattare di una singola unità di risultato (risultato x = 100% quota di retribuzione disponibile) o anche di una pluralità di risultati destinati a ripetersi nel tempo (risultato x = frazione della quota di retribuzione disponibile);
c) al raggiungimento del risultato il lavoratore matura il diritto alla quota disponibile di retribuzione maggiorata in applicazione di un coefficiente il cui valore minimo è definito inderogabilmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
d) in questo modo al raggiungimento del risultato il lavoratore non solo percepirà l’intera quota di retribuzione disponibile ma anche la maggiorazione preventivamente determinata dal contratto collettivo;
e) il lavoratore può recedere dall’accordo ed in mancanza di una regolamentazione collettiva di secondo livello in questo caso troverà nuovamente applicazione il modello retributivo tradizionale. Ciò fino alla eventuale definizione di un nuovo accordo individuale.
Lo scambio potrebbe essere ancora più interessante ove il sistema retributivo alternativo si inserisse in un rapporto di lavoro nel quale il dipendente non è più tenuto al rispetto di un vincolo orario ma può decidere autonomamente la quantità di prestazione da offrire (ovviamente nel rispetto dell’orario massimo fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva). Rendendo così pienamente coerente con la struttura della prestazione il fatto che la retribuzione non sia più riferita all’unità di tempo bensì all’unità di prodotto. In questo caso andrebbe apportato un solo correttivo. Il contratto collettivo dovrebbe infatti quantificare la retribuzione oraria (e non più mensile) e la disponibilità dovrebbe essere riferita ad una sua quota.