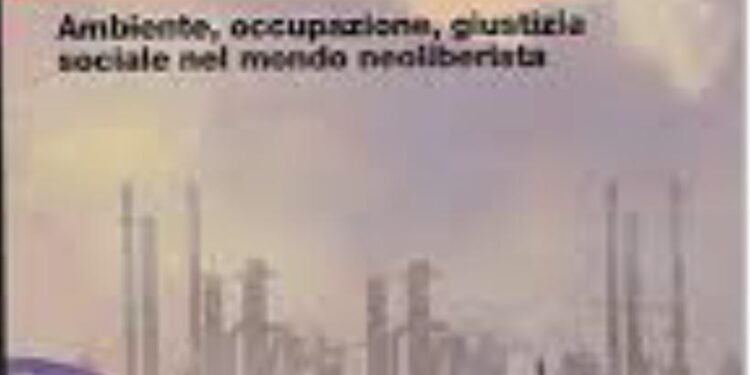“L’estate sta finendo”, cantavano con grande successo i Righeira, esattamente quaranta anni fa, in una canzone dal ritornello orecchiabile, passata alla storia. Una canzone che ci parla, se la ascoltiamo più attentamente, anche dell’inesorabile tempo che passa, dell’angoscia del dover crescere. Di un altro tipo di crescita, questa volta non umana, ma economica, ci parla un prezioso libro uscito nel 2000: Processo alla crescita. Un testo che andrebbe letto e riletto, mettendo da parte ogni preconcetto, ogni idea precostituita, magari ben utilizzando i recenti ricordi della scorsa estate. Venticinque anni fa l’ambientalista Carla Ravaioli e il sindacalista Bruno Trentin davano appunto alle stampe, per Editori Riuniti, i frutti del loro dialogo, assolutamente ancora fresco e attuale su: “ambiente, occupazione, giustizia sociale nel mondo neoliberista.”
Una riflessione, peraltro, davvero ancora molto interessante e utile per una sinistra in crisi di identità, progetto e visione, allora come oggi. Scriveva, sempre nel 2000, Giorgio Nebbia, commentando il libro: “Una società e una economia “funzionano” (dovrebbero funzionare) col fine di soddisfare bisogni umani: bisogni di abitazione, di cibo e acqua, di respirare aria pulita, di salute e conoscenza, di comunicazione delle proprie conoscenze ad altri; bisogni di libertà e dignità. Per quanto se ne dica, per soddisfare tutti questi bisogni occorrono degli oggetti materiali che possono essere ottenuti soltanto trasformando dei beni naturali – aria, acqua, vegetali, animali, rocce, pietre, minerali, fossili estratti dal sottosuolo – in cose utili mediante il lavoro e mediante strumenti che, da quando è nata la proprietà privata, diecimila anni fa, possono solo essere comprati o venduti in cambio di denaro”.
L’ex senatore, uno dei padri nobili dell’ambientalismo italiano, continuava: “Chi investe il proprio denaro nella produzione di merci deve essere premiato con altro denaro anche perché è un benefattore: permette ai lavoratori di acquistare più merci che fanno aumentare la produzione e il denaro in circolazione, eccetera. Il progresso non si misura forse con la “crescita” del denaro in circolazione, così bene interpretata dal prodotto interno lordo di un paese?”. Aveva proprio ragione Nebbia, nel recensire il volume, a dire che ci volevano dei malinconici brontoloni a spiegare, alla luce dell’”ecologia”, che “il di più” – più merci, più denaro – la crescita, insomma, si scontra con limiti inviolabili, quelli della capacità della natura di fornire nuove materie prime e quelli della capacità dell’aria, delle acque, del suolo, di accettare, sopportare, la crescente massa di scorie e rifiuti che inevitabilmente accompagnano la crescita delle merci e del denaro.
Si tratta di un dibattito nato con il sorgere degli anni Settanta del Novecento, ricordate il celebre rapporto: “I limiti dello sviluppo?” Da oltre cinquant’anni si trascina quindi un dibattito fra alcuni che, anche nella sinistra, osservano che la crescita, delle merci e del denaro, in qualche momento deve rallentare (o fermarsi ?); e altri, la maggioranza – i governi ormai di tutto il mondo, oggi capitanati da Donald Trump, gli imprenditori e, spesso, anche i lavoratori – che sostengono invece che, per soddisfare i crescenti e sempre più raffinati bisogni umani, nel Nord e nel Sud del mondo, occorre far crescere il denaro in circolazione, unico agente capace di consentire l’occupazione e la produzione.
Carla Ravaioli, scomparsa nel 2014, è stata per molti anni senatrice della Sinistra indipendente, saggista, una delle voci più attente, a sinistra, ai rapporti fra esseri umani, natura, lavoro e società. Fu autrice di una celebre serie dei “colloqui” con Alberto Moravia sulle donne, con Claudio Napoleoni sul lavoro e con numerosi economisti internazionali. Quest’ultima raccolta di interviste, intitolata: “Il pianeta degli economisti”, è stata tradotta in inglese ed è tuttora citatissima.
Nel libro Processo alla crescita, il dialogo di Ravioli è con Bruno Trentin. Nel 2000 Trentin, poi scomparso tragicamente nel 2007 per i postumi di un incidente in bicicletta avvenuto in Alto Adige, era già un monumento del sindacato e della sinistra. Un ex giovanissimo protagonista della Resistenza sulle orme del padre Silvio, autore di quello slogan: “Liberare e Federare”, che ha accompagnato un certo tipo di incontro tra il federalismo europeo e un pensiero che potremmo definire, con qualche arditezza, quasi gramsciano. Trentin, ex leader della Fiom e della Cgil, protagonista di decenni di lotte ed azioni, molte gloriose, alcune più ordinarie, del sindacalismo italiano. Colui che, nel 1991, al congresso di Rimini, aveva sciolto le storiche componenti della Cgil ed aveva lanciato il complesso percorso del: “sindacato dei diritti” nell’età della conoscenza. Nel colloquio con Bruno Trentin Ravaioli discute, “da sinistra”, la presunta inevitabilità della “crescita” che lo stesso Trentin fa coincidere con il concetto di “sviluppo” umano. Scrive ancora sul libro Giorgio Nebbia e non lo potrebbe fare meglio: “Dal colloquio emergono tutte le contraddizioni fra crescita e “natura”: i limiti fisici della natura possono essere superati governando lo sviluppo, la sua qualità, rendendolo “sostenibile”, come è di moda dire adesso. Ma la “sostenibilità” non sarà una nuova parola magica per evitare di mettere in discussione la “crescita” merceologica e non sarà destinata anche lei a scontrarsi con i limiti fisici della natura?”. Già, l’illusione della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile, fatta propria, spesso, troppo spesso anche dal sindacato, a livello italiano, europeo e mondiale.
L’altro punto importante del colloquio tra Ravioli e Trentin, davvero attualismo (ahimè!) riguarda la democrazia: è possibile evitare o rallentare lo sfruttamento delle risorse naturali e dell’ambiente senza ricorrere a tentazioni autoritarie, “reazionarie”, “di destra”, senza condannare le classi povere e i paesi poveri a restare con la propria miseria, nel nome della salvaguardia di valori che sono tali per (o che sono percepiti come tali soltanto dalle) classi agiate? Può una sinistra “moderna” chiedere “oggi” ai lavoratori di accettare minori salari, meno automobili, di consumare meno benzina, per salvare i boschi o lo strato di ozono, perché la distruzione delle foreste e dello strato di ozono, imposta dalla crescita del capitale internazionale, è destinata a provocare “domani” ricadute negative più gravi proprio sulle classi povere e sui paesi poveri? Rispondeva un altro grande sindacalista, questa volta fimmino e cislino, Pierre Carniti, nel 2009 (in piena crisi economica, peraltro) alla domanda: “lei cosa pensa della decrescita?” “Io sono abbastanza cresciuto, non posso essere il primo fan della decrescita. Però rimango molto perplesso dalla produzione “infinita”, ad esempio, di elettrodomestici e automobili, che poi non sappiamo più dove mettere e che magari murano le nostre case e le nostre strade, imprigionandoci…”
Dal colloquio Ravaioli-Trentin emergono anche le linee per alcune proposte politiche e, potremmo dire “pedagogiche”, anche queste in gran parte attuali: uno scrutinio della qualità delle merci e delle materie prime, alla luce dei vincoli ambientali; una nuova cultura nei bisogni e nei consumi individuali; una educazione critica verso le merci oscene come le armi (velleità, peraltro oggi, direbbe De Andrè, assolutamente collocata in: “direzione ostinata e contraria”); un intervento pubblico verso la standardizzazione delle merci perché durino di più, siano più facilmente riciclabili alla fine della loro vita utile; lo sviluppo di tecniche e processi che, invece di moltiplicare merci e bisogni futili, aiutino i paesi poveri ad attenuare la loro cronica mancanza di cibo, salute, acqua potabile, abitazioni decenti, energia, istruzione, libertà.
Tutto questo – concludeva venticinque anni fa la sua recensione al libro Giorgio Nebbia – “non risolve il problema di fondo: non frena la crescita, non allarga i limiti delle risorse naturali, ma almeno richiede innovazione, crea occupazione, alleggerisce la pressione migratoria – e può anche mettere in discussione i dogmi della competitività, dello sfruttamento, del capitalismo, cioè delle condizioni intrinsecamente incompatibili con le leggi della natura”. Concludeva l’ambientalista: Troveremo una sinistra, e aggiungo io un sindacato – capaci di affrontare una tale sfida? Dopo venticinque anni, l’urgenza è ancora più forte, pressante. Il mondo sembra si stia girando tutto da un’altra parte, rispetto al dialogo Ravaioli Trentin. Entrambi (come Nebbia) non ci sono più. Ma noi ci siamo e, come direbbe, un altro profeta della “conversione ecologica”, Alexander Langer: “dobbiamo continuare in ciò che era – è e assolutamente sarà – giusto. Senza ideologie preconcette, ma con una visione ostinata e condivisa. Coltivando il seme del dubbio, ma non facendoci imprigionare nei convegni dove si fa bella figura e si sciorinano dotte citazioni. Non solo l’estate sta finendo, ma il mondo, almeno come lo hanno conosciuto le ultime generazioni, sta finendo. Il tempo di agire, di una rinnovata battaglia politica, economica, culturale, antropologica: è adesso!
Francesco Lauria