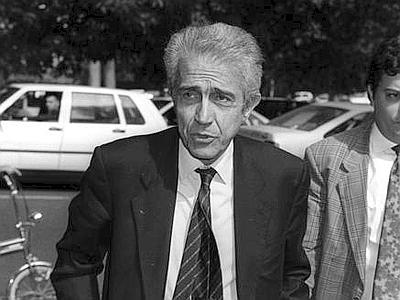di Roberto Voza
I generi letterari sono, evidentemente, una convenzione del pensiero umano. Sono etichette utili a identificare e a raggruppare opere letterarie aventi caratteristiche comuni, secondo criteri classificatori accettabili fino a quando siano utili a una migliore comprensione critica dei testi. Insomma, «i generi sono essenzialmente istituzioni letterarie, o contratti sociali fra uno scrittore e un pubblico specifico, e la loro funzione è quella di specificare l’uso appropriato di un particolare artefatto culturale»[1].
Il libro di Giovanni Pino Uno studio su Gino Giugni e il conflitto collettivo non è facilmente collocabile in uno specifico genere tra quelli propri della letteratura giuridica. Innanzitutto, non è esattamente una biografia (di Gino Giugni, per intenderci), come lo stesso Pino annuncia in premessa[2], né è una recensione di opere del compianto Maestro. Non è un manuale istituzionale, ma non è neppure – in tutto e per tutto – un lavoro monografico.
A me pare che l’opera abbia in sé caratteristiche comuni a una pluralità di generi ed è proprio questa contaminazione a renderla, a mio avviso, utile ed interessante.
Certamente, essa contiene stringati ma accurati riferimenti biografici, funzionali a comprendere le radici e i percorsi del pensiero di Giugni, attraverso le principali esperienze culturali che ne hanno segnato la formazione di studioso, come pure attraverso le sue più significative esperienze all’interno delle istituzioni.
Non si può dire poi che l’opera non abbia un taglio divulgativo, proteso a illustrare il tema che ne forma oggetto, senza darne per scontato i fondamenti concettuali di base. In questo senso, si presenta come un valido supporto didattico alla trattazione del conflitto collettivo, di cui non manca di spiegare le varie articolazioni, in modo sintetico ma apprezzabilmente completo. Insomma, essa potrebbe efficacemente fungere da quella che, nel lessico della didattica accademica, si è sempre chiamata Parte speciale di un corso istituzionale (nel nostro caso, si tratterebbe di quello di Diritto sindacale o di Relazioni Industriali).
E poi il libro di Pino è anche un attento studio sul conflitto collettivo, in cui egli non manca di prendere qualche (argomentata) posizione su questioni cruciali e ‘calde’, come quella della titolarità del diritto di sciopero, rispetto alla quale l’Autore rintraccia una “sottile contraddizione” (p. 109) nello stesso pensiero di Giugni. Infatti, Pino è convinto che “proprio nell’ordinamento intersindacale – per la valorizzazione delle prerogative riconosciute al soggetto sindacale – si possa già ritrovare un rilevante contributo al superamento della concezione dello sciopero come diritto a titolarità individuale” (p. 112).
Occorre rinviare al testo per ogni approfondimento in merito a questo interessante dibattito (e agli altri profili del conflitto trattati dall’autore): un dibattito, peraltro, quanto mai attuale, alla luce dell’impatto che il tema della titolarità del diritto di sciopero produce sulla valenza/efficacia delle clausole di tregua e di pace sindacale (tasselli essenziali dei recenti sviluppi delle relazioni sindacali in Italia). Non a caso, alla tesi della titolarità individuale Pino attribuisce la responsabilità di aver relegato “tutta la potenzialità” di tali clausole nei “misteriosi meandri del contratto collettivo” (p. 114).
Con l’auspicio che il libro di Giovanni Pino abbia ampia diffusione, concludo questo mio breve contributo, il quale (a proposito di generi letterari) non intende essere né una recensione, né una scheda bibliografica, bensì un semplice invito alla lettura.
Roberto Voza
____________________________
[1] F. Jameson, Narrazioni magiche. Sull’uso dialettico della critica di genere, in Id., L’inconscio politico. Il testo narrativo come atto socialmente simbolico, Garzanti, Milano, 1990.
[2] Ove l’Autore presenta l’opera come uno “studio sul contratto collettivo, condotto avendo come riferimento costante quel grande patrimonio che è l’elaborazione teorica di Giugni” (p. XI).