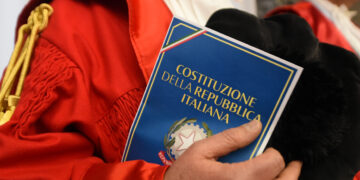Uno dei punti fermi delle analisi sulla crisi che attanaglia soprattutto le economie europee occidentali è dato dalla convinzione che una delle leve per uscirne è l’instaurazione di adeguate ed efficienti relazioni industriali. Affermazione giusta in linea generale perché le relazioni industriali, effettivamente, sono considerate unanimemente come uno dei fattori determinanti della produttività marginale del lavoro.
Ebbene, in quale condizione versano le relazioni industriali? Benché si tratti di un sistema refrattario a essere inquadrato in un comune ambito europeo-occidentale perché ancora troppo marcate sono le tradizioni nazionali nelle quali queste relazioni si sono sistematizzate, si può intravedere abbastanza nitidamente, ormai, una tendenza comune che caratterizza i diversi sistemi nazionali di relazioni industriali. È un fenomeno che definiamo “aziendalizzazione” perché il sistema di produzione normativo sui rapporti di lavoro rinnova il suo ambito prevalentemente entro il perimetro della singola Impresa (o, al più, del singolo territorio nel quale le diverse imprese si raccordano organizzativamente).
L’aziendalizzazione delle relazioni industriali, tipica della tradizione anglosassone, caratterizza ormai sempre più diffusamente l’assetto tedesco, francese e –sotto la recente pressione delle istituzioni sovranazionali – spagnolo, greco, italiano. Siamo di fronte a un movimento teso a spostare il baricentro del sistema delle fonti regolative dei rapporti di lavoro dal livello settoriale (generalmente, nazionale) al livello decentrato, cioè territoriale o – più incisivamente – al livello aziendale. Questo assetto dello sviluppo capitalistico, che Wolfgang Streeck ha definito «coordinamento disorganizzato», è basato sulla centralità dell’Impresa, intesa come istituzione della globalizzazione, cioè il Soggetto dell’ordinamento globale. Il Soggetto che si autoregolamenta come micro-cosmo ordinamentale, produttore di norme (perciò, auto-nomo) necessarie al ruolo di attore economico globale.
L’aziendalizzazione, così intesa, connota anche l’evoluzione del sistema di relazioni industriali italiane, seppur la morfologia economico-produttiva dell’Italia sia caratterizzata da una prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni. Indice di questa tendenza non è solo la ben nota vertenza Fiat (che comunque ha un forte valore simbolico) ma anche i sempre più numerosi accordi aziendali in deroga, oggi stipulati sulla scorta potente dell’art. 8 della legge n. 148/2011.
A ciò aggiungiamo che s’inizia a formare una prassi di disdette dei contratti nazionali venuti a scadenza, anche se presidiati da clausole di ultrattività, per poi adottare regolamenti aziendali unilaterali; prassi che – nella migliore delle ipotesi – ha la funzione di far pressione sulle organizzazioni sindacali affinché accettino rinnovi contrattuali nazionali dai contenuti peggiorativi rispetto ai precedenti.
D’altronde, l’aziendalizzazione è l’approdo di una tendenza al decentramento della regolazione generale e universale realizzatosi nelle centinaia di contratti nazionali di settore; frammentazione contrattuale che, a ben vedere, testimonia la frammentazione della rappresentanza sindacale dei lavoratori e – prima di tutto – della rappresentanza associativa delle imprese. L’aziendalizzazione – a tal proposito – si manifesta anche come delegittimazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese: in fin dei conti, la vertenza Fiat è emblematica anche per l’uscita del Gruppo torinese da Confindustria.
Insomma, il decentramento normativo di cui è espressione l’aziendalizzazione, non consiste soltanto del restringimento del perimetro della regolazione normativa al livello di singola azienda, ma anche in una trasformazione del sistema di governo delle relazioni industriali. Uno dei caratteri dominanti di questa trasformazione è la frammentazione (o il superamento) della mediazione rappresentativa degli interessi a favore di una rinnovata centralità della rappresentanza degli interessi al livello di ciascuna Impresa.
Appare evidente che se è questo l’ambito prevalente dell’ordinamento intersindacale, occorre promuovere e sostenere i soggetti che danno vita ad un efficiente e democratico sistema di relazioni industriali di livello aziendale. Come non vedere, allora, che la prima e maggiore debolezza del sistema italiano è l’ostinata riluttanza all’intervento legislativo sulla rappresentanza sindacale? Una rappresentanza imperniata su una scarna norma dello Statuto dei lavoratori (l’art. 19), peraltro brutalmente manipolata nel corso degli anni e, oggi, sub iudice, essendo stata rimessa (ancora) al giudizio della Corte costituzionale.
Oggi, è oggettivamente ozioso (quando non tendenzioso) continuare ad affermare che la regolazione delle relazioni industriali compete solo alle parti sociali e non alla legge, tanto più oggi che sono costantemente esposte alla legge dei Giudici, nelle aule dei tribunali.
Quanto più si decentra il sistema regolativo, tanto più occorre che le regole generali e universali siano, appunto, certe e inderogabili; per tutti: sindacati e imprese, a cominciare dalle regole sui soggetti delle relazioni industriali aziendalizzate.
Ciò non esclude che le parti sociali possano avere un ruolo centrale nell’agenda legislativa di una legge su democrazia e rappresentanza sindacale; ma ci permettiamo di rimarcare che una delle prime questioni dell’agenda legislativa sulla crisi, se è vero quanto detto finora, è una legge sul Governo democratico delle relazioni industriali aziendali attraverso una legge sulla democrazia sindacale, non fosse altro perché nell’età dell’aziendalizzazione è una questione di efficienza di sistema.
di Vincenzo Bavaro – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”