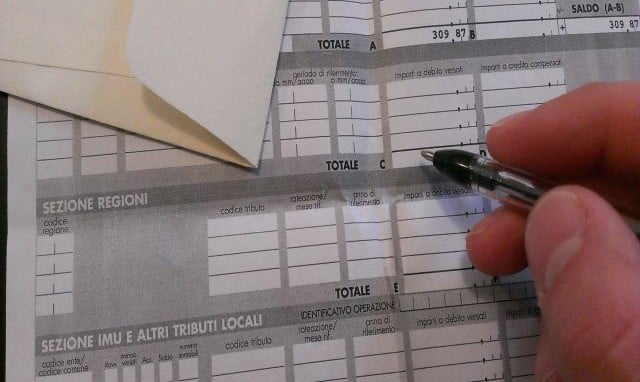Ida Regalia – Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare, Università degli Studi di Milano
1. Recenti prese di posizione in campagna elettorale da parte di economisti e politici sulla opportunità di abolire lo Statuto dei lavoratori, eventualmente sostituendolo con un moderno sistema di ammortizzatori sociali (vedi Meneghelli, Il diario del Lavoro, 10 marzo 2008), forniscono un’occasione per qualche breve considerazione sul ruolo attuale di questa legge fondamentale del diritto del lavoro. Evidentemente, dal momento che chi scrive non è giurista, queste brevi considerazioni non intendono avventurarsi sul terreno dei limiti o dei problemi aperti della legge sul piano giuridico e di politica del diritto (1). Riguardano piuttosto spazio e significato di questa legge, che sta ormai per sfiorare i quarant’anni, da un punto di vista delle relazioni industriali.
In questa prospettiva, occorre iniziare con un cenno alle due diverse “anime”, che, com’è apparso evidente fin dall’inizio, caratterizzano in modo nel complesso equilibrato la legge n. 300 del 1970, nota appunto come “Statuto dei lavoratori”, poiché entrambe sono state di grandissima rilevanza per lo sviluppo delle relazioni industriali, in particolare nel settore privato dell’economia, suo ambito originario di applicazione. Lo è stata l’anima cosiddetta “costituzionale”, volta a garantire direttamente ai lavoratori nei rapporti di lavoro i principi costituzionali di uguaglianza, libertà e dignità, così introducendo nei luoghi di lavoro i diritti di cittadinanza. E lo è stata quella cosiddetta “promozionale”, volta a incentivare, sostenere e rendere effettiva, in un quadro di confronto pluralistico, la libertà d’azione sindacale quale via maestra per attuare efficacemente la tutela dei lavoratori.
La prima linea d’azione è volta dunque a porre dei limiti, obiettivi e validi per tutti, coerenti con i diritti individuali di cittadinanza stabiliti dalla Costituzione, alla regolazione automatica del mercato combinata all’esercizio dell’autorità da parte dell’impresa nella determinazione dei rapporti di lavoro. Per comprenderne l’importanza si dovrebbe riandare a come erano le condizioni di lavoro e i rapporti di lavoro in precedenza, come testimoniato dalle inchieste parlamentari, dagli studi sociologici sulla condizione operaia, dalla narrativa di denuncia della letteratura industriale e naturalmente dai documenti e dalle rivendicazioni sindacali degli anni Cinquanta e Sessanta. Nonostante i moltissimi problemi aperti, in parte nuovi, di cui diremo tra breve, a distanza di tempo si può dire che oggi molto è cambiato nei luoghi di lavoro per effetto, direttamente o indirettamente, della legge. Se leggiamo ad esempio Era il secolo del lavoro di Aris Accornero, o Il tubo di cristallo (sulla Fiat) di Giuseppe Bonazzi, ne possiamo ricavare molti indizi che danno una misura del cambiamento.
La seconda linea d’azione, proponendosi di promuovere la libertà sindacale e l’attività sindacale, e fornendo degli strumenti per una stabilizzazione dei rapporti con i rappresentati e il consolidamento organizzativo, è volta invece a rendere più agevole e fluida l’azione di tutela attraverso la rappresentanza. E quindi a incentivare, pur non regolandoli direttamente, lo sviluppo di forme di democrazia e coinvolgimento dei lavoratori nella formazione delle decisioni che li riguardano e l’estensione del metodo della negoziazione nella soluzione delle controversie e regolazione con le controparti delle condizioni d’impiego dei lavoratori. L’importanza sta in questo caso nella possibilità di superare le tendenze, tipiche di contesti caratterizzati da astensionismo legislativo e assenza quindi di vincoli certi, a far principalmente affidamento sui rapporti di forza e su un uso abnorme, quando possibile, del conflitto, sia per verificare e riaffermare il seguito presso i rappresentati sia per entrare in relazione con le controparti. E i risultati sono poi progressivamente emersi nel tempo, in termini di migliore e più esteso rapporto con i rappresentati (e non solo con gli iscritti o i militanti) da parte delle organizzazioni sindacali, in termini di utilizzo più “libero”, e alla lunga quindi più “responsabile”, del conflitto organizzato, e in termini di sviluppo più esteso e ordinato della logica della regolazione congiunta e della logica partecipativa, per affrontare in modo più costruttivo i problemi che hanno via via interessato il mondo del lavoro e il sistema delle imprese nel tormentato periodo di profonde trasformazioni che ha inizio proprio dalla metà degli anni Settanta.
2. Lo Statuto dunque come fattore di emancipazione individuale, e quindi più in generale di civiltà nelle relazioni intersoggettive, quale prerequisito per relazioni di lavoro mature e libere. E lo Statuto come fonte di garanzie per l’organizzazione sindacale, quale prerequisito per relazioni industriali stabili basate sull’autonomia collettiva a vantaggio di entrambe le parti, e quindi più in generale come fattore indiretto di benessere sociale ed economico.
Non stupisce tuttavia che, nel lungo arco di tempo che è passato dal varo della legge, diverse delle specifiche circostanze in base alle quali l’insieme delle tutele e delle garanzie era stato strutturato e reso operativo siano tanto o poco cambiate, e che nuove esigenze di tutela o nuovi problemi di salvaguardia siano emersi.
Si è venuta trasformando, infatti, la struttura del sistema produttivo ed è stata fortemente ridimensionata la centralità della grande impresa; è molto aumentata la richiesta di forme di flessibilità interna nell’utilizzo del lavoro (flessibilità temporale, flessibilità funzionale) specie da parte delle imprese più dinamiche e tecnologicamente all’avanguardia; mentre la forte crescita del terziario – oltre che di aree meno dinamiche dell’economia – ha favorito una domanda di contratti e forme di impiego più fluidi (quando non irregolari), dalle prospettive incerte e non adeguatamente tutelati. Lo sviluppo e l’evoluzione, spesso problematici, del settore pubblico – pubblica amministrazione e servizi pubblici – hanno condotto a una riforma radicale dei modi di regolare il rapporto di lavoro in quest’area dell’economia, “privatizzandolo” e “contrattualizzandolo”, e riconducendolo quindi, non senza problemi, entro l’ambito di applicazione dello Statuto. Il massiccio ingresso nel mercato del lavoro dell’occupazione femminile, e, più di recente, di un flusso in crescita di lavoratori stranieri, specie provenienti dai paesi del Sud del mondo, ha evidenziato nuove domande di tutela e protezione dai rischi solo in parte coperte dalla legislazione recente. Anche l’evoluzione del sindacalismo, di cui si sono accentuate le tendenze alla differenziazione, talvolta alla frammentazione, e, specie in alcuni periodi, le difficoltà all’azione unitaria, ha messo in evidenza problemi di individuazione dei criteri di rappresentatività delle organizzazioni, oltre che di forse eccessiva prudenza nelle norme sulle rappresentanze sindacali in azienda.
Su diversi aspetti sono del resto intervenuti provvedimenti legislativi successivi, che hanno via via modificato, o sostituito, o abrogato specifici punti critici, contribuendo a un aggiornamento della normativa. Ma senza dubbio ve ne sono altri che si potrebbero ritoccare, rendendoli più adatti e più efficaci nel mutato contesto tecnologico e organizzativo delle imprese; e ve ne sono altri che occorrerebbe aggiungere.
Tra gli aspetti che si potrebbero ritoccare, e nel campo della tutela dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà, dignità e diritto al lavoro, si possono citare le norme sui controlli, in particolare quelli a distanza, e quelle sul diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; le norme a tutela e promozione della professionalità, e quelle alla “tutela reale” del posto di lavoro. Mentre nel campo della promozione della libertà d’azione sindacale, insoddisfacenti sono senz’altro le norme sulla costituzione delle rappresentanze in azienda.
Tra le tematiche su cui, infine, sarebbe auspicabile un’aggiunta o un’estensione dell’intervento legislativo, ci sembra vada in particolare considerata quella della tutela e promozione di ogni forma di “diversità” sul lavoro: da quella delle donne a quella dei lavoratori stranieri, a quella dei lavoratori con contratti e modalità lavorative diverse da quelli standard.
3. Queste ultime osservazioni nulla tolgono tuttavia al significato e al valore fondamentale che lo Statuto continua ad avere: e probabilmente oggi più di un tempo. Esse sono osservazioni che potrebbero rivelarsi utili qualora a livello politico ci fosse la possibilità di intraprendere un percorso, certamente impegnativo e difficile, di riforma del quadro istituzionale delle regole delle relazioni industriali con la partecipazione di tutte le parti interessate.
Ma indubbiamente di una legge che stabilisca questo quadro istituzionale, a partire dalla tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori, c’è bisogno. E, pur con alcuni limiti, la legge di cui disponiamo assolve a compiti, come abbiamo detto, di emancipazione individuale, e quindi di promozione di civiltà nelle relazioni intersoggettive, e di sostegno alla libertà d’azione sindacale, e quindi di promozione della dialettica e del confronto nelle relazioni collettive. Il che costituisce il prerequisito di relazioni di lavoro mature e libere, da un lato, e di relazioni industriali stabili basate sull’autonomia collettiva, dall’altro.
E si noti che non si tratta solo di una questione, comunque fondamentale, di civiltà e dignità dei lavoratori, e di libertà collettive di espressione e coalizione. è insieme una questione di miglior funzionamento dell’economia a partire dai vantaggi che derivano da un miglior clima e da una miglior capacità di comporre costruttivamente le controversie nei luoghi di lavoro e al livello centralizzato delle relazioni tra le parti sociali.
La maggior problematicità oggi di un’economia che s’è fatta più diversificata, fluida, in movimento, che necessita di sistemi di relazioni di lavoro decentrati, ma anche di quadri di riferimento centralizzati su alcuni temi, rende particolarmente necessaria l’esistenza di regole chiare e svincolate dagli interessi contingenti degli attori, e quindi di vincoli certi, validi per tutti, come appunto ha luogo attraverso lo Statuto. Questo consente di eliminare dal gioco delle parti e dal campo del contendere le discussioni sui diritti e la libertà dei lavoratori, da un lato, e sui caratteri e le prerogative della rappresentanza sindacale, dall’altro. E, fornendo canali socialmente legittimi per la riduzione della complessità delle pressioni e delle domande e per l’espressione e composizione del dissenso, permette di liberare spazi per individuare e risolvere i problemi e i conflitti che sorgono nel governo della flessibilità e dell’incertezza.
Di per sé nessun moderno sistema di ammortizatori sociali, pur necessario, può sostituirsi alla capacità strutturante di una legge sui diritti.
NOTE
1) In proposito, rimando al bel commento di A. Tursi, Statuto dei lavoratori. In Digesto, IV Edizione, vol. XV Commerciale, Torino, UTET, 1999, di cui mi avvalgo ampiamente.