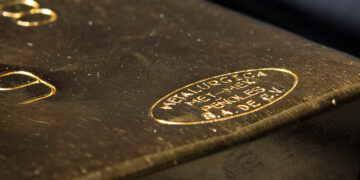La scelta di Sbarra di ricoprire un incarico importante nel governo di centro-destra, seppur come “indipendente”, ha suscitato un vivace dibattito nella Cisl da parte di chi non condivide quella scelta. Non è una questione di autonomia: molti ex segretari generali, al termine del loro mandato, hanno fatto scelte analoghe. Ricordiamo Carniti, eletto nel Parlamento europeo come indipendente nelle liste del Psi, Marini, che passò direttamente al ruolo di ministro del Lavoro per la Dc, D’Antoni, che fondò un partito proprio, senza riuscire a coinvolgere la Cisl, e poi si accasò nel Pd, Pezzotta, che fece un mandato parlamentare nelle fila dell’Udc, Bonanni che lasciò per un’incresciosa vicenda e si è poi sistemato in Azione, Furlan, eletta nelle liste del Pd e poi approdata in Italia Viva. La vera novità non è dunque la scelta di occuparsi di politica, ma di farlo in una formazione di centro-destra: è la prima volta. Si tratta di una scelta personale che non coinvolge la Cisl, ma certamente fa discutere. L’autonomia, tratto caratteristico della Cisl, è a tutto campo (e quindi comprende, anche senza condividerle, scelte di destra) o c’è una linea rossa, che non si può superare, verso la destra? Questa è una prima domanda a cui sono possibili risposte diverse.
Le scelte sono, come detto, personali e vanno rispettate, marcando la differenza con le scelte dell’organizzazione. Nel compierle un ex dirigente dovrebbe tener conto di non suscitare reazioni negative anche solo in una parte dell’organizzazione che fino a poco tempo prima guidava. I valori della Cisl e la sua storia sono contro gli interessi portati avanti dalla destra; ma di quale destra parliamo? La destra fascista o la nuova destra che, faticosamente e con scarsi risultati, sta facendo emergere la Meloni? Questa è una seconda domanda a cui occorre dare una risposta.
Si confrontano ancora, a mio parere, due concezioni differenti del ruolo del sindacato che, pur essendosi nel tempo influenzate a vicenda, riemergono. Una è il sindacato dell’autonomia (di matrice Cisl) e l’altra è il sindacato politico (di matrice Cgil).
Autonomia non è centrismo come suggerirebbero la vicenda di D’Antoni (che addiritura tentò, senza riuscirci, di portare tutta la Cisl a fare quella scelta) o di Pezzotta (che aderì, però solo a titolo individuale, all’Udc). E non è nemmeno “accontentarsi di quel che passa il convento”, come pare stia facendo l’attuale dirigenza nazionale della Cisl. È far riferimento agli interessi economici dei lavoratori, che non hanno un colore partitico.
La concezione politica è largamente maggioritaria sia nel sindacalismo internazionale (valgano gli esempi della Gran Bretagna e del Brasile) e nell’opinione pubblica del nostro paese. Bisogna tenerne conto e non liquidarla a cuor leggero. In base a quell’approccio vengono definite “di destra” le scelte che non coincidono con quelle “di sinistra”, che sono, per definizione quelle della Cgil. Ed è per questo, credo, che l’esperienza della Cisl è stata definita una “splendida anomalia”, in quanto si riferisce a una concezione minoritaria e pressochè ignorata nel panorama mondiale e nazionale, ma non “di destra”, come sembra desiderare (e la si può capire) la Meloni e il suo entourage.
Il riferimento, comune al sindacalismo politico e ai partiti della sinistra, è la rappresentanza degli sfruttati o, per dirla in un linguaggio “cattolico”, degli ultimi. Da qui il fascino della sinistra. Ma è ancora così? Gli ultimi (disoccupati, precari, eccetera) non li rappresenta nessuno, sono una esigua minoranza nel sindacato e si rifugiano nel non voto o nel voto prevalentemente a destra per quanto riguarda i partiti.
Il mandato di rappresentanza è, per il sindacato, più limitato, di quello dei partiti; riguarda gli interessi economici e sociali dei lavoratori. Si misura sulla distanza tra quanto richiesto nelle piattaforme e quanto ottenuto negli accordi. Ed è su questo punto che si misura il “politicismo” della Cgil, guidata da Landini, che sembra non interessarsi dei risultati che la sua azione porta a casa. A mio parere c’è uno spazio tra gli scioperi sfogatoio e l’accontentarsi: è quello degli scioperi proclamati per non aver ottenuto a sufficienza, rispetto a quanto richiesto. E’ su questo punto che esprimo il mio dissenso con le scelte che sta facendo la Cisl che sottolinea i risultati ottenuti che, a mio parere, sono invece insufficienti a dichiararsi soddisfatti, soprattutto in tema di fisco e di sanità.
L’approccio autonomo si è fatto strada anche nella Cgil. Questo sindacato non prende più ordini dai partiti di sinistra; l’ultimo episodio di questo genere fu l’obbedienza di Lama agli eredi di Berlinguer in occasione del referendum sul raffreddamento della scala mobile. La Cgil elegge i suoi dirigenti e approva la sua linea strategica in piena autonomia. Ma nelle sue scelte è ancora affascinata dal comune richiamo alla rappresentanza degli sfruttati, che però neanche lei rappresenta fino in fondo. La Cgil, come la Cisl e la Uil, rappresenta oggi i penultimi, che però sono ormai una minoranza, se facciamo riferimento alla classe operaia.
L’approccio politico, d’altro canto, si è parzialmente affermato nella Cisl, soprattutto nel periodo di Carniti, che teorizzò il far politica in proprio del sindacato, cioè condizionando con la propria azione le priorità della politica.
L’unità sindacale sarà possibile quando le due concezioni vivranno in un’unica organizzazione. Il fondamentale requisito perché ciò avvenga è che chi fa riferimento a una delle due concezioni sia disposto a far prevalere l’altra, se pur provvisoriamente, cioè a restare in minoranza.
È, in fin dei conti, una questione di potere. Meglio essere primi (cioè comandare) in una organizzazione che conta sempre meno che, eventualmente, secondi (cioè essere minoranza) in una organizzazione che tenta di contare qualcosa. Per recuperare il suo fascino il sindacato dovrebbe investire molto di più nell’avere una rappresentanza dei nuovi ultimi. Ma questa è un’altra storia…
Piergiorgio Caprioli