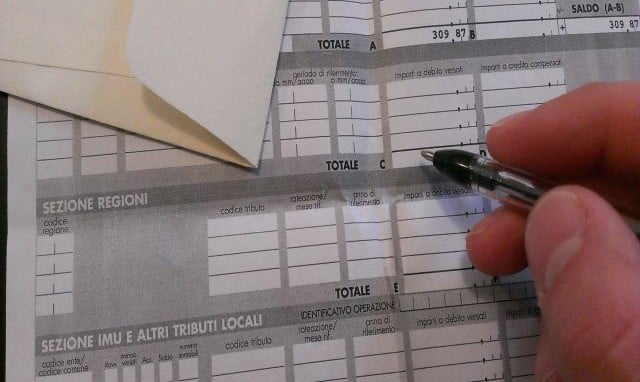di Vincenzo Bavaro – Università di Bari
1. Premessa
La piattaforma rivendicativa presentata nel maggio 2007 da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto collettivo nazionale aveva l’ambizione di mettere in discussione gran parte dell’assetto regolativo dell’organizzazione del lavoro nelle imprese metalmeccaniche. Il gran numero di rivendicazioni avanzate testimoniavano una maturata consapevolezza delle organizzazioni sindacali rispetto alla necessità di rilanciare una ambiziosa politica contrattuale. Questo connotato della piattaforma ha rappresentato, al contempo, la virtù ed il vizio della proposta sindacale perché, a fronte dell’ambizione dei contenuti si collocava il rischio che il concreto sviluppo della trattativa negoziale, data la situazione di contesto, potesse disperdere le energie su numerose questioni. D’altronde, come vedremo, la regolazione di non pochi istituti è stata rinviata ad un momento successivo.
Non ho dubbi sul fatto che le organizzazioni sindacali avessero messo in conto la rinuncia ad alcuni punti rivendicati nella piattaforma, come avviene in ogni trattativa negoziale. Piuttosto, la piattaforma ha rappresentato una base solida per rinnovare la politica contrattuale del sindacato metalmeccanico rispetto agl’ultimo decennio. Nondimeno, da una mera comparazione fra piattaforma contrattuale e ipotesi di accordo del 20 gennaio 2008 emerge che gran parte delle istanze rivendicative ha trovato risposta, sovente con un ridimensionamento. Cercherò di mettere in evidenza, seppur nel limitato spazio di questi appunti, che gran parte della piattaforma ha avuto la sua traduzione normativa benché, in alcuni punti qualificanti, l’accoglimento è stato ridimensionato oppure rinviato a sessioni negoziali prossime venture.
Vi è anche un’altra chiave di lettura che credo debba essere tenuta in considerazione per valutare l’accordo: il contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico dell’industria del 2008 chiude definitivamente la questione (politica e giuridica) della coesistenza di due contratti collettivi (quello del 1999 e quello del 2003, come si ricorderà non sottoscritto dalla Fiom-Cgil). Appare chiaro che il rinnovo contrattuale ha metabolizzato non solo la vicenda politico-sindacale ma anche la questione tecnico-giuridica della efficacia di norme contrattuali sovrapposte e coesistenti ad altre norme contrattuali, senza un ben definito criterio di definizione dell’efficacia giuridica. Benché il problema non sia arrivato in un’aula di Tribunale, oggi, la fonte di diritto contrattuale si è ricomposta; e questo, almeno per chi applica il diritto, è già una buona cosa.
2. Sistema di relazioni sindacali
Tutti e quattro i punti della piattaforma in materia di relazioni sindacali hanno trovato attuazione pressoché integrale nel rinnovo contrattuale. La norma del contratto del 2003 che istituiva l’Ente Bilaterale – rinviandone la costituzione a fasi successive – è stata abrogata a favore di un Organismo bilaterale nazionale, dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle parti ed interlocutore dell’Osservatorio e delle Commissioni paritetiche. A dire il vero sembra la stessa cosa, anche se con un nome diverso. Peraltro, non è ben chiaro quale funzione peculiare debba svolgere questo Organismo: c’è da supporre che lo statuto provvederà a circoscrivere le sue funzioni. Certo è che, oltre alla pubblicazione del “Rapporto sull’industria metalmeccanica” – prima affidato all’Osservatorio – l’Organismo «potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo». Tali compiti saranno definiti da un gruppo di lavoro e – si presume – debba svolgere una funzione di supporto al sistema contrattuale, sia in materia di iniziative formative, di studio e ricerca, e di supporto all’attività delle commissioni paritetiche.
In tal senso, se l’Organismo non assolverà – come sembra – le tipiche funzioni assistenziali degli enti bilaterali costituiti in altri settori, dovrà necessariamente investire il massimo delle energie proprio nella costruzione di una base di conoscenza per definire efficaci iniziative di formazione, per l’analisi su mercato del lavoro, andamento economico-produttivo del settore, condizioni di lavoro (incluse quelle delle donne lavoratrici o dei lavoratori migranti), per l’attivazione di azioni positive autenticamente e finalmente efficaci. Mi sembra che questa sia l’unica prospettiva per evitare che l’Organismo possa ripiegarsi in un funziomento autoreferenziale e burocratizzato. Resta da verificare il rapporto con l’osservatorio paritetico nazionale che, date le sue funzioni, potrebbe essere assorbito dall’Organismo bilaterale.
Diverso è il discorso per gli osservatori paritetici aziendali, rispetto ai quali il nuovo art. 3, Disciplina Generale – Sezione Prima, ha eliminato il limite minimo di 1.000 dipendenti per unità produttiva ai fini della loro costituzione, stabilendo che gli osservatori aziendali potranno essere costituiti in ogni azienda che abbia complessivamente più di 3.000 dipendenti. Analogamente, anche per i diritti di informazione e consultazione aziendale vi sono stati due cambiamenti: si è modificata la soglia minima dimensionale delle imprese in cui vige il diritto dei sindacati all’informazione e consultazione, passando da 200 dipendenti a 50; il sindacato ha ampliato il diritto all’informazione e consultazione anche sulle delocalizzazioni all’estero di segmenti del ciclo produttivo o di nuove attività.
Al livello nazionale, merita di essere segnalata l’istituzione della Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti. È una delle rivendicazioni della piattaforma che si connota per l’attenzione che il sindacato ha voluto prestare ai lavoratori migranti. La Commissione ha il compito, per esempio, di proporre interventi per l’organizzazione delle mense aziendali nel rispetto delle differenze religiose. A ben vedere si tratta di interventi che le imprese dovrebbero aver attivato già in osservanza dei vincoli di legge connessi alla libertà religiosa dei lavoratori. Nondimeno, è un segnale di civiltà giuridica che, finalmente, anche un contratto collettivo importante come quello dei metalmeccanici con una forte presenza di lavoratori migranti possa adattare l’organizzazione aziendale ai diritti inviolabili della persona umana, qual è il diritto alla libertà di religione.
Molto interessante sul piano giuridico – benché ponga delicati problemi di organizzazione giuridica – è la promozione di un regime di ferie «volto a permettere ai singoli lavoratori [migranti] di fruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine». Si tratta, adesso, di sperimentare una attenta ed intelligente applicazione della disciplina giuridica delle ferie e dei tempi di non lavoro nell’interesse di tali lavoratori. Spetterà alla Commissione proporre soluzione che possono essere immaginate tenendo conto dei vincoli giuridici ma anche delle potenzialità della contrattazione collettiva in materia di tempi di lavoro. Sarà l’occasione buona per sperimentare tecniche di regolazione del complessivo assetto normativo in materia di tempi di lavoro secondo un approccio progressivo di flessibilità dei tempi di lavoro nell’interesse dei lavoratori.
Nella stessa prospettiva, questa Commissione potrà avere una funzione di stimolo all’attuazione del rinnovato art. 29, Disciplina Generale – Sezione Terza che obbliga le imprese a favorire la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, anche per attivare presso il Ministero della Pubblica Istruzione la predisposizione di appositi moduli formativi.
3. Tempi di lavoro
La materia dei tempi di lavoro era uno dei capitoli della piattaforma e si dimostra conferma come il capitolo nevralgico dell’organizzazione del lavoro. Com’è noto, la disciplina contrattuale risale al 1999 atteso che nell’accordo separato del 2003 le parti si limitarono ad un laconico rinvio ad una sede negoziale successiva per l’adeguamento della disciplina contrattuale al nuovo contesto legale del d. lgs. n. 66/03. A conti fatti si può dire che la situazione ha subito solo alcuni ritocchi confermando l’art. 5, Disciplina Generale – Sezione Terza. L’orario plurispettimanale è stato in parte modificato in una duplice direzione: da una parte è stata sostanzialmente ampliata la causale di ricorso alla multiperiodalità aggiungendo ai due casi di «stagionalità dei prodotti» e «attività di installazione e montaggio» anche l’ipotesi di «picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi». Il rinnovo non ha sciolto il problema tecnico della rilevanza della contrattazione collettiva. In passato ho avuto occasione di sottolineare che esiste un problema di interpretazione della clausola contrattuale esiste anche in sede giurisprudenziale (Trib. Casale Monferrato, 14 aprile 2006 e, in senso contrario, Corte d’Appello Torino, 21 settembre 2007). La questione riguarda la competenza del contratto collettivo aziendale a consentire oppure no il ricorso a tale modulo orario di organizzazione.
Ebbene, mentre non si è sciolto il dubbio sulla previsione di una «contrattazione aziendale [che] non ha carattere ostativo rispetto alle norme del ccnl», le parti hanno voluto aggirare il problema stabilendo che il mancato accordo al livello aziendale entro dieci giorni dalla comunicazione aziendale alle RSU, può rinviare la questione al livello territoriale. Orbene, non nutro dubbi sul fatto che il livello territoriale di contrattazione potrà quasi sempre addivenire ad un accordo; ciò non toglie che si tratta di un classico caso in cui le parti avrebbero potuto disporre con chiarezza: o il contratto aziendale è condizione necessaria per l’orario plurisettimanale, oppure no. Tertium non datur. Peraltro, poiché la piattaforma poneva una soluzione chiara, è evidente che si tratta di un compromesso che si fonda consapevolmente sull’ambiguità della clausola e, per conseguenza, sulla fiducia nella propensione al negoziato delle parti (territoriali).
Forse a compensazione di tale persistente ambiguità, si è stabilito l’aumento della maggiorazione retributiva in caso di orario plurisettimanale in eccedenza nonché la possibilità di versare nella Banca ore le ore eccedenti non recuperate.
Proprio l’istituto della Banca ore ha ricevuto una piccola ma molto significativa modifica: innanzitutto essa perde la qualifica di norma stralcio, che si porta appresso dal 1999, e diventa vero e proprio articolo contrattuale; in secondo luogo, il conto personale di ore non dovrà più costituirsi a partire dall’81esima ora di lavoro straordinario nell’anno (nelle imprese fino a 200 dipendenti) e dalla 33esima ora per tutti gli altri, bensì dalla prima ora di lavoro eccedente (sia straordinario, sia in virtù dell’orario plurisettimanale, come appena detto). Beninteso, è solo una piccola modifica rispetto ad una visione dell’orario che adotta autenticamente in base alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori. Tuttavia, si tratta di un fatto significativo oltre che dall’effetto pratico importante se pensiamo proprio alle esigenze dei lavoratori migranti, i quali potrebbero utilizzare non solo un agevolato regime di collocazione temporale delle ferie, ma anche le ore eccedenti di lavoro versate alla Banca ore per accumulare un congruo periodo di assenza dal lavoro.
Il conto ore individuale potrebbe anche essere aumentato dall’accantonamento di uno dei 7 permessi annui retribuiti (PAR), previo esame con le RSU, e qualora il lavoratore non ne chieda il pagamento. Riguardo al godimento, va segnalato che il termine di preavviso passa da 25 a 15 giorni altresì introducendo nelle ipotesi di priorità rispetto al contingente che ne può godere contemporaneamente, la necessità per i lavoratori migranti di svolgere attività burocratiche.
Nel rinnovo sono stati modificati anche due istituti di grande importanza pratica e strategica: la reperibilità e la definizione dei tempi d’inizio dell’orario effettivo di lavoro.
A differenza della disciplina previdente (e che risale all’accordo separato del 2003), il nuovo art. 5-ter istituisce un diritto di informazione preventiva alla RSU qualora l’impresa intendesse utilizzare la reperibilità. La norma contrattuale, inoltre, in linea con la rivendicazione della piattaforma, sembra riconoscere che la permanenza in reperibilità può incidere sul godimento effettivo del riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7, d. lgs. n. 66/03) e che, pertanto, il presente contratto costituisce una ipotesi di deroga ex art. 17, d. lgs. n. 66/03 al principio legale del riposo giornaliero di 11 ore. La norma stabilisce che la deroga «non può assumere carattere di strutturalità» e che in ogni caso si deve assicurare un riposo giornaliero consecutivo di 8 ore.
Si tratta di una previsione normativa molto delicata e dalle numerose sollecitazione di ordine pratico e teorico. Il lavoratore ha il diritto di opporre un giustificato motivo a non svolgere turni di reperibilità; nondimeno, esso è un obbligo contrattuale dagli effetti considerevoli proprio in applicazione dei limiti e delle deroghe previste in materia di orario massimo. Le modifiche in parola hanno una notevole importanza perché si tratta di norma contrattuali in deroga ai già ampi limiti legali alla durata massima giornaliera. Solo che ciò è avvenuto attraverso l’istituto della reperibilità e non attraverso una decisa presa di posizione rispetto al tema dei tempi di lavoro. Si tratta, ancora una volta, di mancata consapevolezza sul fatto che il tema dei tempi di lavoro non può essere affrontato in ordine sparso, perché così non si ha il quadro generale delle interconnessioni di ogni norma con le altre. Ci sarebbe da lamentare, per esempio, la mancata presa di posizione sulla durata massima giornaliera (inclusiva di orario normale e straordinario) oppure della durata massima settimanale.
Allo stesso modo, proprio il tema delle reperibilità dimostra che è maturo il tempo per una rinnovata concezione del tempo di lavoro e che occorre riconoscere pieno statuto giuridico anche ai tempi strumentali che sono ormai assolutamente essenziali al processo produttivo ma piuttosto defilati rispetto alla regolazione giuridica. Il discorso, per esempio, vale per la nuova norma sulla regolazione della «Entrata ed uscita in azienda». In particolare, il secondo periodo stabilisce che «resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro». Rispetto all’art. 3, Disciplina Speciale – Parte Prima, la nuova norma contrattuale non da più una precisa regolazione del tempi ma affida alle disposizioni aziendali. Ebbene, ciò significa affidare alla disposizione unilaterale il criterio di calcolo dell’orario di lavoro effettivo, contraddicendo una tendenza della giurisprudenza che, invece, ha da tempo iniziato a dare rilievo a tempi di lavoro strumentali ma essenziali allo svolgimento della prestazione di lavoro (per esempio tempo-tuta o tempo di spostamento nell’area dello stabilimento).
4. Inquadramento unico
E veniamo all’altra questione nevralgica. Diciamo subito che la necessità “politica” di addivenire ad una conclusione del negoziato in tempi non troppo lunghi ha indotto le parti a riconoscere che un nuovo inquadramento contrattuale unico esige un confronto approfondito. Nondimeno, le parti non hanno voluto far cadere la questione ma hanno ritenuto di avviare una riflessione comune ed intanto di «valutare come utile e propedeutica alla riforma del sistema di inquadramento professionale la c.d. “parificazione operai impiegati” realizzata attraverso l’unificazione delle discipline normative relative ai lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato, definita con l’accordo di rinnovo». In particolare a partire dal 1° gennaio 2009 è estesa anche agli operai la disciplina della Parte Terza prima prevista per i soli impiegati, ferma restando la condizione di miglior favore. Uno degli effetti di maggior rilievo riguarda le ferie. Infatti, l’applicazione anche agli operai del regime di ferie degli impiegati fa si che i lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 10 anni e inferiore a 18 matureranno il diritto ad un giorno di ferie in più, mentre oltre i 18 anni di servizio matureranno una settimana in più rispetto alle quattro oggi previste dal d. lgs. n. 66/03.
Anche in materia di festività, gli operai acquisiscono il diritto a che le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno retribuite in aggiunta alla retribuzione mensile con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso di adibizione a mansioni superiori, invece, la nuova norma contrattuale è il risultato di una combinazione dell’art. 9 della Disciplina Speciale – Parte Prima valida per gli operai, con l’art. 8, Disciplina Speciale – Parte Terza per gli impiegati. Pertanto, il diritto alla conservazione della mansione superiore si acquisisce dopo 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi in 1 anno ovvero ancora dopo 6 mesi non continuativi in 3 anni; solo per l’acquisizione della 6a e 7a categoria il periodo è di 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi in 3 anni: si tratta dunque, complessivamente di una condizione di miglior favore per gli impiegati.
5. Contratti temporanei e flessibili
Infine il rinnovo del contratto ha previsto anche una disciplina di stabilizzazione dei contratti di lavoro temporanei. Proprio nella prima pagina dell’accordo è stabilito che «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». La stabilizzazione deriva da una norma avanzata nella piattaforma contrattuale e recepita in parte nel contratto in base alla quale «i lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti, sia con rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con quello di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita».
Innanzitutto va notato che questa la piattaforma richiedeva il limite complessivo di 36 mesi; potrebbe perciò apparire più penalizzante la nuova disciplina contrattuale. Sennonché quest’ultima non ha posto alcun periodo di riferimento entro cui si deve effettuare il computo dei periodi lavorati che, invece, nella piattaforma era di 60 mesi. In questo modo, quale che sia l’arco temporale di riferimento, allo scoccare del 45esimo mese complessivo di lavoro con la medesima azienda il lavoratore ha diritto alla stabilizzazione. A dire il vero la formula crea qualche dubbio in ordine alla formulazione letterale. Innanzitutto non si comprende per quale ragione non sia stato disposto che il contratto si trasforma automaticamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre si è preferito utilizzare un termine a-tecnico come «stabilizzazione». In secondo luogo, la norma parla di rapporti «intrattenuti»; anche in questo caso si tratta di una locuzione a-tecnica che, però, deve essere intesa nel senso che si riferisce sia all’assunzione con contratto a termine ex d. lgs. n. 368/01 sia all’utilizzazione in base ad un contratto di somministrazione.
Di notevole interesse è l’inclusione nel computo del periodo di lavoro anche del contratto di lavoro a termine stipulato ai sensi del nuovo art. 5 del d. lgs n. 368/01, che è stato introdotto in attuazione del Protocollo sul Welfare dalla Legge n. 247/07. Se dunque si rapporta la norma di legge a quella del rinnovo contrattuale si può apprezzare la maggiore tutela a favore della stabilizzazione del contratto collettivo perché include anche i periodi di lavoro effettuati per somministrazione di lavoro. Restano salve le norme aziendali in materia di stabilizzazione non solo quando sono di miglior favore (come nel caso del recente accordo di Gruppo Indesit Company in cui si procede alla stabilizzazione dopo 36 mesi complessivi) ma – c’è da presumere – anche se peggiorativi rispetto alla norma contrattuale (ma non a quella del d. lgs. n. 368/01).
Sarà necessario, dunque, che nelle specifiche norme contrattuali da stipulare entro febbraio 2008 siano definite le procedure attraverso le quali monitorare periodicamente le situazioni di ciascun lavoratore e precisare l’incidenza dei termini di trasformazione del contratto, i periodi di decorrenza ed ogni altro elemento necessario a dare certezza giuridica. Si può osservare che il contratto non ha dato risposta alla rivendicazione di una clausola di contigentamento dei lavoratori temporanei a differenza di altri contratti (si v. per esempio il contratto delle Telecomunicazioni del 2005).
Chi ha memoria della genesi del d. lgs. n. 368/01 ricorderà che fu proprio questa una delle questioni più controverse. Ad ogni modo, non si può escludere né che in sede di contrattazione applicativa della norma contrattuale si possa addivenire ad un’ulteriore precisazione dei vincoli, inclusi quelli derivanti già dall’applicazione del d. lgs. n. 368/01 con riferimento alle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che, la giurisprudenza nazionale (per tutte Cass. S. U. 2 marzo 2006, n. 4588) e la Corte di Giustizia (sentenza 4 luglio 2006, C-212/04 Adeneler sulla quale – ed in generale – v. il recente contributo di S. Sciarra, Il lavoro a tempo determinato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, WP C. S. D. L. E. “Massimo D’Antona”.IT – n. 52/2007, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp) hanno provveduto a delimitare. In questo senso, occorre avere la consapevolezza che la disciplina di stabilizzazione qui prevista non può ovviamente eludere i vincoli legali riguardo alla «temporaneità» della causale che giustifica il contratto a termine ovvero alla stipulazione successiva di più contratti. Tuttal’più, si può dire che l’effetto autenticamente innovativo della norma contrattuale in parola sta nell’aver incluso anche i rapporti di lavoro derivati da somministrazione di manodopera che sfuggono al limite oggettivo della temporaneità.
Infine, il contratto prevede l’istituzione di una Commissione con poteri negoziali per disciplinare il contratto di inserimento, il contratto di lavoro part-time e i rapporti di lavoro costituiti con imprese appaltatrici che – c’è da presumere – effettuino lavori di appalto interni all’azienda.
6. Conclusione
Altri elementi costellano il rinnovo contrattuale. In particolare sul piano retributivo si segnalano alcuni elementi di notevole interesse. Tralasciando la questione della quantificazione dell’incremento dei minimi tabellari (oppure dell’incremento dell’indennità di trasferta) che è questione eminentemente derivata dalla dinamica contrattuale, due elementi in particolare meritano di essere segnalati: da una parte l’assicurazione che agli operai non derivasse una retribuzione penalizzata a seguito dell’unificazione delle discipline speciali con gli impiegati, e perciò è stato riconosciuto un incremento retributivo pari a 11 ore e 10 minuti «a titolo di superminimo individuale non assorbibile».
Un ultima notazione riguarda il periodo di prova. Il rinnovo contrattuale ha modificato le ipotesi per le quali vi è una riduzione del periodo di prova e che s’inspirano al principio della valorizzazione dell’esperienza professionale. Infatti, la riduzione si giustifica quando il lavoratore abbia già una specifica professionalità a svolgere una certa mansione dimostrato dal fatto che per almeno 2 anni ha s volto identiche mansioni; pertanto appare ingiustificato avere un periodo di prova identico a chi versa in condizioni di maggiore inesperienza. Per lo stesso principio il periodo di prove si riduce in caso di apprendisti presso altre aziende formatosi per il medesimo profilo professionale per il quale si procede all’assunzione.
Complessivamente il contratto ha innovato numerosi istituti del contratto collettivo del 1999 e assorbito definitivamente altri istituti risalenti al 2003. In genere si può dire che la maggior parte delle modifiche migliora le condizioni di lavoro pur assecondando alcune esigenze organizzative ritenute – c’è da supporre – d’importanza strategica (penso all’ampliamento delle causali per l’orario multiperiodale oppure al regime di reperibilità). Che in ciascuna clausola di modificazione ci siano ulteriori margini di innovazione è fuori di dubbio. Che, peraltro, ci siano alcune questioni che restano ancora bandite dal tavolo negoziale è altrettanto vero. Ma una più completa valutazione delle ragioni dipende anche dal clima generale in cui maturano gli accordi collettivi. Quello che si può dire è che ci sono ancora molti e urgenti questioni che devono essere affrontate: non solo quelle legate all’utilizzazione dei contratti temporanei o flessibili (cui si provvedere nell’immediato futuro) ma soprattutto in tema di organizzazione del lavoro e diritti dei lavoratori.
Nel contratto rinnovato di metalmeccanici ci sono alcune novità emblematiche che possono rappresentare il paradigma per nuovi e più avanzati modelli di organizzazione del lavoro. Si tratta di istituti che concorrono a definire il quadro normativo del lavoro di qualità, elemento imprescindibile per una lavoro autenticamente orientato alla produttività qualitativa. Sarà decisivo affrontare organicamente la materia dei tempi di lavoro e non-lavoro nonché la materia della professionalità dei lavoratori, in parallelo ad una nuova e più avanzata griglia di diritti di formazione. Nel frattempo, dato il contesto e la storia recente della contrattazione collettiva nel settore metalmeccanico, si può dire che qualcosa è accaduto; poco ma comunque nella giusta direzione.