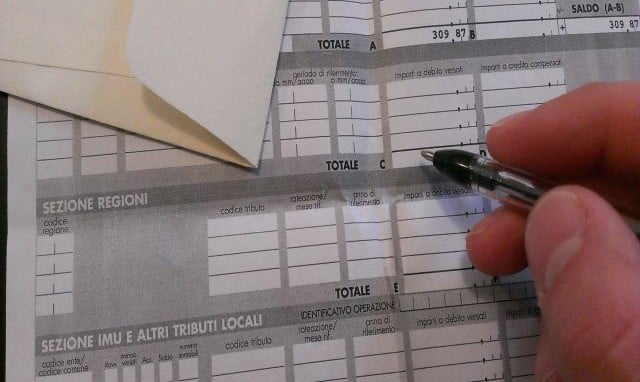di Mario Ricciardi, Università di Bologna
Parlare dell’effetto del voto sulle relazioni industriali, per rispondere al cortese invito del “Diario del lavoro”, non è un compito facile. Intanto, perché è difficile parlarne quando ancora non si conosce la composizione del nuovo governo, gli equilibri interni e neppure l’identità del ministro del Lavoro. In secondo luogo, perché è francamente difficile ragionare sulle prospettive future in un sistema politico come quello italiano. Certo, il risultato delle elezioni è stato per diversi aspetti sorprendente, anche se la vittoria della destra era largamente prevedibile, corrispondendo in parte a tendenze di lungo periodo dell’elettorato, in parte alla tentennante, e alla fine insostenibile, esperienza di governo del centrosinistra. Lanciarsi in previsioni di medio periodo può essere tuttavia imprudente, sia perché la congiuntura generale è molto incerta, sia per le caratteristiche stesse dell’evoluzione politica italiana. Tra circa un anno ci saranno nuove elezioni, europee e amministrative, con sistemi elettorali diversi da quello delle politiche, e l’esperienza passata ci insegna che tra un anno potremmo discettare su scenari anche assai diversi da quello di fronte al quale ci troviamo ora.
Volendo comunque azzardare qualche riflessione per la prospettiva breve, si possono fare alcune osservazioni.
La prima, piuttosto scontata, è che è prevedibile una discontinuità rispetto alle forme e ai modi della politica di ricerca della concertazione sociale perseguita nella legislatura appena conclusa. La ricerca del consenso a tutti i costi con le parti sociali è del resto storicamente tipica, nell’esperienza italiana, dei governi deboli sul piano politico-parlamentare, oltrechè ideologicamente orientati in senso concertativo. Va da sé che il governo Berlusconi-ter ha una maggioranza abbastanza ampia da garantirgli l’autosufficienza sul piano parlamentare, e le forze che lo sostengono sono (salvo mutamenti di rotta allo stato piuttosto improbabili) orientate semmai verso il “dialogo sociale”, che è una forma di rapporto nel quale alle parti sociali, e al sindacato in particolare, è consentito di collaborare all’attuazione di decisioni già assunte dall’esecutivo in forza del più o meno esplicito patto elettorale, piuttosto che di co-elaborare le decisioni strategiche.
Questa impostazione d’ordine generale (che corrisponde peraltro all’attitudine poco amichevole verso i sindacati diffusa tra l’elettorato di riferimento dei partiti di governo) potrebbe tuttavia essere temperata, se non modificata, da alcuni elementi in parte nuovi rispetto alle esperienze più recenti. Intanto, l’evoluzione in senso bipartitico del sistema politico italiano spinge inevitabilmente le forze politiche verso un crescente interclassismo, il che potrebbe far ipotizzare un’evoluzione (almeno) del più importante dei partiti di governo verso un modello di partito popolare (anziché populista) di massa. Non v’è dubbio, poi, che l’appesantirsi della congiuntura economica potrebbe consigliare il governo a non complicarsi troppo la vita attizzando conflitti, ma a cercare piuttosto forme di accordo con le parti sociali, come hanno fatto e fanno, del resto, i governi moderati d’Europa, da Aznar alla Merkel e, probabilmente, allo stesso Sarkozy. Si può fare, infine una constatazione abbastanza banale. Le riforme in senso mercatista del diritto del lavoro italiano sono in larga misura ormai compiute, in una logica non formalmente, ma nei fatti bipartisan. Lo è la riforma del mercato del lavoro, avvenuta con la legge Biagi e lasciata intatta dal governo Prodi. Lo è la riforma delle pensioni, anch’essa maturata in una sorta di staffetta tra governi d’ispirazione diversa. Il principale terreno su cui potrebbero ancora trovare sfogo le pulsioni più radicali è quello della destrutturazione del sistema contrattuale, ma si tratta di un terreno irto di ostacoli, e si tratta di capire se il nuovo governo riterrà che valga la pena di sollevare intorno a questo tema un conflitto che potrebbe essere molto aspro. Tutto sommato, la prospettiva appare ancora piuttosto incerta. Bisogna vedere se prevarranno nel medio temine le pulsioni tradizionalmente più profonde dello schieramento vincente, o l’interesse a una sua evoluzione verso una maggiore moderazione sul modello europeo.
Un discorso per diversi aspetti analogo si può fare per quanto riguarda gli imprenditori. Essi hanno ottenuto parecchio, sia nella legislatura del centrodestra che in quella appena conclusa. Basti pensare alla riforma del mercato del lavoro, alla riduzione del cuneo fiscale, alle misure contenute dell’accordo di luglio 2007. Hanno un mercato del lavoro ormai estremamente flessibile, e salari tra i più bassi d’Europa . Tutto farebbe pensare che un ceto imprenditoriale maturo e consapevole dovrebbe condividere il disegno di far crescere la competitività e la qualità del sistema attraverso misure concertate tendenti a far crescere gli investimenti in qualità e ricerca, ad aumentare il livello qualitativo della forza-lavoro, a porsi come obiettivo quello di garantire ai propri collaboratori salari e stabilità del lavoro comparabili con quelli dell’Europa.
Per queste ragioni risulta poco comprensibile la scelta del presidente di Confindustria di mettere l’ultimo sigillo alla sua presidenza sferrando un attacco ad alzo zero contro i sindacati (attacco sferrato in singolare coincidenza con la pubblicazione di un libello sulla “casta” sindacale nel quale si mescolano con disinvoltura notizie vere, omissioni e vere e proprie fandonie). Si tratta di capire se questa tardiva conversione in senso radicale di una presidenza che era nata nel segno del dialogo preluda a un cambiamento di rotta dell’intiera organizzazione, o serva soltanto a cercare di nascondere le responsabilità di un fallimento, quello della trattativa sulla riforma della contrattazione, che, riguardando un trattativa bilaterale, è per definizione attribuibile ad entrambe le parti.
Per quanto riguarda i sindacati, infine, non c’è dubbio che l’immediato futuro dei loro atteggiamenti dipenderà in misura rilevante dalle mosse degli altri due interlocutori delle relazioni industriali. L’esito del voto nello schieramento a loro tradizionalmente più vicino è stato per diversi aspetti traumatico, ma non è detto che ciò eserciti effetti rilevanti, visto che i rapporti con la sinistra cosiddetta radicale erano da tempo difficili ed erano diventati pessimi dopo la vicenda-welfare, mentre la cinghia di trasmissione con una sinistra riformista da molto tempo in cammino verso orizzonti decisamente interclassisti era finita da un pezzo. Certo, la fine (definitiva?) di uno scenario politico che, sia pur ormai vagamente, affondava le sue radici negli equilibri della prima repubblica, potrebbe accelerare un processo di riflessione strategica e di autoriforma (democratizzazione interna, sburocratizzazione e rinnovamento anche generazionale) di cui peraltro il sindacato ha ormai urgentemente bisogno, anche indipendentemente dall’evoluzione delle vicende politiche. Sarebbe un vero peccato se il radicalizzarsi del contesto sociale rallentasse il concretizzarsi, ancora una volta, di questa prospettiva.