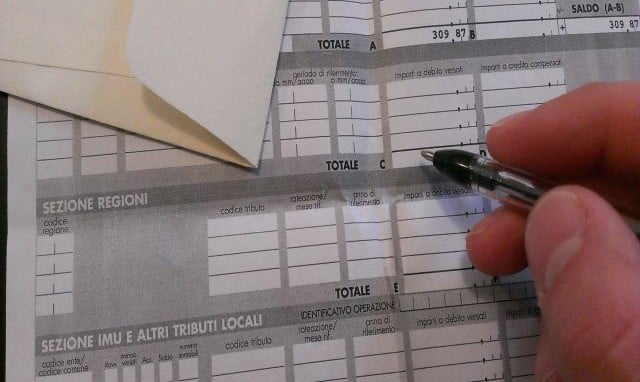di Giuseppe D’Aloia, esperto di relazioni industriali
(La sintesi del Rapporto Cnel)
Il Rapporto Cnel sulla contrattazione aziendale nel settore privato dell’economia presenta due risultati fondamentali: una tendenza al declino della diffusione e della frequenza della contrattazione a livello aziendale e una scarsa presenza (anzi un regresso) dei temi collegati all’innovazione organizzativa negli accordi esaminati.
Il Rapporto si basa sull’analisi – lungo il periodo 1998-2006 – dell’andamento della diffusione (o intensità) della contrattazione a livello aziendale in un campione di circa 1.100 imprese (per quasi 3.000 accordi), delle frequenze di contrattazione delle diverse materie e di 13 case studies di particolare interesse. L’analisi è stata condotta, soprattutto cercando di verificare il peso ed il ruolo delle diverse forme di flessibilità nella contrattazione aziendale: la flessibilità retributiva, quella connessa, cioè, alla contrattazione della parte variabile della retribuzione legata alle performance di impresa; la flessibilità numerica, rappresentata dalla flessibilità da contratto (contratti a termine, atipici, ecc.) e dalla flessibilità da orario; infine, la flessibilità funzionale o organizzativa, quella legata all’introduzione di forme di innovazione organizzativa come quelle suggerite dalle cosiddette new forms of work organization.
1. La flessione dell’intensità di contrattazione
L’evidenza di maggior rilievo che emerge dall’analisi sembra essere la flessione della diffusione e dell’intensità di contrattazione lungo l’insieme del periodo 1998-2006.
Questa tendenza al declino si manifesta sia per le imprese maggiori (>= 1.000 dip.) che – in modo più evidente – per quelle di minore dimensione (tra 100 e 999 dip.). Per ciascuno dei settori si evidenziano (in particolare per le imprese maggiori) dei massimi di intensità di contrattazione (nel 2000 e nel 2004 per i metalmeccanici, nel ’98 e nel 2002 per gli alimentaristi, nel 2000 e nel 2003 per la chimica) che corrispondono alle stagioni di rinnovo della contrattazione integrativa, ma sempre all’interno di una tendenza alla flessione dell’intensità di contrattazione; tale tendenza è più evidente per le imprese di minore dimensione.
La flessione dell’intensità di contrattazione registrata dal nostro Archivio può essere messa in relazione sia alla flessione e alla caduta della produttività nel periodo 2000-2005 e, quindi, ad una attenuazione della ability to pay delle imprese (con la conseguenza di un mancato rinnovo dei contratti integrativi o comunque di una mancata erogazione di quote di retribuzione aggiuntiva), ma anche alle difficoltà delle relazioni industriali segnalate anche dal forte ritardo dei rinnovi contrattuali in importanti settori e dalle difficoltà delle trattative nello stesso periodo. Sia le difficoltà della situazione economica che quelle delle relazioni industriali hanno spesso finito per imporre un vero e proprio slittamento delle stagioni di contrattazione integrativa e per spostare l’attenzione delle parti sociali piuttosto sulla gestione di complessi processi di ristrutturazione aziendale, con i connessi problemi di outsorcing e di dislocazione all’estero di fasi importanti dei cicli produttivi.
2. La contrattazione delle diverse forme di flessibilità e l’innovazione organizzativa
Dal rapporto emerge con nettezza il ruolo preminente della contrattazione salariale e, dunque, della flessibilità retributiva, attraverso la contrattazione dei Premi di risultato. La flessibilità da orario rappresenta la seconda voce per frequenza di contrattazione in tutti i settori con uno scarto abbastanza sensibile rispetto alle frequenze registrate dalle materie relative alla flessibilità organizzativa (organizzazione del lavoro, inquadramento, formazione): le prime si collocano in generale in una fascia alta delle frequenze relative, spesso superiore al 70%; le seconde in una fascia in generale intorno al 50%.
La flessibilità da contratto – i contratti atipici – si colloca in generale nella fascia medio bassa delle frequenze di contrattazione. Se si tiene conto del fatto che, in particolare negli ultimi anni, le nuove assunzioni sono avvenute nella grande maggioranza attraverso forme di contratto a tempo determinato, la relativamente bassa frequenza di contrattazione di questa materia sembra indicare che si tratta di una materia che in una certa misura sfugge alla contrattazione stessa.
L’analisi dei testi e dei case study esaminati emerge che le esperienze di innovazione organizzativa risultano scarsamente presenti nella contrattazione (in generale negli accordi ci si limita a impegni generici), ma nella seconda metà degli anni ‘90, si registrano alcune (anche se del tutto minoritarie) esperienze di particolare interesse nelle quali, si dà vita a dei progetti sistemici che integrano formazione, programmi di aggiornamento, sviluppo delle professionalità, nuovi modelli organizzativi (l’organizzazione del lavoro come elemento fondamentale del modello partecipativo; lo snellimento organizzativo e la riduzione dei livelli gerarchici; l’arricchimento, la polivalenza, la polifunzionalitá, la capacità di problem solving, la responsabilizzazione ed autonomia operativa, il lavoro integrato e i team work, ecc.). Dall’esame della contrattazione successiva a questa stagione emerge, però, un sostanziale abbandono (almeno a quanto si può dedurre dalla lettura degli accordi) di queste pratiche innovative (con la sola eccezione di due o tre delle imprese esaminate), e una forte accentuazione della centralità della flessibilità da orario e da contratto e di quella retributiva. Una sorta di ritorno, insomma a nuove forme di neo-taylorismo. Uno scenario, insomma, che sembra confermare, il carattere nettamente minoritario delle esperienze di innovazione organizzativa rilevata da una ricerca dell’ISFOL.