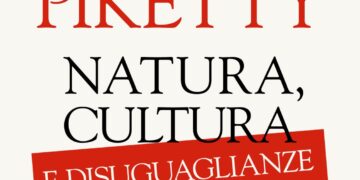È ormai incontrovertibile l’esistenza in Italia di una questione salariale. Il tema del lavoro povero con la incapacità dell’attuale sistema di contrattazione collettiva di garantire l’adeguamento salariale al costo (reale) della vita e di recuperare la perdita del potere d’acquisto del mondo del lavoro italiano, anche a causa della crescente debolezza dei sindacati “storici” e delle loro divisioni, restituiscono attualità alle intuizioni fondamentali dell’economista del lavoro Ezio Tarantelli, sull’uso concertato della politica salariale, con la predeterminazione nella lotta all’inflazione, per un tasso decelerante di aumento dei prezzi.
Furono queste le intuizione alla base del decreto-legge del 14 febbraio 1984, imposto dal diktat del Partito comunista di Berlinguer al leader della Cgil Luciano Lama, che l’accordo triangolare voleva sottoscriverlo unitariamente con la Cisl di Pierre Carniti e la Uil di Giorgio Benvenuto e il governo presieduto dal socialista Bettino Craxi, ed ebbe conseguenze storiche non solo sull’economia italiana, ma anche sulle relazioni sindacali e sullo stesso sistema politico.
Infatti, il taglio di 4 punti di contingenza, poi ridotti a tre, del meccanismo di scala mobile, con cui ogni tre mesi i salari si adeguavano automaticamente all’aumento dell’inflazione in una spirale sud-americana, con un contributo primario derivante dai prezzi dei prodotti petroliferi e dal loro pagamento in dollari, a fronte delle continue svalutazioni della lira, con il crescente debito pubblico a cui il cosiddetto “divorzio” tra Tesoro e Bankitalia del 1981 ha dato storicamente un contributo primario, innescò un importante ciclo di crescita virtuosa, il più importante dal dopoguerra, assieme a quello degli anni del boom economico.
Tarantelli credeva nella politica dei redditi e nella concertazione tra istituzioni e parti sociali e pagò il suo impegno teorico con la vita, trucidato dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985, tre mesi prima del referendum sulla scala mobile del 9 e 10 giugno 1985, promosso e perso dal Partito comunista, per l’abrogazione del provvedimento del governo.
Al quel modello lo Stato era chiamato a contribuire con una fiscalità meno oppressiva soprattutto per il lavoro dipendente (la Storia si ripete!) e con una maggiore efficienza nei servizi: uno “scambio politico” necessario per raggiungere – attraverso il coordinamento tra i soggetti del settore privato e di quello pubblico – un più alto livello di benessere sociale. La conseguenza istituzionale di questo approccio era la centralizzazione delle istanze decisionali dei vari attori, in particolare del sindacato.
Ma c’è da chiedersi se oggi, in un contesto profondamente mutato rispetto alla metà degli anni Ottanta del secolo trascorso, vinta la lotta all’inflazione anche per effetto dei meccanismi elaborati da Tarantelli, in uno scenario che vede la centralizzazione della politica monetaria a livello europeo, la politica economica vincolata nella spesa e nel debito per ciascuno dei paesi dell’Unione, i sindacati in difficoltà rispetto ad un sistema produttivo sempre più frammentato anche in conseguenza dei processi di digitalizzazione e delocalizzato, la pratica del dumping contrattuale in campo nazionale e di quello sociale a livello globale, siano ancora utilizzabili le sue intuizioni.
Sicuramente, venuta meno nel 1992 la scala mobile, a seguito dell’accordo triangolare tra il governo-Amato e le parti sociali, con le successive dimissioni di Bruno Trentin dalla guida della Cgil, e con un’inflazione in discesa grazie a quella che venne definita la “concertazione dell’emergenza” a partire dalla successiva intesa del 1993 con l’esecutivo presieduto da Ciampi, appare utile recuperare la proposta di un conguaglio salariale a fine anno, per l’eventuale scarto tra andamento retributivo ed aumento (reale) di prezzi e tariffe, che tenga conto dei prodotti energetici e accantoni l’insufficiente Ipca.
Inoltre, nell’attuale scenario di notevole incertezza sociale l’introduzione del salario minimo potrebbe costituire un provvedimento importante per contrastare l’impoverimento dei redditi da lavoro, in un quadro macroeconomico che ha visto negli ultimi venti anni un significativo trasferimento del reddito nazionale dalle retribuzioni ai profitti con un crescente aumento delle rendite finanziarie, oltre alla necessaria istituzionalizzazione del sistema della rappresentanza collettiva e della contrattazione, attraverso un intervento legislativo rispettoso dell’art. 39, con i suoi principi di libertà e pluralismo sindacali, della Costituzione e del diritto vivente.
Maurizio Ballistreri – Professore ordinario ab. di Diritto del Lavoro, Università di Messina