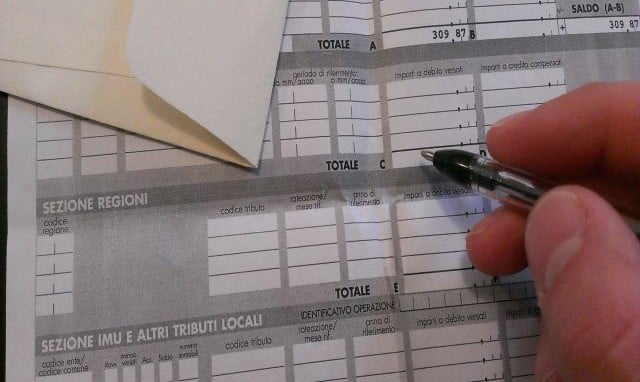di Mario Ricciardi, Università di Bologna
L’aprirsi di una fase di trattative sulla riforma del sistema di contrattazione collettiva rappresenta certamente un fatto positivo, dopo tanto parlarne e dopo tante false partenze. La crisi della contrattazione è sotto gli occhi di tutti quelli che sanno e vogliono vedere, e ne è soltanto un sintomo, ma non certo casuale né irrilevante, che nella campagna elettorale in corso si torni a parlare di istituti che, pur molto diversi tra loro, sono comunque obiettivamente alternativi alla contrattazione stessa, come la scala mobile ed il salario minimo garantito per legge.
E’ inoltre un forte limite della trattativa che sta (forse) decollando, che essa si svolga in sede soltanto bilaterale, avendo come protagonisti soltanto sindacati e Confindustria. Uno dei pregi del sistema contrattuale varato nell’estate di quindici anni or sono fu quello di tenere assieme, con regole comuni, tutto il sistema italiano, delle grandi e delle minori imprese, del privato e del pubblico. Non è detto che, a condizioni mutate, ciò sia ancora possibile o auspicabile, ma non c’è dubbio che sarebbe sbagliato rinunciarvi a priori. Allo stesso tempo, però, appare sbagliato anche pensare che alla riforma complessiva possano provvedere soltanto alcuni soggetti, per quanto importanti, escludendo dalla trattativa tutto il settore pubblico, il cui sistema contrattuale ha, come è noto, caratteristiche in parte comuni con quello privato ma in parte del tutto peculiari. Si tratta di capire se la trattativa che si è aperta in questi giorni, e che sta procedendo per tavoli “tecnici”, sfocerà in un negoziato vero e proprio in tempo utile per aggiungere anche l’interlocutore pubblico al tavolo delle trattative, oppure se nel pubblico si condurrà una trattativa a parte, nel nuovo quadro politico che si comporrà dopo le elezioni. In questo caso, la trattativa non potrebbe, alla fine, che adeguarsi alle linee guida eventualmente raggiunte nel privato, salvo che si voglia rinunciare a uno degli aspetti fondamentali della cosiddetta “privatizzazione”. Su tutto grava, ovviamente, l’incognita di quale sarà il risultato elettorale, e di quali saranno le intenzioni in questa materia di chi formerà il governo, pur essendo questo, da quel che è possibile vedere dalle prime battute della campagna elettorale, un tema sul quale non è che si sprechino l’attenzione e le proposte.
La crisi di governo e la fine anticipata della legislatura hanno insomma prodotto risultati negativi anche in questa materia, e, come si è sottolineato da più parti, l’assenza di un negoziato trilaterale rappresenta probabilmente un elemento di debolezza, e non di forza, per il raggiungimento di un accordo che abbia la possibilità di durare nel tempo.
Il dato positivo che si deve però sottolineare, leggendo le cronache e alcuni documenti preparatori che sono circolati, è che sembra esservi ormai una diffusa consonanza di posizioni, almeno sull’agenda e sui temi che è necessario affrontare per condurre una trattativa fruttuosa. In particolare i sindacati, dopo un lungo tempo nel quale le posizioni erano rimaste notevolmente diversificate (si pensi alle diverse opzioni che vennero registrate alla fine dei lavori della commissione che vari mesi or sono riuscì a malapena a fare una ricognizione delle opinioni esistenti sull’argomento), sono stati in grado di elaborare una bozza unitaria che appare non solo sufficientemente articolata, ma anche piuttosto ragionevole ed equilibrata.
L’obiettivo che appare centrale è quello di restituire alla contrattazione quella credibilità che il protocollo del 1993 era riuscito ad assicurare per un decennio, e che si è venuta logorando negli anni più vicini a noi. Procedure contrattuali snelle e capaci di assicurare il raggiungimento di accordi in tempi ragionevoli e senza conflitti inutili, capacità di assicurare una tutela dei salari contro l’inflazione attraverso i contratti e senza ricorrere ad automatismi, estesa diffusione della contrattazione di secondo livello in una logica partecipativa e di promozione della produttività e redditività dell’impresa.
In questo quadro riveste un’importanza particolare, e per certi aspetti preliminare, il tema del disboscamento dei contratti. Le cifre non sono note con esattezza, si è parlato di 378 contratti tra pubblico e privato, la bozza sindacale parla di “oltre quattrocento”. Comunque sia, si tratta di un eccesso di dispersione, che produce effetti non positivi a vari livelli. Da un lato, surriscalda la macchina contrattuale, che è perennemente in moto. Non è solo un problema di conflittualità, che pure conta, ma di costante lavorio in un universo estremamente frammentato, dell’inseguimento di troppi particolarismi, dell’ impegno di centinaia di persone non sempre dotate delle conoscenze generali e delle capacità tecnico-professionali per sfornare buoni prodotti, di un ormai palese affanno delle istanze confederali, dall’una e dall’altra parte, nel mantenere una qualche forma di supervisione e di coordinamento su questo universo in perenne movimento. Si tratta, insomma, di ridurre drasticamente la quantità per innalzare la qualità dei prodotti contrattuali, ciò che non dovrebbe neppure essere difficilissimo, se si guarda alla struttura organizzativa interna ormai assunta dalle parti sociali, all’interno delle quali, negli anni più recenti, si sono verificati numerosi processi di revisione organizzativa, che hanno fortemente concentrato le strutture di categoria: esse sono ormai non più di quindici-venti nei grandi sindacati, mentre anche la Confindustria ha provveduto ad organizzare in federazioni di settore la miriade di associazioni categoriali. L’altro risultato rilevante e certamente positivo di una semplificazione dei contratti dovrebbe essere quello di invertire la tendenza all’estrema frammentazione delle tutele, per creare una base di trattamento omogeneo, almeno a livello generale, per attività e lavori che hanno contenuti professionali sostanzialmente simili
Naturalmente, quello che appare superficialmente facile, lo è di meno nella realtà. Innanzitutto, non basta dire che si vuole accorpare, si deve dire come. L’ipotesi probabilmente più realistica potrebbe essere quella di cominciare ad accorpare la miriade di contratti minori, che spesso riguardano gruppi relativamente piccoli di addetti, in più grandi contratti di settore omogeneo. E’ evidente che si tratta di un processo complicato e che non potrà che avere caratteristiche di gradualità, data la difficoltà di ricondurre a disciplina unitaria settori e microsettori che hanno spesso storie e tradizioni contrattuali diverse, che non è facile ricondurre ad unità, non solo dal punto di vista delle discipline contrattuali. Le tracce della “storia” sono del resto ben presenti anche dentro i sindacati, nei quali i processi di accorpamento effettivo di categorie e microcategorie richiedono anni, e talvolta sono vissuti dai quadri intermedi come vere e proprie forzature. Ben più impegnativo sarebbe invece se si volesse raggiungere l’obiettivo di operare una più drastica riduzione del numero dei contratti, portandolo a coincidere, o quasi, con quello delle strutture di categoria oggi esistenti.In questo caso, infatti, a parte la difficoltà dell’accorpamento, da un lato si dovrebbero fare contratti con discipline molto generali, dall’altro si dovrebbe pensare probabilmente ad andare verso discipline “di settore” all’interno delle macrocategorie così individuate. Ancor più complesso e ambizioso (ma probabilmente utile, almeno in certi settori) sarebbe volersi cimentare con l’unificazione di contratti dello stesso settore ma di datori di lavoro diversi, come ad esempio tra pubblico e privato.
Che l’operazione, comunque la si voglia condurre, sia indispensabile ma probabilmente tutt’altro che una passeggiata lo testimoniano anche alcune recenti vicende del settore pubblico. Qui negli ultimi anni si è andati in controtendenza rispetto all’esigenza qui rappresentata. Rispetto alle origini (metà anni novanta) si sono infatti creati nell’ultimo decennio, per lo più attraverso l’uso improprio dell’invasione di campo legislativa, nuovi micro-comparti, contraddicendo apertamente la filosofia originaria della riforma. In tempi molto recenti l’Aran ha provato a invertire la tendenza, cercando di ricondurre la frammentazione entro termini fisiologici. Ma l’opposizione congiunta dei corporativismi di alcune amministrazioni e dei calcoli di bottega di alcune organizzazioni sindacali timorose di indebolire la loro quota di rappresentatività, hanno congelato la situazione che si era venuta a determinare. Una volta spremuto, rimettere il dentifricio dentro il tubetto è piuttosto complicato.