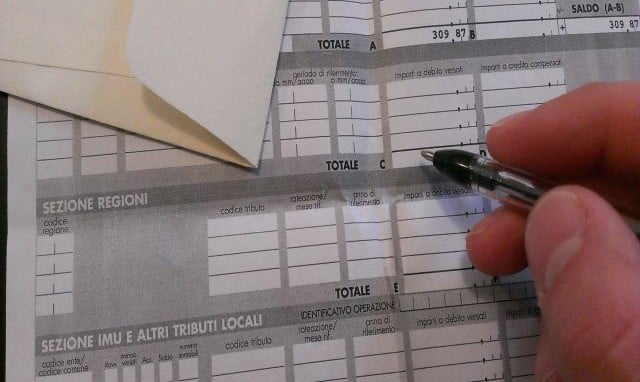di Andrea Ciampani, Università Lumsa di Roma
(In questo articolo si anticipa il tema centrale della nuova pubblicazione trimestrale “Sindacalismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale”, edita da Rubbettino, il cui primo numero esce in libreria questa settimana).
Nell’odierno dibattito pubblico sulla profonda fase di trasformazioni del capitalismo torna a imporsi la questione della libertà nelle dinamiche d’interdipendenza tra dimensione politica, sociale ed economica. Si pone in particolare l’interrogativo su come delineare un mercato di concorrenza ben funzionante eliminando, contemporaneamente, distorsioni e asimmetrie sul piano delle dinamiche sociali. E’ in questo contesto che inizia ad approfondirsi una riflessione sul contributo che possono apportare ad una regolazione sociale della vita socio-economica alcune esperienze già avviate nell’ambito della società civile. Promosse da diversi attori che, alla luce della cultura di responsabilità sociale che li sostiene, intervengono nel campo economico, dal mondo del credito cooperativo e popolare all’impresa sociale, tali iniziative invitano a ripensare l’esperienza delle persone che lavorano e del loro agire collettivo, proponendo un dibattito sulla sorta di “capitalismo associativo” che nel loro insieme sembrano delineare.
In questo contesto si colloca, in particolare, anche l’azione del movimento sindacale, nella misura in cui impegna la propria forza associativa nella partecipazione dei lavoratori ai processi di formazione delle decisioni economiche, mostrandosi da tempo interessato e coinvolto nella discussione intorno all’orientamento sociale del mercato, secondo dinamiche di libertà e responsabilità. Un approccio storico di quanto accaduto in Italia, peraltro, può forse aiutare a comprendere la profondità e le peculiarità dell’attuale problematica.
L’orientamento della cultura sindacale introdotta dalla Cisl nella seconda metà degli anni Cinquanta doveva fare i conti, nel decennio successivo, con la visione dirigistica e imperniata sul controllo dell’amministrazione pubblica sullo sviluppo economico dell’area governativa, con una programmazione economica ricondotta alla pura gestione politica parlamentare, con una forte resistenza culturale sindacale e patronale, potendo contare, all’esterno della Cisl, solo sulla lungimirante adesione di un ristretto ambiente politico, economico e finanziario. Tuttavia, quando già si annunciava la stagione sindacale del “potere contro potere”, Romani tornava a ribadire alla dirigenza confederale della Cisl, nell’estate 1967, come fosse necessario (“non solo per il vantaggio immediato dei lavoratori, ma per la possibilità di mandare avanti la crescita interna del sistema”) sviluppare le dinamiche partecipative nel processo d’accumulazione, “al processo, cioè, di formazione del fondo di risorse finanziarie che – spiegava in maniera piana nel corso del suo dialogo con i responsabili sindacali – sono quelle che in definitiva sostengono tutta la crescita in qualsiasi settore o direzione e qualsiasi aspetto o momento”. E continuava, esplicitamente: “E’ necessario, cioè, che i lavoratori organizzati, con la loro azione, tendano a passare dalla contrattazione esclusiva del mercato del lavoro alla considerazione di quell’altro mercato, un fattore della produzione che diventa sempre più importante, come abbiamo sentito, obiettivamente: il mercato dei capitali.”
Romani entrava anche nella descrizione degli strumenti a disposizione, con la piena consapevolezza della difficoltà che la prospettiva additata avrebbe affrontato all’interno degli equilibri politico-economici di allora. Gli premeva, tuttavia, che s’individuasse soprattutto il fatto che coloro che si preoccupavano “veramente di vedere un pochettino di là della superficie delle cose” fossero portati “non solo in Italia, ma nell’intero mondo civile” a considerare “la questione della partecipazione del lavoro dipendente al processo di accumulazione come una questione fondamentale”. Del resto, anche “sotto il profilo economico-finanziario, della funzionalità dei mercati, a scala interna e internazionale, e dell’irrobustimento di questi mercati” e del loro allargamento, appariva possibile allora pensare l’inserimento di nuovi attori. Da parte del sindacato, poi, sarebbe stato facile vedere in questo processo il conseguimento di ulteriori “punti concreti di forza nello svolgimento dell’azione generale” dell’evoluzione socio-economica. Di fronte alle domande di cambiamento e di maggiore giustizia sociale, infine, che si sollevavano con forza nella seconda metà degli anni Sessanta, Romani faceva osservare il rilievo che per un profondo mutamento sociale poteva assumere il collocarsi del movimento di rappresentanza sindacale in “uno dei punti di forza della società capitalista o neocapitalista” .