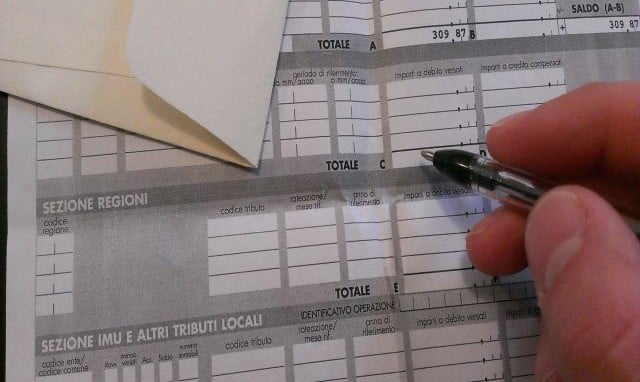di Vincenzo Bavaro, Università di Bari
Ha ragione Leopoldo Meneghelli (L. MENEGHELLI, Dai diritti ai sussidi, in q. rivista, 10 marzo 2008) a dire che era questione di tempo e che il tempo della messa in discussione dello Statuto dei lavoratori è arrivato. Si deve precisare, però, che quello di queste settimane è il tempo in cui alcuni organi autorevoli di informazione hanno ospitato interventi dichiaratamente favorevoli alla necessità di «abrogare» (sic) tutto lo Statuto dei lavoratori, ma non è inedita questa posizione. Mi limito a ricordare che proprio uno dei direttori di questa rivista, quasi dieci anni fa, ebbe a parlare della disciplina del licenziamento (nella specifica parte prevista dall’art. 18 dello Statuto) come di un «ultimo tabù» del diritto del lavoro post-repubblicano (cfr. A. ACCORNERO, L’ultimo tabù, Laterza, Bari-Roma, 1999).
In verità, più che esprimere una posizione favorevole, Accornero si limitò a mettere in evidenza che la questione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori era presente nel dibattito pubblico, poiché fu proprio l’allora presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, a proporre il tema della sperimentazione di forme alternative di tutela dai licenziamenti ingiustificati rispetto a quella prevista dallo Statuto.
A dire il vero, nel dibattito scientifico si era cominciato a mettere sotto accusa il sistema di controllo giudiziario della disciplina del licenziamento illegittimo (cfr. A. ICHINO, P. ICHINO e M. POLO, L’influenza delle condizioni del mercato del lavoro regionale sulle decisioni dei giudici in materia di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, I, p. 19 ss.). In effetti, quando si parla di licenziamento e di tutela reintegratoria, è principalmente sul fattore giudiziario che si concentra la critica maggiore. Si sostiene che il fattore principale di diseconomia della disciplina giuridica sul licenziamento individuale sia proprio il rischio incalcolabile connesso alla vicenda giudiziaria. La ragione di tale rischio risiede soprattutto nella possibilità che tale vicenda possa protrarsi per un periodo troppo lungo rispetto alla sentenza.
Orbene, l’argomento è serio. Non v’è dubbio che la durata di un processo eccessivamente lungo incide sulla capacità dell’impresa di pervenire in tempi rapidi alla definizione del contenzioso e, quindi, dei suoi eventuali costi. Ma si deve altresì riconoscere che questo problema è maggiormente gravoso proprio per i lavoratori, i quali, ovviamente, subiscono con maggiore pena le conseguenze di tempi processuali molto lunghi, ammesso che siano in grado di reggere lo sforzo economico di un processo sin dinanzi alla Corte di Cassazione. In ogni caso, si può dire che la questione del processo del lavoro è urgente e meriterebbe attenzione ben più grande di quella che abitualmente riceve.
Questo aspetto del problema, però, come si può facilmente intendere, non ha nulla a che fare con la grezza tesi di chi ritiene che la modernizzazione del diritto del lavoro debba passare per una rimozione del controllo giudiziario sulla libertà di licenziare, «soprattutto togliendo di mezzo i giudici e il diritto di chi è licenziato ad appellarsi a un tribunale del lavoro, tranne che per casi davvero estremi» (A. ALESINA e F. GIAVAZZI, Il liberismo è di sinistra, il Saggiatore, Milano, 2007, p. 68). In sostanza, si dice, escludendo i casi di licenziamento discriminatorio, la tutela dal licenziamento illegittimo non deve consistere nella conservazione del posto di lavoro ma in una forma di tutela risarcitoria. Ciò supportato dal postulato tralaticiamente ripetuto – tale da divenire ideologico – dalla Commissione Europea: «sulla base delle analisi di cui si dispone, una legislazione rigida a tutela dell’occupazione riduce il numero di licenziamenti ma fa anche calare il numero di transizioni dalla disoccupazione al lavoro. Al momento di reclutare nuovo personale le aziende tengono conto della probabilità di trovarsi ad incorrere in futuro in elevati costi di licenziamento. Questa è una preoccupazione particolarmente avvertita dalle piccole imprese» (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza, 27 giugno 2007, p. 6). È una tesi ostinata che pervade la cultura neo-liberista, sia conservatrice sia liberal, e che sul piano dell’ufficialità trova due interessanti elaborazioni nel Libro Bianco del Governo italiano sul mercato del lavoro del 2001 e nel recente Libro Verde della Commissione europea Modernizzare il diritto del lavoro del 2006.
Sull’ostinazione ideologica di tale postulato teorico mi pare davvero sufficiente rinviare all’ultimo libro di Luciano Gallino (L. GALLINO, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari-Roma, 2007). Perciò non aggiungo nulla alla questione della relazione tra flessibilità e occupazione. Mi limito solo ad osservare che, se avesse ragione la Commissione europea a dire che le piccole imprese avvertono il disagio di una disciplina rigida sul licenziamento, intendendo la rigidità di una tutela come quella dell’art. 18 dello Statuto, allora dovremmo presumere che le imprese italiane con meno di 15 dipendenti possono essere davvero tranquille, dato che ad esse non si applica quella tutela.
L’art. 18, perciò, non si applica quando quell’impresa è il risultato di un’artificiale operazione di frammentazione del ciclo produttivo mediante ambigue cessioni di rami d’azienda o quando si tratta di imprese di un medesimo gruppo (o addirittura di una medesimo proprietario individuale) ancorché inseriti in un unico assetto organizzativo del processo produttivo. Si tratta evidentemente di operazioni giuridico-organizzative finalizzate anche ad eludere i vincoli legali derivanti dallo Statuto dei lavoratori. L’attuale nozione di «unità produttiva», infatti, può «stimolare processi artificiosi di frammentazione organizzativa ed indurre distorsioni della concorrenza fra imprese di pari capacità economica» (M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2005, p. 416). Si deve convenire, dunque, sul fatto che lo Statuto meriti un aggiornamento: se proprio non si vuole generalizzare la tutela reale (generalizzazione negata con argomenti, invero, molto deboli sul piano della legittimità costituzionale), si deve pensare ad una aggiornata nozione di «unità produttiva» cui riferire la soglia dei 15 dipendenti ai fini dell’applicazione dello Statuto, di modo che tale nozione sia rispondente all’assetto organizzativo effettivo e reale del processo produttivo, soprattutto quando tale assetto corrisponde a imprese con forti collegamenti proprietari e – addirittura – talvolta collegate anche fisicamente nel medesimo sito produttivo (per esempio, modificando la nozione di datore di lavoro ai soli fini dell’applicazione dello Statuto).
Ma è anche la distinzione fra causali del licenziamento a meritare qualche osservazione critica. Sostanzialmente, la tesi più accreditata ritiene che si debba distinguere il licenziamento per motivi economici (il giustificato motivo oggettivo) da quello per motivi personali (il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa) sostenendo che si debba prevedere una maggiore libertà di licenziare quando ricorrano motivi economici.
Il punto si fondo è che non è ben chiaro se si deve agire sul controllo del motivo oppure sul regime sanzionatorio. In ogni caso, appare evidente che l’uno e l’altro sono interconnessi: in altre parole, se si prevedesse che in caso di licenziamento per motivi economici dichiarato illegittimo non si dovrebbe ricorrere alla tutela reale (ma solo risarcitoria) vorrebbe dire che il posto di lavoro è comunque perso (come per il regime di tutela obbligatoria). Peraltro, l’argomento innesca un circolo vizioso perché la distinzione fra un licenziamento per motivo economico ed uno per motivo personale non può avvenire se non mediante il controllo del giudice: altrimenti, basterebbe la semplice dichiarazione del licenziamento di tipo economico e così sfuggire ad ogni controllo, anche quando la ragione fosse personale. Ebbene, una volta accettato il controllo giudiziario sulla tipologia di licenziamento, il controllo giudiziario si fermerebbe a questo, potendo decidere se vi deve oppure no essere un risarcimento. Insomma, il controllo del giudice potrà anche essere depotenziato, ma non può sparire del tutto; con buona pace di Alesina e Giavazzi.
La verità è che è proprio questo controllo giudiziario ad essere mal sopportato. La polemica riguarda proprio il controllo eteronomo di una relazione che si ritiene essere puramente mercantile. Dunque, a ben vedere, nella questione sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori si impianta l’intera questione sullo Statuto, come da molto tempo la dottrina più avvertita ha messo in evidenza. Infatti, non da ora si è messo in evidenza che la tutela reale del posto di lavoro è espressione della tutela della dignità della persona nel rapporto di lavoro, al pari di tutti gli altri istituti giuridici posti dallo Statuto (v. per tutti M. D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro, Cedam, Padova, 1979; M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Angeli, Milano, 1980).
Da questo punto di vista, allora, va riconosciuto il merito almeno della schiettezza a chi ritiene che non basta mettere in discussione l’art. 18 ma tutto lo Statuto dei lavoratori. La ragione deve essere trovata nel fatto che lo Statuto si pone l’obiettivo di istituire e regolare il rapporto di lavoro inteso come rapporto sociale e non come rapporto di mercato. Pertanto, chi intravede in un contratto di lavoro una mera relazione mercantile non può che mal tollerare non la regola della relazione di mercato, ma la regola che impone una torsione al quella relazione facendone emergere il valore «sociale».
Perché lo Statuto dei lavoratori è una regola sociale prima che mercantile. Per meglio dire, «lo Statuto dei lavoratori è, per l’appunto, uno strumento per cambiare il potere dentro la fabbrica e, reciprocamente, una prefigurazione normativa del modo operaio di partecipare al governo dell’impresa» (U. ROMAGNOLI, Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche, in Pol. Dir., 1971, p. 538). Questo è il carattere proprio dello Statuto; questo è il carattere differenziale dalle altre e recenti proposte di revisione dello Statuto. Per questa ragione nello Statuto si sancisce la libertà di opinione e il divieto di indagini sulle opinioni e convizioni personali dei lavoratori; si tutela la dignità e riservatezza dei lavoratori da controlli occulti e pervasivi dell’impresa; si vieta ogni comportamento discriminatorio dell’identità personale dei lavoratori, sia in quanto cittadini, sia in quanto lavoratori.
Proprio per quest’ultimo aspetto lo Statuto garantisce in modo particolare la libertà sindacale e promuove l’autonoma organizzazione sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro. l’identità personale del lavoratore è (cioè «coincide con») l’identità collettivo-sindacale; anche quando si manifesta nella libertà negativa di non aderire ad alcun sindacato. Perciò lo Statuto promuove la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro.
Occorre aggiornare lo Statuto? Certamente, occorre aggiornarlo per potenziare e ridare vigore a tali principi, dal momento che alcune di quelle norme ignoravano i nuovi modelli di organizzazione del lavoro e le relative nuove forme di potere di disciplina e controllo del lavoro. occorre, dunque, aggiornare la norma sul controllo a distanza (art. 4), sul personale di vigilanza (art. 3) o sugli accertamenti sanitari (art. 5). Occorre immettere nello Statuto le innovazioni dell’ordinamento giuridico sulla tutela della riservatezza; occorre potenziare l’art. 10 sul diritto allo studio dal momento che il lavoro di qualità esige formazione e sapere dei lavoratori. Occorre infine anche modificare l’art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali. Non è questo il luogo per affrontare un tema così impegnativo; ma è ormai evidente da tempo che occorre un intervento legislativo in grado di dare una più incisiva regolazione giuridica alle forme di selezione delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.
Insomma, il destino dello Statuto dei lavoratori non è ancora scritto. Quel che si può dire è che la contesa non è tanto di tecnica giuridica quanto di politica del diritto e legislativa; e, su questo piano, non è tanto fra innovatori e conservatori quanto fra diverse concezioni dell’innovazione. Nella consapevolezza di riconoscere che ci sono importanti sfumature e articolazioni di posizioni, al fondo, si tratta di una contesa fra chi vuol annichilire e chi potenziare la natura democratica dello Statuto dei lavoratori.