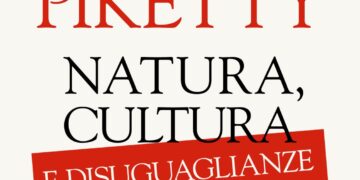“Nonostante Hobbes. Lavoro, antropologia, democrazia” di Laura Pennacchi, edito da Castelvecchi, è un libro stupendo. Quando ho chiuso l’ultima delle 191 pagine, mi è venuta in mente la definizione che avevo dato, controcorrente, dei primi Diari pubblicati di Bruno Trentin e che tanto era piaciuta alla moglie Marcelle “Marie” Padovani: “uno scrigno scomodo”. Certo, non parliamo di una lettura da ombrellone. Il solo ricchissimo, aggiornatissimo e internazionale apparato bibliografico ne fa un contributo inestimabile. Laura Pennacchi, economista, più volte eletta in Parlamento, sottosegretaria al Tesoro con Ciampi nel primo governo Prodi, ci ricorda che per decenni, anche a sinistra, si è accolto con entusiasmo l’annuncio della “fine del lavoro”, resa possibile dai progressi tecnologici. Oggi che questa stagione appare definitivamente (e fortunatamente) tramontata, occorre, per dirla sempre con Bruno Trentin, ricercare non “la libertà dal lavoro”, ma la “libertà nel lavoro”. Un lavoro che torna cruciale per la formazione e l’affermazione delle identità e delle soggettività, pur nella necessità, oggi, di continuare a ripensarne il significato, a partire dalla rilevanza cooperativa ed emancipatoria. Il libro di Pennacchi mette in discussione la cupa antropologia ereditata da pensatori come Machiavelli e Hobbes e propone, al contrario, un’antropologia che, recuperando anche il migliore pensiero femminista, esalta la creatività e ci accompagna nella piena realizzazione personale, collettiva e relazionale, anche salvaguardando, nella crisi di questi tempi bui, lo sviluppo della democrazia. Di seguito, una conversazione con Laura Pennacchi a proposito della ultima opera.
“Nonostante Hobbes” è un libro prezioso, quanto complesso. Apparentemente controcorrente, visto il contesto economico, politico e sociale complessivo. Come e perché nasce l’idea del libro?
L’idea del libro mi era venuta, per la verità, già da molto tempo. L’avevo sempre un po’ spinta indietro nella mia mente. Il fatto decisivo per riprenderla sono state le guerre: questa strana giustificazione, portata nemmeno in modo troppo esplicito, ma data assolutamente per scontata, che le guerre stesse siano un portato naturale della vita umana sul pianeta. Mi trovavo di fronte alla desolazione delle guerre e alla devastazione da esse provocata. Ho ripensato anche alle molte distruzioni che hanno preceduto i conflitti e che si sono espresse soprattutto con assetti economici molto poco favorevoli, quasi negatori rispetto all’espressione della dignità umana. Penso soprattutto al lavoro. Ho quindi ritenuto che stia montando una questione antropologica, come molti riconoscono, soprattutto nel mondo religioso, ma anche in un mondo laico che guarda alla spiritualità con grande interesse. In particolare Papa Francesco aveva indicato i termini di una nuova questione antropologica affermando: “questa economia uccide l’umanità”. Mi è venuto l’impulso di cercare, di mettere in evidenza dei substrati logici e filosofici che si sono consolidati nel tempo nelle nostre coscienze e che sono quasi diventati luoghi comuni. Tali substrati, a mio parere, risalgono addirittura ad antecedenti filosofici maturati negli anni che hanno visto l’affermazione della riforma protestante, ma anche in precedenza. Io li attribuisco soprattutto a Machiavelli e a Hobbes, da qui il titolo del libro.
Machiavelli, soprattutto in Italia, è considerato un autore criticare il quale significa compiere azioni di lesa maestà, è lo scrittore italiano più tradotto e più letto nel mondo. Hobbes viene considerato il padre della scienza e della teoria politica moderne rispetto al sistema dell’evoluzione degli stati assoluti e delle fasi successive. Appare veramente controcorrente sia discutere Machiavelli e Hobbes, sia contestare quei principi di Machiavelli e Hobbes che sono diventati quasi senso comune. Parlo dell’idea dell’intrinseca malvagità, naturale, innata dell’essere umano. Afferma, infatti, Machiavelli, e lo dice in particolare ai politici: “dovete sempre presupporre la malignità umana”. Per lo scrittore fiorentino la prima cosa che il principe deve imparare è mentire e presupporre che gli esseri umani siano sempre pronti al male. La malvagità naturale, innata, intrinseca dell’essere umano in Hobbes viene anche teorizzata come homo homini lupus, sotto un’accezione ancora più violenta. Tutto ciò reca alla base la presupposizione di un egoismo comportamentale, anche questo innato o intrinseco, la pulsione all’utilitarismo, un’esistenza individualistica assoluta. Hobbes critica Aristotele, per lui non aveva capito niente, ritiene falso il suo assioma dello zoon politikon, dell’uomo essere sociale intrinsecamente tale. Questi presupposti agiscono talmente quasi all’insaputa, come direbbe Elster, degli agenti economici quando in realtà sono, sia dal punto di vista empirico che dal punto di vista teorico, assolutamente criticabili e contestabili. Tali presupposti non appaiono fondati, sono proiezioni ideologiche di immagini dell’essere umano e dunque del suo vivere. Esistono, in realtà, più Machiavelli, come, del resto, più Hobbes. La differenza tra i vari Machiavelli è più marcata. In Machiavelli, a un certo punto, c’è uno spirito repubblicano che viene affermato, ma gli elementi di fondo non vengono mai smentiti. In Hobbes tutto è molto più chiaro: la politica si basa sul dominio, sulla violenza, sulla sopraffazione. Da qui anche la legittimazione della guerra come impulso atavico permanente. Da tutto questo groviglio di pensieri nasce il ragionamento che ha portato al libro.
È davvero giunta al termine la “strana stagione di esaltazione della fine del lavoro”? Come può il lavoro ritornare al centro di una nuova soggettività, allo stesso tempo, emancipante e relazionale?
Sostengo che tutti questi discorsi sono iniziati già negli anni ‘90 con André Gorz e poi hanno raggiunto un apice in Rifkin, che ha scritto, nel 1995: “La fine del lavoro”. Il volume è uscito proprio negli anni in cui avveniva una moltiplicazione delle forze di lavoro a livello mondiale per l’ingresso della Cina nell’agone internazionale. Rifkin non ha mai fatto autocritica. Ci sono stati vari gruppi di pensiero, ad opera, per esempio, della Scuola di Francoforte, con Axel Honneth e Rahel Jaeggi, ma anche gruppi di francesi come quelli legati a Deleuze, che, come altri che hanno dato vita addirittura a nuove discipline come la psicodinamica del lavoro, hanno studiato con rinnovato interesse proprio le questioni del lavoro. Il problema enorme che abbiamo di fronte e che abbiamo avuto nel ventennio passato non è tanto che il lavoro finisca, ma è che il lavoro viene frantumato, spezzato. C’è una dicotomia tra una componente ad altissima qualificazione e salari, che è sempre più esigua, e una grande massa. Qualcuno ha usato, addirittura, l’espressione plebe, che Hegel aveva utilizzato nell’Ottocento con grande riprovazione di quello che stava allora accadendo. La domanda esige una risposta che tenga conto del fatto che questi ricorrenti tentativi di dire che il lavoro è finito, il lavoro non conta più per le persone, ci sono ancora oggi. Basta pensare, per esempio, alla questione delle c.d. “grandi dimissioni” che ci sono state dopo il Covid 19, subito utilizzate per sostenere questa falsa affermazione. Secondo queste interpretazioni la gente odia il lavoro, non vuole più lavorare. Non si ha mai, peraltro, un’indicazione su come si vivrebbe completamente senza lavoro, anche in senso materiale, cioè con quale reddito, con quali risorse. Manca una riflessione seria sul significato che avrebbe una vita spogliata del lavoro, una nuda vita, come diceva Foucault.
Porterebbe davvero la felicità? Io non credo proprio. D’altro canto è vero anche che riprendono vigore dei tentativi che datano molto più indietro nel tempo. Addirittura al ‘68 e agli anni successivi in cui si affermava che è importante liberarci dal lavoro. Liberazione dal lavoro, non del lavoro. Questi temi sono stati molto presenti nelle formazioni di estrema sinistra e rimangono sempre filoni di pensiero vivi. C’è poi tutto il filone del basic income che ha origini molto più liberali. La fase attuale, però, mi pare, come scrivo nel libro, un tempo in cui si torna a pensare in modo forte e autorevole alla centralità del lavoro.
Quali sono gli aspetti principali da rimettere in discussione per l’affermazione di una: “nuova questione antropologica”? Quali le priorità, i punti di forza e i punti di debolezza?
Penso che sia fondamentale rimettere in discussione quei postulati indimostrati di cui parlavo all’inizio. Questa è un’operazione che va compiuta soprattutto sul piano delle coscienze, dei comportamenti primari. C’è una grande opera di demistificazione da compiere. In parte io lo l’ho tentata riprendendo, per esempio, una straordinaria opera di antropologia: “L’alba di tutto”, scritta da David Graeber, antropologo, e David Wengrow, fondatore, tra l’altro, di Occupy Wall Street. Un libro veramente bellissimo che cito abbondantemente nel mio e che è un testo voluminoso perché rappresenta una storia dell’umanità. In “L’alba di tutto”, per esempio, documentano, come hanno fatto altri antropologi, anche studiando le popolazioni primitive che ancora vivono nel pianeta, che la guerra non è un istinto primario. La guerra come struttura organizzata, non come scaramuccia: il conflitto, come è ovvio, c’è sempre. La guerra sembra essere comparsa soltanto 10.000 anni fa: la lunghissima storia di formazione dell’umano non aveva con sè la guerra incorporata, come dimostrano peraltro molti documenti e fatti empirici. Penso a studiosi che svolgono tantissimo lavoro di ricerca sul campo, per esempio Michael Tomasello, che ha scritto opere molto importanti. Mi è piaciuto molto un suo testo divulgativo che è stato pubblicato anche in Italia e che ha questo significativo titolo: “Altruisti nati”, perché cooperiamo fin da piccoli. Non si tratta solo del celebre discorso sui neuroni specchio, è qualcosa di più profondo, nel quale Tomasello, per esempio, documenta l’attitudine alla cooperazione che si riscontra nei bambini piccolissimi, addirittura prima dell’anno di vita. Alcuni psicologi studiano questi processi evolutivi. La scuola di Jean Piaget, attiva negli anni ’50 e ’60, è importantissima per tutti questi temi. Per molti è in realtà l’altruismo che precede l’istinto alla cooperazione, con un riconoscimento di modalità comportamentali e di regole. Dalle regole nascono le istituzioni. È molto importante diffondere questi filoni che vanno dall’antropologia alla psicologia, all’economia comportamentale critica dell’economia neoclassica. Filoni che manifestano, sia empiricamente che teoricamente, che in realtà c’è tutto un percorso diverso che ci tiene in vita e che ci porta e che ci ha portato, fino a questo punto, alla maturazione dell’umano, all’essenza umana. Tutto questo richiederebbe un grandissimo lavoro anche di educazione pedagogica: non un’educazione pedagogica tirannica, ovviamente, ma l’esercizio alla comprensione della tendenza intrinseca alla relazionalità umana. Una volta questo esercizio pedagogico veniva svolto dai partiti politici e dai sindacati, già nel loro strutturarsi organizzativo. Penso anche alla scuola operaia di cui si era fatto interprete Giuseppe Mazzini nell’Ottocento. Questi aspetti sono stati molto importanti anche nel primo socialismo e nella prima parte del secondo dopoguerra, ma oggi sono andati un po’ perduti e dovrebbero essere recuperati. Va combattuta una battaglia a viso aperto, penso al filosofo Vittorio Possenti, che ha costituito un’associazione dedicata alla persona e ha lanciato un manifesto incentrato proprio sulla riscoperta della persona umana.
Nel libro appare fondamentale, in più ambiti, la ripresa della centralità del lavoro. Lei afferma che: “senza democrazia del lavoro, senza la democrazia mediante il lavoro, la lotta per la democrazia è perduta“. Possiamo approfondire il rapporto tra democrazia economica e democrazia politica, alla luce degli assunti del volume?
Questo è il percorso più lungo e specifico che il volume offre. L’elemento rilevante sta nel seguente punto di partenza: senza una rivitalizzazione della democrazia nel lavoro e del lavoro la battaglia per la democrazia oggi è perduta. Ciò anche per quello che la lunga fase neoliberista ha imposto. Questa fase sembra avvalorare proprio le descrizioni che Hobbes compie dello stato di natura e della massimizzazione dell’interesse come unico movente dell’attività economica, che è la base peraltro della teoria degli shareholder, la quale a sua volta è fondamento della tremenda trasformazione dell’impresa. Non c’è stato solo un danno sul lavoro, c’è stato anche un danno sull’impresa, che è stata trasformata in un mero organo per la creazione di valore per gli azionisti e per i manager, sottraendola alla sua finalità precipua che è di essere un attore dell’economia reale. L’impresa diventa, invece, un attore dell’economia finanziaria: da questo punto di vista ci sono stati danni immensi. Riconoscerli offrirebbe una grande occasione per ristabilire equilibri capitale/lavoro più adeguati e più simili a quelli che si riscontravano nei “trent’anni gloriosi” quando il compromesso socialdemocratico/keynesiano aveva prodotto risultati rilevanti, pur con diverse mancanze. Teniamo presente, inoltre, che in Germania o nei Paesi scandinavi il rapporto capitale lavoro era già allora molto più avanzato. Oggi sta ormai venendo alla luce l’esaurimento del modello neoliberista che, per riprodursi, cerca fertilizzazione con il populismo, l’autoritarismo, la xenofobia, che a loro volta danno luogo a attacchi alla democrazia liberale, configurandosi come istanze democratiche illiberali. Tutto ciò è un paradosso assoluto e insostenibile. Non possiamo dimenticare le grandi trasformazioni tecnologiche, legate oggi soprattutto all’intelligenza artificiale e la grande ridefinizione degli equilibri geopolitici mondiali nei quali l’Europa non potrà sopravvivere adeguatamente se non cambia radicalmente il suo modello di sviluppo. Penso soprattutto alla Germania e all’Italia, ma ciò vale davvero per tutto il continente. Il modello di sviluppo non può più essere concentrato solo sulle esportazioni che rendono i Paesi molto esposti alle rappresaglie sui dazi che Donald Trump sta portando avanti. Le economie europee devono basarsi molto di più sulla domanda interna, sui beni comuni, sui beni sociali. Tutto questo richiede un apporto partecipativo e un dialogo democratico delle forze del lavoro, dei sindacati, delle associazioni di volontariato. Va ricostruito un dialogo che non sarà privo di conflitti, ma produttivo e creativo, anche con le tante piccole imprese che appaiono disposte a un grande cambiamento di paradigma.
Oggi ci troviamo di fronte alla crisi profonda del diritto internazionale, alla prepotente ripresa di centralità della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, all’esplosione delle disuguaglianze e all’inerzia crescente rispetto alla catastrofe climatica, Come è possibile affermare, come Lei fa all’inizio del terzo capitolo del libro, che il dolore, la sofferenza, l’angoscia non sono altrettanto fondative della vita umana quanto la gioia, la felicità, la speranza?
Faccio questa affermazione partendo soprattutto dalla mia esperienza personale e dall’osservazione dell’esperienza di tutti. Credo che non ci sia nessuno che se viene interrogato su cosa contraddistingua la propria essenza di essere umano, pur nel dolore e nella sofferenza che sono sempre presenti, non prediliga la gioia, la speranza, la sollecitudine verso gli altri come fattori realmente identificativi. Miliardi di persone sul pianeta non potrebbero vivere se non ci fosse questa spinta primaria. Possiamo osservare questa spinta primaria perfino nell’interazione tra vivente umano e vivente biologico, animale e vegetale. L’interazione nel vivente è talmente forte che non possiamo non essere indotti a ripensare all’affermazione di Spinoza: “Deus sive natura”, per la grande, potente forza spirituale che c’è in tutta la natura stessa. Certo, non possiamo non osservare il contrasto di tutto ciò con le guerre e la lesione del diritto internazionale. Questo contrasto nasce dal fatto che c’è stata un’evoluzione sorprendentemente positiva verso la democratizzazione del mondo e verso un diritto internazionale più equo e più articolato. Pensiamo ai progressi incredibili che tutta l’umanità ha fatto dall’Ottocento alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948. Progressi immensi che non sono solo formali se osservati anche dal punto di vista empirico. Passi avanti innegabili persino oggi che siamo di fronte alle allucinanti guerre in Palestina e in Ucraina e anche in altri scenari. Ci sono studi che ci dicono che la reazione offensiva basata sulle guerre è appunto una reazione al fatto che il processo di democratizzazione è andato estremamente avanti. Ci sono studi importanti basati sulle idee di Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, degli economisti e degli storici economici del c.d. “sistema mondo”. Ad esempio Giovanni Arrighi, scomparso ormai da tempo, aveva scritto e dimostrato che, fino al 2007-2008, gli avanzamenti democratici erano stati straordinari, comprendendo anche la Cina. Arrighi era un grande conoscitore della Cina, ricordo il suo libro interessantissimo: “Adam Smith a Pechino”. Questa teoria interpreta la turbolenta fase odierna come l’estremo tentativo di farci tornare indietro da punti molto avanzati di cui dobbiamo avere consapevolezza. Se combattiamo questo tentativo con consapevolezza, io penso che saremo nelle migliori condizioni per smascherarlo e vincerlo.
Un’ultima domanda. Lei riflette sulla differenza tra potere (o meglio “potere per”) e dominio (“potere su”). Con quali forme, strumenti e priorità è possibile valorizzare collettivamente, attraverso il lavoro, un “potere cooperativo”, rispetto al “potere come violenza”?
Qui c’è tutto un campo che va esplorato nel futuro. Non posso dare risposte esaustive, certamente vanno riattivati e mobilitati tutti gli strumenti della partecipazione democratica. Dal voto a tante attività intermedie che possono essere messe in campo a partire dal ripristino delle funzioni integrali degli attori della cosiddetta mediazione sociale che a lungo, anche a sinistra, è stata, invece, criticata. Negli anni passati abbiamo letto di elogi della disintermediazione: impostazioni assolutamente sbagliate che vanno criticate e messe completamente da parte. C’è poi tutto il discorso sugli strumenti della partecipazione, c’è una grande riflessione da compiere sulla trasformazione anche degli Stati e dell’ambito pubblico. Tutto il ragionamento che svolgo porta a una grande rivalutazione delle strutture, delle istituzioni pubbliche, anche statuali. Non possiamo, ovviamente, tornare al vecchio statalismo, dobbiamo cercare ed esplorare quello che alcuni studiosi chiamano “sperimentalismo istituzionale” e ritrovare istituzioni differenti. Dobbiamo basarci molto sui territori, non puntare soltanto sulle strutture centralizzate, puntare molto sull’interazione. Non dobbiamo demonizzare le nuove tecnologie, ma dobbiamo imparare ad usarle, anzi dobbiamo inventarne di nuove coerenti con i nostri fini. Dobbiamo dare vita, curare i beni sociali e i beni comuni. Penso, per esempio, a tutte le aree interne che vanno recuperate assai più di quanto non abbiamo fatto finora, le nuove tecnologie ci possono aiutare anche da questo punto di vista. Più al fondo c’è in me una ricerca che ho appena abbozzato e che spero qualcuno voglia continuare.
Nel libro ho molto criticato di Hannah Arendt la svalutazione del lavoro, la svalutazione dell’anima al lavoro. L’ho criticata e continuo a criticarla proprio perché credo, invece, a una nuova centralità del lavoro. Vi credo nei termini che usava Marcuse negli anni ’30 del Novecento, anche positivamente condizionato dalla lettura dei manoscritti economico-filosofici del giovane Marx, che erano stati appena pubblicati. Marcuse parla del lavoro come ciò che fa accadere l’esistenza, accetta un quadro trascendentale di tipo kantiano agli antipodi proprio della riflessione di Hannah Arendt. Seguo, però, anche il suggerimento di un grande filosofo dell’esperienza del pragmatismo americano: Richard Rubenstein. Egli riconosce che la Arendt ha moltissimo da insegnarci rispetto alla visione della sfera democratica e del potere. Hannah Arendt giustifica, infatti, il potere soltanto se esprime un amor mundi, l’amore per il mondo. Ciò è proprio all’opposto del potere come violenza, come sopraffazione, come dominio. Insomma l’opposto di Machiavelli e Hobbes, per tornare a tutto quello da cui siamo partiti…
Francesco Lauria
Laura Pennacchi, Nonostante Hobbes. Lavoro, antropologia, democrazia. Castelvecchi, Roma, 2025, pp. 202, euro 25.