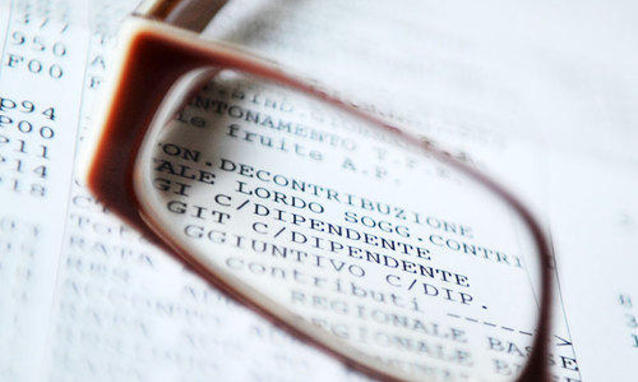In un momento di gravi tensioni geopolitiche, dove la ricchezza e l’accesso al cibo sono sempre più ad appannaggio di una parte minoritaria del mondo, il lavoro di chi produce cibo di qualità e nel rispetto dell’ambiente deve essere tutelato nei salari e nei diritti. Così Andrea Coinu, responsabile delle politiche internazionali della Flai-Cgil e neo eletto presidente dell’Assemblea sindacale mondiale dell’agricoltura. Ci preoccupano, spiega, le distorsioni che il trattato del Mercosur potrebbe innescare e la mancanza di contromisure. La Pac, dice Coinu, deve tutelare i lavoratori e i piccoli produttori dal dumping produttivo e sociale.
A che punto sono le trattative per il Mercosur?
Le trattative per l’attuazione del Mercosur si stanno spostando al livello locale, dove i singoli paesi definiranno le clausole di salvaguardia per rendere operativo l’accordo. Saranno poi sempre i singoli stati che dovranno verificare che i prodotti importati dall’America Latina rispettino gli standard qualitativi.
C’è stato qualche tipo di dialogo con il sindacato?
Non è mai stata avviata, sin ora, nessun tipo di interlocuzione.
Qual è il vostro giudizio sul trattato?
Noi non siamo contro l’accordo a prescindere ma sin da subito abbiamo evidenziato delle criticità che non devono essere trascurate.
Quali?
La prima è di carattere sociale, sindacale e ambientale. La nostra paura, condivisa anche con i sindacati dei paesi del Mercosur, è che l’accordo possa portare a un’ulteriore compressione dei diritti dei lavoratori, a liberalizzare maggiormente il mercato a discapito delle tutele. Tutti i prodotti agricoli che arriveranno dal Sud America devono rispettare il lavoro delle persone e l’ambiente. E su questo, al momento, non abbiamo garanzie. Temiamo che con il Mercosur si distrugga quel tessuto economico sorretto dai piccoli produttori a vantaggio del latifondo e delle multinazionali, accrescendo le diseguaglianze nella redistribuzione della ricchezza. Ma ci preoccupa anche l’impatto che può avere sull’agricoltura italiana ed europea. I lavoratori e i produttori delle zone rurali interne rischiano di pagare il prezzo più alto. E anche le parole della premier Meloni ci mettono ancor più in allarme.
Perché?
La presidente del Consiglio ha detto che qualora dovessero emergere delle problematiche avvierebbe un confronto con i rappresentanti delle imprese per pensare a un piano di ristori verso i produttori. In questo modo Meloni mette già le mani avanti perché ipotizza dei rischi ancor prima della piena messa in atto dell’accordo. In seconda battuta nel suo orizzonte manca qualsiasi dialogo con il sindacato e, infine, i ristori sarebbero del tutto inefficaci. L’impatto delle produzioni sud americane può essere potenzialmente devastante e questo richiede di rivedere tutte le filiere e un nuovo modello produttivo. Con solo dei ristori è come pensare di svuotare il mare con un cucchiaino.
L’accordo comporterà dei vantaggi economici per l’Italia e l’Europa?
Le stime dell’Italian Trade Agency, che è un organo istituzionale, dicono che il guadagno massimo per la nostra economia si potrà avere solo nel 2036, con una cifra intorno ai 3 miliardi. Negli anni precedenti sarà molto inferiore se non nullo. Per tutta la comunità europea le stime parlano di 30-60 miliardi nel biennio 2035-2036. Questi numeri ci dicono che il ritorno economico è del tutto irrisorio e non compensativo delle perdite che avremo a causa dei dazi Usa. A spartirsi questa piccola torta sarebbero, poi, solo alcuni settori. Prima fra tutti la chimica e la meccanica.
I prodotti del nostro agroalimentare possono avere un ruolo?
Pensare, come spesso facciamo, che tutti sono desiderosi di consumare il parmigiano, l’olio o i vini nostrani è una supponenza culturale che esclude il fatto che gli altri paesi non abbiano i propri formaggi o i propri vini. Poi bisogna guardare anche la capacità di spesa di ogni mercato. Il Pil medio pro-capite di Brasile e Argentina non supera i 12mila dollari. La riforma agraria di Lula di inizio anni Duemila ha tolto dalla povertà quasi 50 milioni di persone, un quarto della popolazione brasiliana. È impensabile che nel giro di vent’anni ci sia stato un progresso economico e sociale così impetuoso da permettere alla maggior parte della popolazione di acquistare una bottiglia di vino italiano o un’auto tedesca. Se in Italia si aumentassero i salari e si rafforzasse così la domanda interna la nostra economia non avrebbe sempre bisogno dell’export come valvola di sfogo.
Quindi perché abbiamo ratificato questo accordo?
Credo per una motivazione più di carattere geopolitico. Si tratta di un tentativo di rispondere ai dazi e di fare vedere che l’Unione europea non è chiusa in un angolo ma che è capace di diversificare.
State portando avanti un lavoro congiunto con i sindacati dei paesi sud americani per tutelare i lavoratori dagli effetti distorsivi del Mercosur. Ma le chiedo come è possibile coordinare un’azione sindacale unitaria, in aggiunta transnazionale, in un settore di forte concorrenza, dove probabilmente ogni stato del Mercosur cercherà di contendere all’altro una fetta del mercato europeo?
Ovviamente la concorrenza c’è ed è presente in ogni settore e ci sarà anche tra i paesi europei verso i mercati dell’America Latina. Quello che vogliamo evitare è che a certe criticità se ne aggiungano altre. Il presidente argentino Milei ha parlato di ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro. Inoltre mentre l’Europa non ha dazi verso questi paesi esistono, invece, barriere doganali all’interno del Mercosur. E proprio per rendere i propri prodotti più appetibili gli stati potrebbero intraprendere una corsa al ribasso dei diritti e delle tutele sociali e ambientali. Non dobbiamo, infine, dimenticare che ci sono filiere ormai consolidate per cui il mercato apprezza le carni bovine argentine così come l’industria avicola brasiliana ne fa da padrona.
In questo scenario quali devono essere, secondo lei, le priorità della nuova Pac?
La guerra in Ucraina ha portato un grande cambiamento, ma dobbiamo pensare che ritornerà a essere un produttore a basso costo di prodotti agricoli. Ci sono poi i beni che importiamo dall’area del Mercosur. Nel 2025 si stimano 300mila tonnellate di carni bovine e avicole principalmente da Brasile e Argentina. È chiaro che tutte queste produzioni creeranno un dumping al ribasso sulle nostre. Il 70% delle risorse della Pac viene destinato al 20% delle imprese. È un paradigma che va cambiato. I lavoratori e i piccoli produttori sono i soggetti che devono beneficiare delle tutele maggiori perché più esposti alla concorrenza.
Quali sono le sfide che l’Assemblea mondiale dei lavoratori agricoli è chiamata a governare?
C’è una profonda relazione tra gli innumerevoli scenari di guerra e le condizioni di lavoro nei campi. I conflitti accrescono le diseguaglianze e polarizzano l’accesso ai beni primari. Non possiamo più tollerare l’opulenza e lo spreco di cibo, oltre il 30%, nelle aree più ricche del mondo, mentre 800 milioni di persone soffrono la fame e 200mila muoiono per i pesticidi nei campi, senza contare quelle dovute agli effetti del caldo e dello sfruttamento. L’agricoltura è l’unico comparto economico dove la ricchezza sta a margine della filiera produttiva, nei macchinari, nella chimica, nelle tecnologie produttive e nella trasformazione e rivendita dei prodotti, ma mai nel benessere e nel salario dei lavoratori. Serve una nuova visione internazionale del ruolo degli operai agricoli e dei piccoli produttori e un nuovo modello globale. Dobbiamo combattere l’agricoltura estrattiva che sfrutta le persone e l’ambiente, e promuovere l’idea che si può produrre cibo e benessere diffuso in maniera sana, sostenibile e democratica. Chi garantisce la salute alimentare e la tutela dell’ambiente deve vedere riconosciuto il proprio peso.
Tommaso Nutarelli