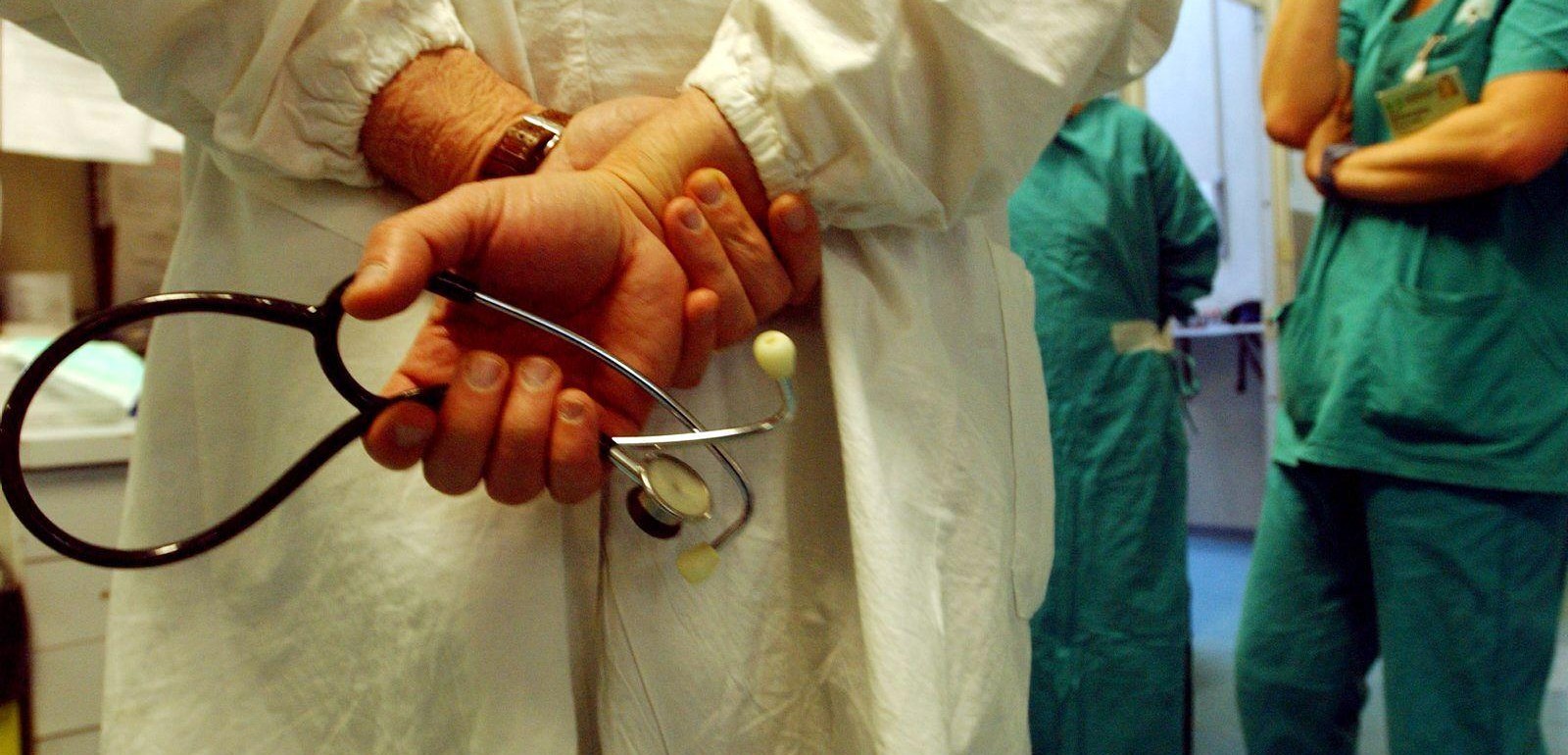L’anno in corso ha segnato un passo avanti significativo nella tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e, più in generale, da malattie croniche o invalidanti.
Le recenti iniziative legislative — insieme a un’evoluzione giurisprudenziale sempre più attenta alla dimensione umana della malattia — delineano un sistema che mira a porre la persona al centro del rapporto di lavoro, non solo nella fase della cura, ma anche in quella del rientro e della reintegrazione sociale e professionale.
In questa prospettiva, l’obiettivo generale sembra essere quello di costruire un diritto del lavoro realmente orientato al principio di uguaglianza sostanziale.
Tra le novità di maggior rilievo dell’ultimo biennio figura l’introduzione del diritto all’oblio oncologico. L’obiettivo normativo è quello di superare il pregiudizio legato alla pregressa malattia, restituendo pienamente dignità e parità di trattamento a chi ha concluso il percorso terapeutico. La legge n. 193/2023 e i relativi decreti attuativi riconoscono infatti alle persone guarite da una patologia oncologica il diritto a non essere discriminate nell’accesso a servizi e opportunità — quali servizi bancari, finanziari e assicurativi, adozioni e affidamenti, nonché nell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale — a condizione che non si siano verificate ricadute e sia trascorso un determinato periodo dalla conclusione delle cure, variabile in funzione dell’età e del tipo di tumore.
In questa direzione si colloca anche il recente intervento legislativo approvato in via definitiva dal Senato a luglio 2025 (Legge del 18 luglio 2025, n. 106), che introduce una serie di misure mirate a rafforzare la protezione dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche, con particolare riferimento al profilo lavorativo.
Tra le disposizioni più significative figura il congedo straordinario – aggiuntivo rispetto alle misure già esistenti – non retribuito, della durata massima di 24 mesi, anche frazionabile, per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, con invalidità pari o superiore al 74%. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto, ma non la retribuzione, né può svolgere altre attività lavorative. Inoltre, il periodo non è utile ai fini pensionistici, ma può essere riscattato mediante versamento volontario di contributi.
La normativa intende altresì favorire un rientro graduale e sostenibile, evitando un brusco reinserimento lavorativo dopo periodi di assenza prolungata, valorizzando la flessibilità organizzativa come strumento di tutela della salute e di conciliazione tra vita e lavoro. Per tale ragione, al termine del congedo, al lavoratore è riconosciuto il diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile, qualora le mansioni lo consentano.
Rispondendo a esigenze molto sentite dai lavoratori, sono inoltre introdotte dieci ore aggiuntive di permesso retribuito annuo per esami, terapie e visite mediche, cumulabili con quelle già previste, sia a favore della persona interessata, sia a favore di chi assiste un minore affetto da patologie oncologiche o croniche o invalidanti che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Un’importante novità riguarda anche i lavoratori autonomi che svolgono attività in forma continuativa ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Per questi è prevista la possibilità di sospendere l’attività fino a 300 giorni per anno solare. Si tratta di un riconoscimento importante, poiché si estende la logica della tutela ben oltre le maglie del lavoro subordinato.
Nonostante l’indubbio valore di queste novità, la tutela offerta appare ancora insufficiente sotto il profilo sostanziale. Si tratta di un palliativo che lascia irrisolto il problema centrale: la necessità di una copertura economica adeguata e stabile, che garantisca un sostegno equivalente alla retribuzione e alla contribuzione nei periodi di cura o convalescenza prolungata, al fine di evitare che la malattia si traduca in marginalità economica e sociale.
In altri termini, il diritto al lavoro rischia di rimanere incompiuto se non accompagnato da un diritto effettivo — anche in termini di durata, poiché la malattia non è prevedibile — al sostegno del reddito nei momenti di maggiore vulnerabilità.
Altrettanto problematica appare la soglia, decisamente elevata, di invalidità fissata al 74% che rischia di escludere una parte significativa dei potenziali beneficiari.
Accanto alla normativa statale, la contrattazione collettiva e gli accordi aziendali possono ampliare la tutela dei lavoratori fragili, offrendo così un rimedio aggiuntivo.
L’istituto delle ferie e dei permessi solidali, disciplinato dal D. Lgs. 151/2015, consente ai dipendenti, su base volontaria e a titolo gratuito, di cedere ferie e permessi non goduti a colleghi che ne abbiano necessità per gravi motivi di salute o per assistere familiari malati.
Il legislatore ha lasciato ampio spazio alla contrattazione collettiva che, come avvenuto per il CCNL Metalmeccanici Industria, ne ha esteso la portata, prevedendone l’utilizzo, ad esempio, anche per “altre situazioni di grave necessità personale o familiare”.
Questa estensione testimonia come la solidarietà interna possa divenire un pilastro complementare alla tutela normativa, promuovendo un modello d’impresa socialmente responsabile e attenta al benessere collettivo.
Roberta Toschi – Avvocato di CBA Studio Legale e Tributario