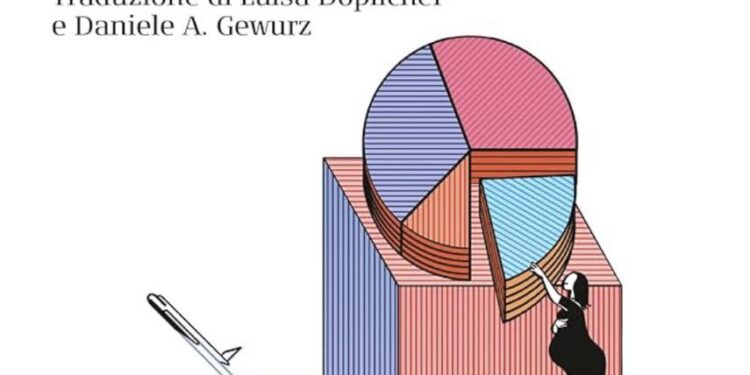Non passa ormai giorno senza che un nuovo report ci avvisi sull’entità e la gravità della crisi demografica e delle sue ripercussioni sul nostro paese. Ultima in ordine di tempo, la memoria depositata la scorsa settimana dall’Inapp presso la Commissione di indagine parlamentare sulla denatalità: dove si avverte della prossima perdita di oltre 6 milioni di lavoratori a causa dell’uscita dei baby boomers dal mercato del lavoro, senza che nuove forze giovani siano disponibili per sostituirli. Ma questo non è accaduto all’improvviso, e non riguarda soltanto l’Italia: è un fenomeno che data ormai parecchi anni, anche se ora sta accelerando esponenzialmente, e che, soprattutto, coinvolge più o meno tutto il mondo. Per capirne le cause e le origini, ma soprattutto per buttare un occhio sul panorama complessivo che ci aspetta da qui a pochi anni, è utilissima la lettura del saggio firmato da Paul Morland, ricercatore presso il Birkberck College University of London, dal titolo “L’umanità di domani. Dieci numeri per comprendere il nostro futuro”.
In realtà i numeri forniti da Morland sono ben più di dieci: nelle 288 pagine del saggio-inchiesta, corredate da un poderoso apparato di note, l’autore traccia una vera e propria “carta geografica del futuro”, per orientarsi “nel mondo che verrà, attraverso la lente degli sviluppi demografici e dei flussi di popolazioni che lo caratterizzeranno’’. Il valore, e la novità, del libro, e’ appunto che affronta il problema demografico a 360 gradi, sia dal punto di vista geografico, spaziando dall’Occidente all’Oriente, dall’Europa all’Africa, dagli Usa all’Asia, sia in tutte le possibili implicazioni che la denatalità, unita all’invecchiamento, potrà avere non solo sul mercato del lavoro, ma sull’intera struttura delle società, intervenendo e modificando la cultura, la struttura delle famiglie, i rapporti interpersonali, la politica, la religione, le leggi, eccetera.
Ed è proprio questo il maggior pregio del lavoro di Morland: forse proprio perché un demografo puro, non si limita a riportare le solite percentuali di fecondità e proiezioni di quanti saremo o non saremo di qui a dieci, venti, cinquant’anni, ma mostra il nesso tra molti fatti solo apparentemente estranei al tema demografico e la demografia stessa, evidenziandone i collegamenti e le conseguenze.
Quella che con termini tecnici e dunque neutri viene definita ‘’transizione demografica’’, è infatti, una rivoluzione di enorme portata che modificherà l’umanità in modi fin qui mai sperimentati. Anche perché l’invecchiamento delle popolazioni, che va di pari passo con la riduzione dei giovani, influenza le società in modi insospettabili. Una società di ‘’vecchi’’ non fa le rivoluzioni, ma punta a mantenere lo statu quo. E questo può significare che un paese anziano finisca per tenersi governi non democratici o autoritari, non avendo sufficienti forze giovani per ribaltarli. Più un paese è anziano, insomma, più finisce per essere ‘’stabile’’, a prescindere dalle forme dei suoi governi. Ma diventano più rare anche le ‘’rivoluzioni’’ culturali, l’innovazione, la sperimentazione. In parallelo, si spopolano i territori, vengono abbandonati i piccoli centri, col risultato che si degradano le infrastrutture, rendendoli sempre meno abitabili; si svuotano le campagne, e di conseguenza aumenta la fauna selvatica: “nel nord del Giappone gli avvistamenti di orsi sono raddoppiati in un solo anno”. E non è un fenomeno dovuto alla generale tendenza mondiale all’urbanizzazione, perché, annota Morland, ‘’in Nigeria le campagne non si stanno svuotando, nonostante le città si riempiano’’.
Ed è anche interessante constatare, dati alla mano, come il fenomeno della denatalità inizi, ovunque, per la stessa ragione: e cioè il percorso di crescita della cultura, e quindi della maggior consapevolezza, delle donne, la loro conquista di indipendenza e autonomia. Non solo nelle società occidentali, ma in tutte, comprese le più lontane e insospettabili: “l’aspetto impressionante di questo giro del mondo della bassa fecondità è la natura variegata dei paesi dove le famiglie piccole sono ormai la norma. Alcuni paesi sono ricchi e altri poveri, alcuni cristiani e altri buddisti, musulmani, altri nettamente laici’’, ma tutti hanno in comune lo stesso elemento, e cioè che “sembra assai improbabile che in un prossimo futuro uno qualsiasi di loro assisterà a un aumento della fecondità”. In tutti questi paesi, il dato comune è l’accresciuto ruolo delle donne nella società.
A prescindere dalla celebre politica del figlio unico della Cina, la donna libanese negli anni 60 aveva in media cinque figli, oggi soltanto 1,75; il paese dove la fecondità è calata più vertiginosamente è l’Iran, paese teocratico, mentre uno dei pochi dove resiste un modello famigliare con un maggior numero di nascite è Israele, paese laico. Dell’Europa sappiamo tutto: calano le nascite in Italia, ma anche in Germania, in Francia, e nei paesi del nord, dove per anni si è creduto che l’esistenza di forti forme di welfare famigliare bastassero a sostenere le nascite, mentre oggi reggono solo grazie agli immigrati. Sta di fatto che anche i “campioni di culle” europei fanno i conti con la denatalità, esattamente come li stanno facendo il Pakistan, l’America del Sud, la Tailandia, il Giappone, la Russia, l’Ungheria, la Cina, la Corea, eccetera. La carenza globale di bambini, insomma, ‘’prescinde da religioni e culture’’, scrive Morland. Con una sola eccezione, ovvero, ancora una volta, l’Africa subsahariana, terra dove il calo del tasso di mortalità, unito alla persistenza dell’alta fecondità, “sta alimentando l’esplosione demografica maggiore della storia’’. E anche questa bisognerà in qualche modo imparare a gestirla.
È impossibile, oggi, dire se quello che sta avvenendo è un bene o un male, se questa transizione finirà bene o finirà male, se ci porterà a stare meglio o peggio: di sicuro, sarà ‘’diverso’’. È interessante, come lo è ogni fenomeno nuovo e mai esplorato. L’importante è essere preparati, sapendo che ne saremo, anche nostro malgrado, tutti protagonisti. In questo senso, il saggio di Morland è uno strumento indispensabile, se non altro per uscire dai fin troppi luoghi comuni sull’argomento.
Nunzia Penelope
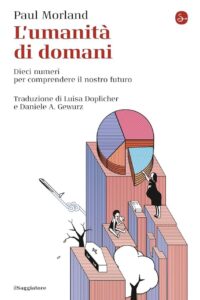
Titolo: L’umanità di domani. Dieci numeri per comprendere il nostro futuro
Autore: Paul Morland
Editore: Il Saggiatore
Data di pubblicazione: novembre 2022
Pagine: 288 pp.
ISBN: 9788842831822
Prezzo: 25,00€