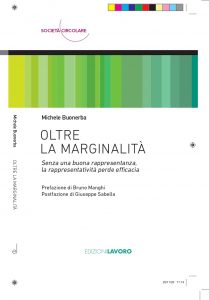 Il futuro del sindacato e la sua capacità di rappresentare gli interessi e i bisogni delle persone. È questo il centro del libro di Michele Buonerba Oltre la marginalità. Senza una buona rappresentanza, la rappresentatività perde efficacia edito da Edizioni Lavoro. Buonerba cerca di tracciare una strada, una via di uscita per il sindacato, la cui capacità di rappresentanza, negli ultimi decenni, è stata costantemente messa sotto sforzo, a causa delle trasformazioni del mercato del lavoro, dall’avvento delle nuove tecnologie, che stanno repentinamente mutando la vita di cittadini e lavoratori, e da ultimo dallo scoppio della pandemia, che l’autore considera come l’ultima chiamata per un sindacato che voglia realmente governare i processi economici e l’implementazione delle politiche pubbliche.
Il futuro del sindacato e la sua capacità di rappresentare gli interessi e i bisogni delle persone. È questo il centro del libro di Michele Buonerba Oltre la marginalità. Senza una buona rappresentanza, la rappresentatività perde efficacia edito da Edizioni Lavoro. Buonerba cerca di tracciare una strada, una via di uscita per il sindacato, la cui capacità di rappresentanza, negli ultimi decenni, è stata costantemente messa sotto sforzo, a causa delle trasformazioni del mercato del lavoro, dall’avvento delle nuove tecnologie, che stanno repentinamente mutando la vita di cittadini e lavoratori, e da ultimo dallo scoppio della pandemia, che l’autore considera come l’ultima chiamata per un sindacato che voglia realmente governare i processi economici e l’implementazione delle politiche pubbliche.
Una crisi che ha avuto i suoi prodromi negli anni ’80, ma già da un decennio iniziavano a farsi sentire gli effetti di una società e di un mondo sempre più globalizzato. Negli ultimi quarant’anni, afferma Buonerba, il lavoro si è progressivamente precarizzato, i bilanci pubblici hanno visto tagli sempre più significativi, con la conseguente riduzione del perimetro del welfare. La crisi di sistema del 2008 non è stata gestita con gli strumenti più adatti, e quella innescata dal covid deve ancora presentarci il conto in termini di costi economici e sociali. Eppure il sindacato italiano continua a mantenere numeri invidiabili rispetto agli altri paesi. Durante la crisi dello scorso decennio gli iscritti sono cresciuti, e i servizi offerti sui territori restano uno degli ultimi presidi di democrazia e legalità per le fasce più deboli.
C’è dunque, spiega Buonerba, un problema non quantitativo ma qualitativo della rappresentanza, ancora legata a vecchi schemi di partecipazione, a un mercato del lavoro novecentesco e alla fabbrica fordista, che oggi non esiste più. La strada da intraprendere è dunque quella di ripartire dai territori, dove è scritto il “destino” delle persone. Sono gli ecosistemi territoriali che incidono sul tenore e la qualità di vita. Nascere in una regione piuttosto che in un’altra può comportare differenze considerevoli in termini di servizi offerti. Anche il sindacato, afferma l’autore, attraverso la contrattazione, dovrebbe guardare ai territori con maggiore attenzione. L’impianto del contratto nazionale di lavoro è utile per definire quelle che sono le regole del gioco, ma diventa d’impaccio quando vuole normare l’aspetto contributivo su tutto il territorio nazionale. Questo, afferma Buonerba, poteva andar bene nel mondo del lavoro del secolo scorso, ma oggi appare anacronistico. Il costo della vita non è uniforme in tutte le aree del paese, e avere un lavoro, in particolare nelle grandi città, non sempre mette le persone al riparo dal rischio di cadere in una condizione di povertà relativa. Ugualmente anche i sussidi e i trasferimenti in denaro, che costituiscono la principale forma di aiuti che viene dallo stato, non intercettano i reali bisogni dei cittadini, favorendo, in molte occasioni, chi evade il fisco.
La prossimità rimane dunque la chiave di lettura per andare incontro alle nuove esigenze. In un contesto nel quale il lavoro è precario e frammentario, i salari bassi e il l’azione del pubblico, nell’ottica di erogazione di servizi, si sta costantemente restringendo, l’azione del sindacato sui territori dovrebbe essere di una maggiore governace del welfare integrativo, e un accesso costante alla formazione.
Secondo l’autore l’intermediazione è una delle principali lacune della sanità integrativa. Nel 2019 la spesa out of pocket, ossia quella che le famiglie hanno dovuto tirar fuori di tasca propria, ha raggiunto i 38 miliardi di euro. L’accrescimento della parte intermediata potrebbe avvenire, da parte delle parti sociali, attraverso la costruzione di un sistema integrativo con ogni regione. In questo modo. E sul versante della previdenza si registra un sistema ancora troppo frammentato. Rimane poi il grande tema del welfare aziendale. Ancora poco diffuso e concentrato in alcuni settori e nelle grandi aziende del nord, ha visto una grande diffusione negli ultimi anni, grazie soprattutto alla decontribuzione. Una rimodulazione del welfare contrattuale in chiave territoriale avrebbe, secondo Buonreba, il merito di includere quei lavoratori, che per il settore e il tipo di occupazione, rischiano di restarne fuori, evitando, inoltre, che il welfare diventi esclusivamente wellness, ovvero detassando solo quei servizi capaci di generare un’effettiva redistribuzione della ricchezza.
Altro capitolo cruciale, identificabile come una quarta area di welfare, è quello della formazione. Le innovazioni tecnologiche, la crisi pandemica, hanno impresso mutazione rapidissime al mondo del lavoro. A tutto questo, sostiene l’autore, si deve far fronte con la formazione. I cambiamenti impongo una revisione del sistema formativo, che dovrà essere più allineato con le richieste del mercato, e la capacità delle parti sociali di sapere conciliare il lavoro con la formazione, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso.
Sono questi gli strumenti che secondo Buonerba il sindacato deve mettere in campo per recuperare nuovamente quella centralità che nel corso degli anni ha perso. Tra le sfide future che attendono il sindacato, oltre alle trasformazioni del mondo del lavoro, la non autosufficienza e l’invecchiamento della popolazione rappresenteranno delle ulteriore scommesse. In un paese con il tasso di natalità tra i più bassi al mondo, con in figli che con crescente difficoltà riusciranno a garantire la giusta assistenza ai genitori, il ruolo delle parti può risultare strategico. La partita, infatti, si giocherà anche sul tema dei valori. Per l’autore il sindacato non dovrebbe unicamente ambire a essere un fornitore di servizi, tramite i patronati e i Caf, ma diventare un promotore di quegli ideali, come la solidarietà, il senso di comunità, la partecipazione e la libertà, che ne costituiscono l’anima. Il cambiamento, parola centrale nel libro di Buonerba, pervade la nostra società. Un cambiamento che molto spesso ci spaventa, che mette alla prova le nostre certezze. Ma negarlo, sostiene l’autore, vorrebbe dire essere destinati a un inevitabile declino e impoverimento.
Tommaso Nutarelli



























