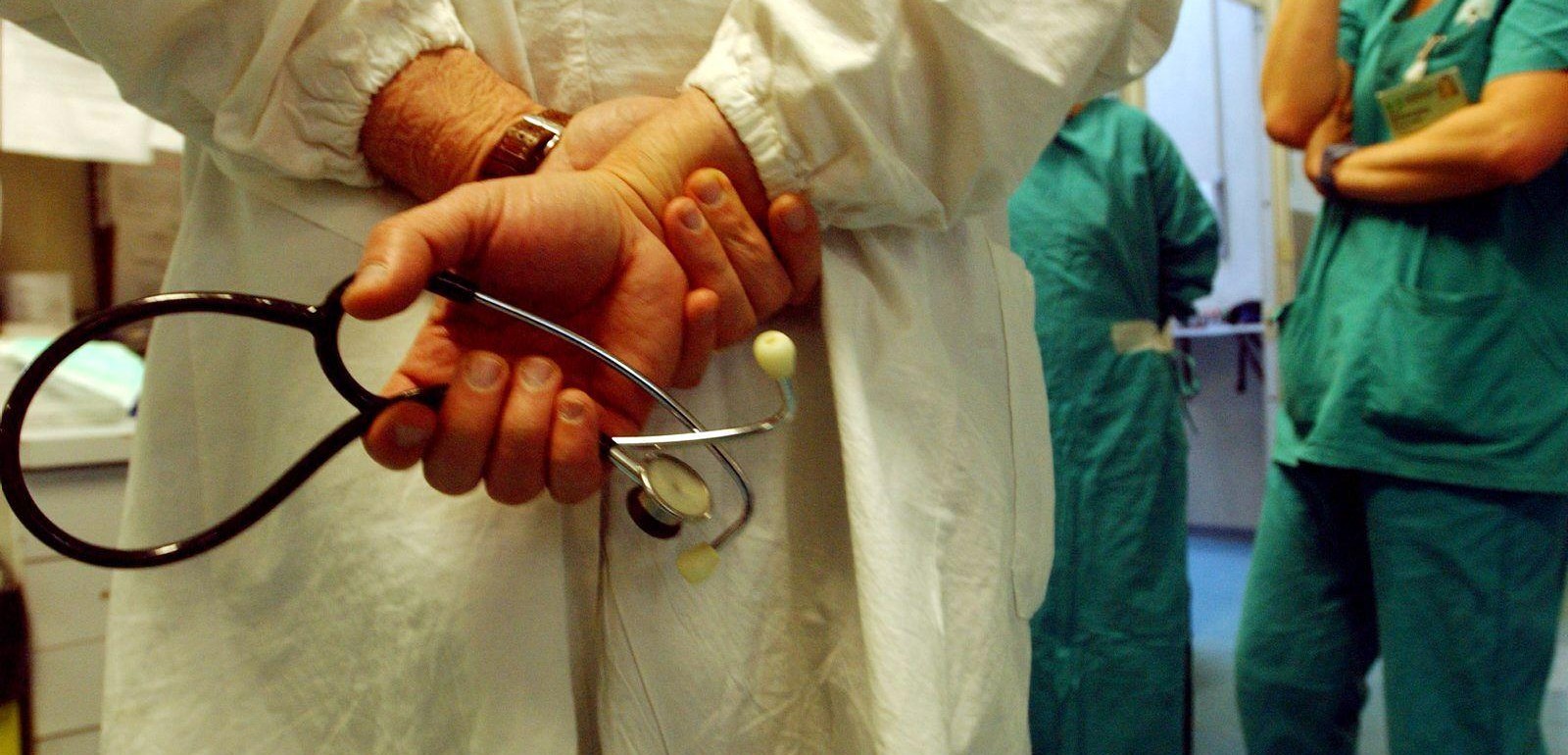Negli ultimi 5 anni i salari italiani hanno perso tra il 7 e l’8% del loro potere di acquisto. E già prima del 2020 erano tra i più bassi nei paesi industrializzati dell’Occidente. Poi è venuta la pandemia, a seguire l’alta inflazione. Un problema di macroeconomia, perché salari bassi portano meno domanda interna e, in un momento in cui la tempesta dei dazi mina il commercio mondiale, ciò rende difficile ogni ripresa. È per questo che il negoziato avviato tra imprenditori e sindacati non potrà eludere il tema dei salari. Il problema è dove e come intervenire.
Un possibile campo potrebbe essere quello del fiscal drag. Di cosa si tratti è noto, dell’erosione delle retribuzioni che crescono nominalmente per l’inflazione, ma vedono aumentare anche le aliquote fiscali cui sono sottoposte, in questo modo impoverendosi. Di recente si è levata più di una voce per affermare che in realtà questo non è un vero problema perché il governo sarebbe già intervenuto per evitare questa diminuzione di reddito. Si è esposto nell’affermare che si tratta di un falso problema anche Guido Tabellini, economista e già rettore della Bocconi, che cita uno studio della Bce a supporto della tesi. Forse ha ragione, ma il problema dei bassi salari resta in piedi.
A proteggere i salari dall’inflazione, del resto, c’è solo la contrattazione, che però strutturalmente non li difende fino in fondo. Secondo gli accordi degli ultimi 15 anni, infatti, i contratti nazionali recuperano non il 100% dell’inflazione subita, resta fuori il peso inflattivo derivato dai prodotti energetici importati, che non è poca roba. È la regola dell’Ipca. Il Patto della fabbrica del 2018, l’ultimo accordo interconfederale, spostò giustamente l’attenzione dal Tem, il trattamento economico minimo, al Tec, il trattamento economico complessivo, guardando così anche al welfare contrattuale, sempre più rilevante, specie per gli interventi in previdenza e sanità. Ma i prodotti energetici sono rimasti fuori, il che significa che, comunque vada, i salari anno dopo anno qualche cosa perdono. Per questo il negoziato avviato a livello interconfederale tra Confindustria e sindacati non potrà non curarsene.
L’attenzione dovrebbe allora puntarsi sui fattori che influiscono negativamente sulla dinamica salariale, nell’ordine tra gli altri i contratti pirata, i ritardi nei rinnovi contrattuali, le disparità territoriali. Anche qui la strada appare tutta in salita. Sui contratti pirata c’è poco da fare. L’unica vera soluzione sarebbe quella di una legge sulla rappresentanza che fissi quali sono i soggetti che possono firmare accordi contrattuali validi per tutti. La Cisl però non la vuole e la strada pattizia è già stata tentata dal 2014, ma il bell’accordo non è stato mai applicato e allora è inutile insistere. Anche perché il governo Meloni sembra essere a favore di questi contratti quanto meno anomali. Non a caso, infatti, sta tentando in tutti i modi di dare sostanza ai contratti “maggiormente applicati”, preferendoli a quelli firmati dai soggetti “maggiormente rappresentativi”.
I ritardi dei rinnovi pesano, perché a volte durano anni e anni. Il contratto del commercio è arrivato l’anno passato dopo cinque anni dalla scadenza, non perché sindacati e Confcommercio non volessero rinnovarlo, ma perché oggettivamente le difficoltà erano enormi. E anche qui pesa l’azione del governo, dal momento che soprattutto i contratti pubblici hanno spesso ritardi immensi, a volte vengono rinnovati quando già la loro vigenza è scaduta. Servirebbe un meccanismo di recupero più incisivo, ma è complicato approvarlo e sarebbe comunque costoso.
L’altro motivo di debolezza salariale è dato dalle disparità territoriali. I minimi salariali valgono per tutto il territorio nazionale, ma il potere di acquisto non è sempre uguale, al contrario le differenze sono a volte molto alte. I sindacati sono sempre stati contrari a forme differenziate di salario. Lavoro uguale, uguale retribuzione, affermano. Principio di equità, certamente, ma le distanze pesano. La contrattazione aziendale in parte supplisce a queste disparità, ma, al di là delle grandi e, a volte, medie aziende, è ben poco presente. Ci sarebbe la contrattazione territoriale che riesce a tener conto dello sviluppo di una determinata regione. Dove è stata applicata, nell’edilizia, agricoltura e artigianato, ha dato buona prova di sé. Gli imprenditori sono però sempre stati molto contrari, temendo che diventi un terzo livello contrattuale obbligatorio. Forse il negoziato interconfederale potrebbe trovare una soluzione.
Massimo Mascini