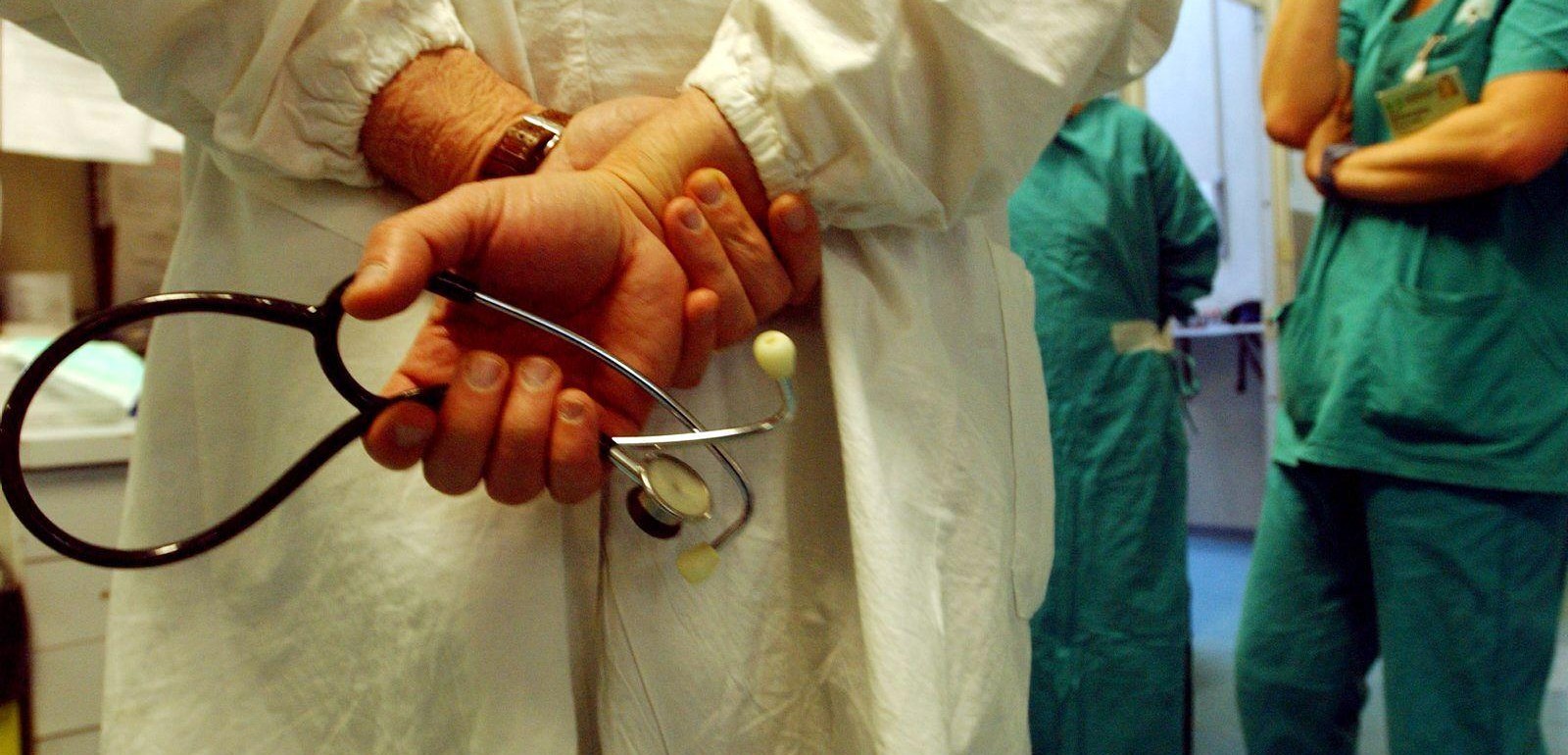Da più parti si sta imputando alla struttura della contrattazione, definita dal protocollo del 1993, la responsabilità per l’insufficiente difesa dei salari italiani dalla recente ondata inflazionistica. Tuttavia, a mio parere, tale lettura rischia di essere superficiale e pericolosamente foriera di ben più gravi errori di prospettiva. Innanzitutto, mettere mano a quella struttura è materia complicata e, aggiungo io, delicata.
Si corrono due rischi: il primo è quello di introdurre surrettiziamente un meccanismo, più o meno automatico, che rischia di trascinare l’inflazione ex post, stabilmente, per effetto degli incrementi contrattuali. Pericolo che era insito nel meccanismo della contingenza e che, come spesso si ricorda, Tarantelli voleva evitare con la “predeterminazione” degli aumenti contrattuali (su questo aspetto mi permetto di tornare tra poco). Il meccanismo previsto dal protocollo del 1993, tuttavia, aveva una sua coerenza di sistema che non può, e a mio parere non deve, essere smantellata. Si tratta del diverso ruolo assegnato al CCNL e alla contrattazione di prossimità (quella di secondo livello).
Come si dice tra gli esperti del campo, la regola è “Ne bis in idem” non si può fare la stessa cosa due volte, per questo l’accordo del 93 assegnava, opportunamente, al contratto collettivo nazionale la tutela dei salari reali e alla contrattazione di secondo livello gli incrementi degli stessi, collegati alla crescita della produttività.
Può non piacere, ma se si confondono i due livelli uno dei due rischia di scomparire. Infatti, in molti paesi la contrattazione di secondo livello non esiste, oppure non esiste, così come lo conosciamo, noi il contratto collettivo nazionale (analizzare con attenzione anche lo stesso caso della Germania). Per inciso, se poi in questi paesi i salari reali dei lavoratori sono più alti di quelli italiani, questo dipende da molti fattori, che sarebbe dilettantesco non affrontare, li cito solo a titolo di esempio: ovviamente la produttività è uno di questi, ma anche la struttura del costi totali; se si devono affrontare extra costi per l’energia è evidente che ci sarà una pressione sulle altre componenti di costo di produzione, ma non si tratta solo di questo, si pensi ad esempio ai costi, cosiddetti, impliciti, del sistema burocratico italiano sull’impresa e si provi a compararli con quelli di altri paesi europei (lo so che questo approccio può essere meno “romantico” della generica definizione dello sfruttamento capitalistico…che piace tanto alla narrazione di parte di certa sinistra, ma mi pare ovvio che a parità di sfruttamento, i lavoratori tedeschi stanno meglio di quelli italiani…sbaglio?).
La struttura della contrattazione, così come definita dal protocollo del ‘93, ha retto molto bene nei periodi di bassa inflazione (anzi, con l’incremento speculativo dell’inflazione determinato dall’introduzione dell’euro, ha persino consentito, nel tempo, di tutelare i salari reali meglio di altri sistemi di adeguamento automatico degli stessi); a riprova di ciò si vedano gli aumenti contrattuali nell’ultima fase precedente la fiammata inflazionistica determinata dalla guerra in Ucraina.
Quegli aumenti, previsti dallo stesso CCNL, iniziavano a distribuire quote di produttività incrementando, anche se di poco, i salari reali (quelli lordi…ovviamente, sulla perversa struttura fiscale mi riservo di dire tra poco).
Che cosa ha messo in crisi quella struttura e perché? che cosa va migliorato in quella struttura e perché?
Sicuramente la fiammata inflazionistica immediatamente successiva al conflitto è stata di tale virulenza da colpire rapidamente il potere di acquisto dei salari, non solo italiani, ma di molti paesi europei, l’indice IPCA (inflazione programmata, non solo prevista….dico io) non è ovviamente in grado di coprire l’impatto dell’inflazione ex ante, specie se questa è determinata da componenti esogeni come l’incremento delle materie prime, che lo stesso indice, opportunamente, non deve considerare ( non vorrei spiegare per quale motivo, mi dilungherei troppo, ma certamente qualche economista …alla Tarantelli potrebbe dire meglio).
Rimane il fatto che i salari a causa di quella fiammata hanno perso, nel periodo, sottolineo nel periodo, una fetta consistente di potere di acquisto.
Si poteva evitare senza compromettere la struttura della contrattazione? sì si poteva! e si doveva, facendo bene ciascuno il suo lavoro: si potevano concordare interventi di una tantum, come per esempio si fece in Francia, alla Renault, e in altre aziende.
Come sanno quelli che si occupano di Relazioni industriali, l’una tantum ha il grande vantaggio di non avere effetti di trascinamento sulla struttura dei costi (o meglio di averli trascurabili).
Il governo poteva favorire questi interventi “emergenziali” a tutela del potere di acquisto? Sì poteva e doveva e il sindacato, nell’ambito di una saggia “politica dei redditi” avrebbe dovuto chiederlo, magari in quella occasione rivendicando che gli stessi fossero totalmente detassati (se non erro questo non avrebbe comportato alcun onere per il bilancio dello stato, se non in una logica di “lucro cessante”, ma essendo un aumento una tantum, non avrebbe potuto essere replicato negli anni, cosa che invece avviene con i rinnovi dei minimi contrattuali).
Piccola considerazione, a seguito della mia piccola esperienza nel campo delle relazioni industriali – in Telecom per 10 anni e in Poste Italiane per altri 10- gli aumenti una tantum, oltre a non avere effetti di trascinamento sulla struttura dei costi, hanno anche il vantaggio che, in genere, sono “uguali per tutti” perché calcolati sulla retribuzione media di riferimento della categoria. Cosi facendo hanno la capacità di tutelare meglio i redditi più bassi e un po’ meno bene quelli più alti (se si è bravi, in azienda, si cerca sempre di trovare una mediana tale da consentire di tutelare meglio anche quelli medio-alti, per esempio la retribuzione dei Quadri. Per i Dirigenti, come dicevo io in trattativa alle mie controparti sindacali… sono affari nostri !!).
Per fare un esempio concreto: se con il governo si fosse raggiunto un accordo “d’emergenza” con il quale garantire la detassazione “eccezionale” di una una tantum contrattuale (CCNL) fino ad un massimo di 2000 euro, si sarebbe molto contenuta la perdita di potere di acquisto nell’immediato, e lo Stato avrebbe avuto comunque un beneficio per effetto dell’incremento dei consumi, o anche del suo non decremento, a conseguenza della tassazione degli stessi (IVA).
So che adesso verrà mossa un’altra obiezione: ma poi, dopo l’una tantum, l’inflazione continua ad erodere il potere di acquisto dei salari reali, come si possono difendere gli stessi, senza terremotare la struttura della contrattazione? mi permetto di evidenziare che l’indice IPCA si riferisce all’inflazione programmata, per cui, nell’ambito di una serie politica dei redditi, il sindacato avrebbe potuto tranquillamente chiedere al governo un indice leggermente superiore all’inflazione prevista, magari avendo a riferimento l’inflazione del cosiddetto “carrello della spesa” invece che quella definita dai costi al netto delle materie prime.
Nel tempo, come in parte sta già accadendo, per le categorie virtuose, che rinnovano per tempo il Ccnl, i salari reali avrebbero recuperato il loro pieno potere di acquisto, senza innescare nuova inflazione.
E qui arrivo all’altro aspetto, se vogliamo, il limite vero dell’accordo del 1993, che succede se non si rinnovano per tempo i contratti scaduti? esiste una qualche sanzione che intervenga? nella struttura del 1993 non esiste! attenzione però, se si guardano i recenti rinnovi contrattuali, non sono certo le categorie industriali a soffrire del mancato rinnovo, per tempo, del loro Ccnl.
A parte alcuni casi come, l’ASSTEL (l’associazione che riunisce le aziende di telecomunicazione e che sta saltando un ciclo contrattuale, ma questa è un’altra storia, sulla quale potrei scrivere ancora), la maggior parte delle categorie che non rinnova, per tempo, il proprio CCNL sono nel settore terziario e …udite, udite, nel pubblico impiego! E guarda caso sono le categorie che più hanno sofferto di una perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni reali.
Il Ministero del Lavoro, quando funzionava, in questi casi interveniva con la propria “moral suasion” per tentare di avvicinare le parti (qualcuno ricorda il “Lodo Scotti” per i metalmeccanici?), ma mi sembra di capire che questi non siano i tempi giusti…né i ministri giusti! In ogni caso questa non è una soluzione di “sistema” e allora che fare? qualche “fraticello minore” dell’ordine delle Relazioni Industriali (ordine in crisi per crisi delle vocazioni) suggeriva, in tempi non sospetti, di introdurre, o meglio ampliare, l’istituto dell’arbitrato.
Oggi lo stesso viene indicato solo per le controversie individuali.
Se invece le parti (sempre loro…ahimè) concordassero che dopo un periodo di tempo, da considerarsi “fisiologico” dalla scadenza del CCNL (sei mesi…un anno…), non si fosse raggiunto un accordo allora potrebbe intervenire un arbitrato, magari anche solo sulla materia dei minimi contrattuali, il cui verdetto sarebbe obbligatorio per le parti stesse (libere di continuare a litigare sul resto…) forse questo aiuterebbe ad evitare pesanti ritardi contrattuali che poi sono la vera ragione delle difficoltà a tenere il passo con l’inflazione.
Quanto al tema del rapporto retribuzioni da lavoro dipendente e fisco, mi trovo completamente d’accordo con i rilievi critici fatti da coloro che, hanno bocciato la recente proposta di detassazione degli aumenti contrattuali (non approfondisco il tema, mi permetto solo di evidenziare che provo una profonda tristezza per il consenso dato a quella proposta da dirigenti confederali che così facendo, non si rendono conto che stanno minando le basi dello stesso sindacalismo confederale).
Voglio soltanto sottolineare che, per ora la struttura delle retribuzioni prevede una diversa tassazione solo per i buoni pasto e gli aumenti concordati a livello aziendale sulla produttività, per inciso le diverse circolari INPS hanno sempre più ristretto questa fattispecie, secondo me opportunamente, agli aumenti contrattuali, collegati ad “effettivi” incrementi di produttività.
Qualche domanda sul perché nel pubblico impiego questa prassi non è cosi diffusa? o perché i sindacati abbiano mai chiesto di destinare risorse certe a questa fattispecie? non mi si risponda che è difficile misurare la produttività di questi comparti, perché vorrei ricordare che esiste una fiorente letteratura a tal riguardo (basta spulciare qualche testo conservato nelle polverose biblioteche dell’ordine monastico delle Relazioni Industriali).
Infine sul tema tassazione del lavoro o tassazione della rendita? sono d’accordo con tutte le osservazioni finora fatte: la struttura della tassazione nel nostro paese di fatto punisce il lavoro e premia la rendita (siamo ancora un sistema feudale e infatti si cerca in tutti i modi di evadere la riscossione dei tributi da parte del feudatario).
Purtroppo un nuovo, diverso e più moderno sistema fiscale necessita un “nuovo, diverso e più moderno contratto sociale”, e questo non può che impattare su rendite garantite e interessi di posizione che nulla hanno a che fare con lo sviluppo del paese.
Lo stesso tema della patrimoniale andrebbe collocato in un’altra prospettiva, quella della riduzione significativa dell’Irpef (imposta sul reddito) per lo più di dipendenti e pensionati in cambio di una seria imposizione sulle rendite; ma questo avrebbe necessitato la revisione dei dati catastali, e se non ricordo male anche su questo Draghi fu lasciato solo.
Luigi Marelli