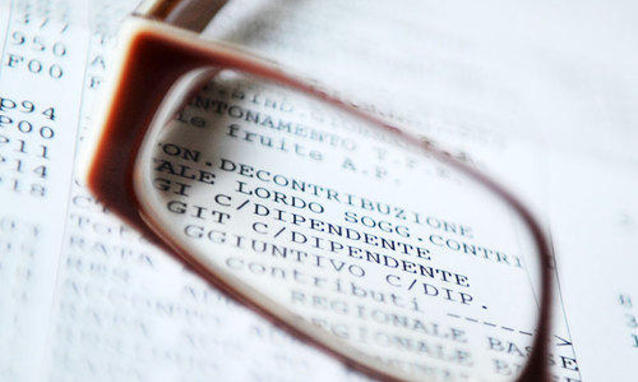Continua ad aumentare il numero di pensionati, prosegue la netta risalita del tasso di occupazione e risale, inoltre il rapporto tra occupati e pensionati, che dunque migliora anche se è ancora distante dai valori pre-Covid. Sono queste le evidenze emerse dall’undicesimo rapporto del centro studi di Itinerari Previdenziali (“Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2022”), presentato alla Camera. I dati, sostiene Itinerari Previdenziali, descrivono un sistema in equilibrio, ma la cui stabilità nei prossimi anni dipenderà da una parte dalla capacità di porre un limite alle troppe eccezioni alla riforma Monti-Fornero e all’eccessiva commistione tra previdenza e assistenza; dall’altra da quella di affrontare adeguatamente la transizione demografica in atto e, in particolare, l’invecchiamento della forza lavoro.
Entrando nel dettaglio del rapporto, dopo un trend positivo avviatosi nel 2009 e proseguito in modo costante fino al 2018, per effetto delle ultime riforme previdenziali che hanno innalzato gradualmente requisiti anagrafici e contributivi il numero di pensionati è di nuovo in risalita. I percettori di assegno pensionistico sono 16.131.414 nel 2022 a fronte dei 16.098.748 nel 2021 e dei 16.004.503 del 2018, anno in cui si era toccato il valore più basso di sempre. Un incremento, sottolinea il rapporto, ascrivibile alle molteplici vie d’uscita in deroga alla Fornero introdotte dal 2014 in poi e culminate negli ultimi anni con l’approvazione prima di quota 100 nel 2019 e a seguire di quota 102. Cresce poi anche il tasso di pensionamento grezzo rilevato dalla pubblicazione: su 3,65 residenti italiani almeno uno è pensionato, dato obiettivamente molto elevato se si tiene conto che il picco dell’invecchiamento della popolazione verrà toccato nel 2045.
Lo studio rileva un aumento di 32.666 pensionati rispetto al 2021 (+0,20% in più in termini di variazione percentuale), con gli uomini che salgono di 27.136 unità e le donne pensionate che incrementano invece il loro numero, nel confronto con la precedente rilevazione, di sole 5.530 unità (erano aumentate di oltre 20mila unità tra il 2020 e il 2021). Un trend al ribasso che può essere interpretato come la non immediata conseguenza dell’inasprimento dei requisiti avvenuto con la riforma del 2012 e, in particolare, dell’equiparazione tra i generi dell’età pensionabile a partire dal 2018. Degli oltre 16 milioni di pensionati il 51,7% è rappresentato da donne, tra l’altro destinatarie dell’87% del totale delle pensioni di reversibilità (con quote della pensione diretta del dante causa variabili tra il 60% e il 30%, in base al reddito del superstite). Per quanto riguarda il numero di prestazioni pensionistiche al 2022 ne risultano in pagamento 22.772.004 (+0,06% rispetto al 2021 pari a 13.207 trattamenti).
Il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati si attesta a 1,4443. Si tratta di un valore fondamentale per la tenuta di un sistema pensionistico a ripartizione come quello italiano e che, solo nel 2019, toccava la quota record di 1,4578, miglior dato di sempre tra quelli registrati dal report. “Resta dunque piuttosto distante quell’1,5 già indicato nelle precedenti pubblicazioni come soglia minima necessaria per la stabilità di medio-lungo termine della previdenza obbligatoria”, evidenzia il centro studi. Le previsioni per gli anni a venire sono quelle di un ulteriore lento, ma progressivo miglioramento, sempre che si riescano a tenere sotto controllo gli effetti su materie prime ed energia di scenari geopolitici incerti e a patto di investire in politiche attive per il lavoro e politiche industriali che sappiano rispettivamente arginare il fenomeno del mistmach tra domanda e offerta e rilanciare la stagnante produttività del Paese capitalizzando le risorse del Pnrr.
Il tutto, aggiunge il report, riducendo il numero delle uscite anticipate per garantire sostenibilità anche ai più giovani, nell’ambito di quel patto intergenerazionale insito in un sistema che vede appunto le pensioni di quanti sono già in quiescenza pagate con i contributi versati dai lavoratori attivi.
Sul fronte lavoro, invece, i dati sono in continuo miglioramento, ma l’Italia si conferma tra le nazioni peggiori in Europa sul fronte occupazionale. Secondo i dati Eurostat riferiti al terzo trimestre 2023 l’Italia è infatti all’ultimo posto per occupazione globale, distante di quasi 10 punti percentuali dalla media europea (61,4% contro 70,4%); per occupazione femminile (52,5% contro il 65,7% della media europea); per occupazione giovanile (15-24 anni), dove e quartultima tra i 27 Paesi Ue (20,1% contro una media del 35,2%). Solo poco meglio l’occupazione senior (persone tra i 55 e i 64 anni), dove l’Italia tocca il 58% contro il 64,3%della media Ue.
Quanto al capitolo spesa, nel 2022 l’Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 559,513 miliardi di euro con un incremento del 6,2% rispetto all’anno precedente (32,656 miliardi). La spesa per prestazione sociali ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale (il 51,65%). Rispetto al 2012, e dunque nell’arco di un decennio, la spesa per welfare è aumentata di ben 127,5 miliardi strutturali (+29,4%). Aumento ascrivibile soprattutto agli oneri assistenziali a carico della fiscalità generale, cresciuti del 126,3% a fronte dei soli 37 miliardi della spesa previdenziale (+17%) e del 18% del Pil. I dati sottolineano l’esigenza di richiamare nuovamente l’attenzione sulla necessità di separare previdenza e assistenza.
Nel 2022 il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale è ammontato a 157 miliardi con un aumento di 12 mld rispetto ai 144,2 del 2021. Nel complesso, la spesa pensionistica di natura previdenziale comprensiva delle prestazioni Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) è stata nel 2022 pari a 247,588 miliardi, per un’incidenza sul Pil del 12,97% in calo rispetto al 13,42% dell’anno precedente.
In sostanza, il sistema pensionistico è “sostenibile” e “lo sarà anche tra 10-15 anni, nel 2035-40, quando la maggior parte dei baby boomer nati dal Dopoguerra al 1980 saranno in pensione”. È quanto affermato dal presidente del centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, commentando i dati dell’undicesimo rapporto. “Perché si mantenga questo sottile equilibrio – ha detto – sarà però indispensabile intervenire in maniera stabile e duratura, tenendo conto di alcuni principi fondamentali: le età di pensionamento, attualmente tra le più basse d’Europa (circa 63 anni l’età effettiva di uscita dal lavoro in Italia nonostante un’aspettativa di vita tra le più elevate a livello mondiale), e che dovranno dunque gradualmente aumentare evitando il ricorso a eccessive anticipazioni; l’invecchiamento attivo dei lavoratori, attraverso misure volte a favorire un’adeguata permanenza sul lavoro delle fasce più senior della popolazione; le politiche attive del lavoro, da realizzare di pari passo con un’intensificazione della formazione professionale, anche on the job; la prevenzione, intesa in senso più ampio come capacità di progettare una vecchiaia in buona salute”.
Insomma, Brambilla ha sollecitato un serio cambio di rotta da parte del Paese, che al momento naviga a vista senza una bussola, dinanzi alla più grande transizione demografica di tutti i tempi, con grande parte della spesa pubblica indirizzata verso sussidi e assistenzialismo (frenando le possibilità di crescita), quando invece, anche alla luce di un debito pubblico che a breve potrebbe sfondare la soglia dei 3.000 miliardi di euro, la priorità sembrerebbe essere una seria revisione dei propri modelli produttivi e del proprio mercato del lavoro.
e.m.