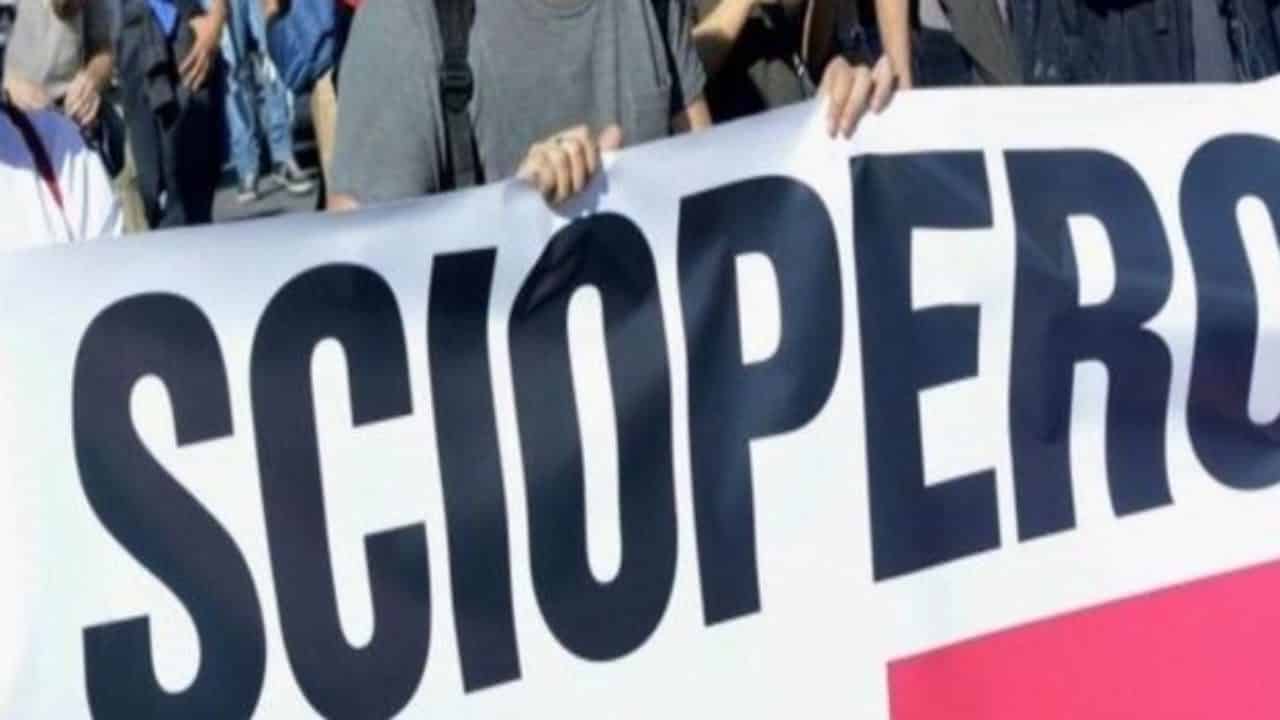di Pietro de Biasi – Responsabile risorse umane e relazioni industriali Gruppo Riva
Dai recenti accordi ILVA microrisposte alla crisi sociale
Il 30 aprile scorso l’ILVA ha sottoscritto con le segreterie provinciali di FIM, FIOM, UILM di Taranto un accordo che istituisce un salario minimo di 1000 euro netti per i dipendenti in cassa integrazione a partire dal prossimo giugno; il 13 maggio ne è stato raggiunto un altro con le segreterie nazionali, valido quindi per tutta l’Ilva, che rinvia il rinnovo della parte economica del contratto integrativo scaduto il 31 dicembre 2007 al 2010, a fronte di un premio una tantum di 640 euro lordi, che fa seguito ad una erogazione di € 550 concordata in via provvisoria nell’ottobre scorso per il 2008. Entrambi questi accordi vanno inquadrati nell’attuale, difficilissima congiuntura economica.
La siderurgia italiana, ma più in generale quella europea, sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia. I dati del primo trimestre parlano di cali produttivi violentissimi. Anche il secondo trimestre dell’anno non è iniziato meglio, anzi: la Germania, primo produttore europeo, ha segnato un crollo della produzione nel mese di aprile di oltre il 50% rispetto all’anno precedente, fermandosi a livelli che non si vedevano addirittura dal 1949.
Purtroppo gli effetti di questa situazione sono ben evidenti. Senza voler riportare troppi dati statistici, basti pensare che lo stabilimento ILVA di Taranto, che da solo ha prodotto nel 2008 ca. un terzo di tutto l’acciaio italiano, sta fermando in questi giorni il terzo altoforno su quattro e prevede, a partire da giugno di portare il numero dei cassaintegrati a ca. 6700 unità, su una forza complessiva di 12.500, riducendo la produzione nei prossimi mesi al 30% dei livelli abituali.
E’ sin troppo ovvio che questo quadro di riferimento ha posto oggettivamente in grave tensione il sistema delle relazioni industriali in azienda.
Le OO.SS. avevano preparato nell’estate 2008 una piattaforma rivendicativa per la contrattazione integrativa largamente basata sul ciclo economico estremamente positivo che la siderurgia aveva vissuto nel triennio 2005-2007. Hanno invece dovuto fare i conti con uno scenario improvvisamente e drasticamente cambiato.
Dal canto suo anche l’ILVA si è trovata a dover gestire, per la prima volta dall’inizio della gestione RIVA, la necessità di ricorrere sempre più massicciamente alla cassa integrazione e di implementare tutte le possibili misure di riduzione costi che una tale crisi richiede.
La decisione strategica che l’azienda ha preso in questo frangente è stata di cercare con determinazione un percorso condiviso con il sindacato. Diverse motivazioni hanno concorso a questa scelta, ma la principale è stata una valutazione complessiva della situazione sociale.
Va considerato innanzi tutto che la Cassa Integrazione, pur essendo nel panorama europeo il più ampio degli ammortizzatori sociali a disposizione in costanza di rapporto di lavoro, è uno strumento pensato per interruzioni dell’attività lavorativa relativamente brevi; in una crisi della durata e della dimensione dell’attuale, anch’essa risulta alla lunga insufficiente.
Vi sono poi le specificità dell’area tarantina, probabilmente simili a molte altre parti del mezzogiorno. L’occupazione femminile molto bassa fa sì che la grande maggioranza dei nuclei famigliari siano monoreddito, l’indebitamento è, per gli standards italiani, molto alto, quasi il venti per cento dei dipendenti dello stabilimento di Taranto ha pagamenti rateali in corso sulle buste paghe ed infine le condizioni del mercato del lavoro locale rendono molto difficile anche il ricorso ad attività saltuarie in nero per integrare il reddito, come avviene invece in molte aree del nord.
Tutto ciò pone all’azienda un problema che si può ben definire di tenuta sociale e professionale della propria forza lavoro. Infatti, nel momento in cui la sospensione dell’attività lavorativa si protrae per mesi (e purtroppo nell’attuale crisi il numero dei mesi sarà alto), la semplice erogazione dell’indennità di cassa può non riuscire più ad impedire un grave deterioramento delle condizioni di vita del dipendente e del suo nucleo famigliare, ciò, insieme ad una lunga lontananza dall’ambiente di lavoro, rischia potenzialmente di danneggiarne anche il patrimonio professionale, in termini di motivazione, autostima, abitudine al lavoro, e può anche provocare forme di obsolescenza nei casi di maggiore specializzazione professionale. In una realtà che coinvolge migliaia di esuberi temporanei si pone quindi un duplice rischio: uno sociale in senso lato, ovvero l’improvviso impoverimento di un’intera comunità, ed uno più specifico aziendale, il potenziale deperimento del proprio patrimonio professionale.
Mentre in caso di esuberi strutturali, i licenziamenti, è innanzi tutto il sistema generale di welfare che deve farsi carico sia della difesa del reddito (al quale partecipa spesso anche l’azienda), sia, soprattutto della riconversione professionale, nella situazione attuale, di una pesante e prolungata, ma comunque temporanea, crisi, l’azienda che decide di ricorrere alla CIGO deve porsi anche il problema di una gestione complessiva della sospensione dell’attività lavorativa.
A questo hanno mirato gli accordi in questione. L’accordo specifico sul regime di cassa ha fissato una retribuzione netta, piuttosto che ricorrere ad altri meccanismi ampiamente diffusi, quali la maturazione per ratei di voci retributive indirette, per dare maggior certezza ai dipendenti circa l’effettiva entità del reddito disponibile mensilmente durante la cassa integrazione. Una parte dell’integrazione è stata poi obbligatoriamente collegata alla partecipazione a giornate di formazione in house, con cadenza almeno mensile, con il duplice obiettivo di mantenere attivo il collegamento “esistenziale” del lavoratore con la realtà di stabilimento, oltre che naturalmente di fornire comunque un supporto formativo durante una lunga inattività.
L’accordo di rinvio della contrattazione integrativa si inserisce nella stessa logica. Un tradizionale rinnovo con un aumento del PdR non avrebbe avuto alcun senso, non solo perché la funzione principe della retribuzione aziendale è onorare incrementi marginali di redditività e/o produttività, ovviamente inesistenti in questa fase congiunturale, ma soprattutto per la semplice ragione che qualsiasi tipo di aumento non avrebbe raggiunto quel 50% della platea attualmente in CIGO. Il rinvio della trattativa rappresenta quindi essenzialmente una responsabile presa d’atto da parte delle OO.SS. della sua stessa inutilità nelle attuali condizioni. In questo senso il premio una tantum rappresenta invece una soluzione efficace (che peraltro ha un immediato ed autorevole precedente: in Germania l’IGM, in una situazione congiunturale per la siderurgia altrettanto grave, ha accettato, per la prima volta, nel rinnovo del contratto nazionale un aumento 0, in cambio di una erogazione una tantum e di diverse misure di difesa dell’occupazione e del reddito). Infatti esso raggiunge anche i lavoratori sospesi, integrandone quindi il reddito, e compensa, sia pure parzialmente, gli occupati attivi del crollo dei valori dell’attuale retribuzione integrativa, che in Ilva è essenzialmente legata all’andamento produttivo e che dunque quest’ anno subirà una drastica decurtazione. Per quanto riguarda l’azienda, la suddivisione in due tranches del premio, con la seconda prevista per gennaio del prossimo annuo, riduce l’impatto economico nell’anno horribilis 2009 a “soli” 320 euro, a fronte di un calo del PdR ben più consistente.
Un’ ultima considerazione di carattere generale va fatta sulla duttilità del sistema contrattuale. Una libera e responsabile negoziazione aziendale consente di gestire con l’adeguata flessibilità anche situazioni così eccezionali, trovando strumenti idonei a contemperare l’interesse aziendale ad una riduzione dei costi con le legittime aspettative ed i bisogni dei dipendenti. Purtroppo negli altri paesi europei più avanzati questa flessibilità – e responsabilità delle parti sociali- esiste anche nella contrattazione nazionale e/o di settore, mentre invece in Italia un malinteso dirigismo di stampo paternalistico vuole che, durante la più grave crisi economica degli ultimi 50 anni, gli incrementi delle retribuzioni siano decisi da esercizi di chiaroveggenza cabalistica sui futuri tassi di inflazione a 42 mesi.