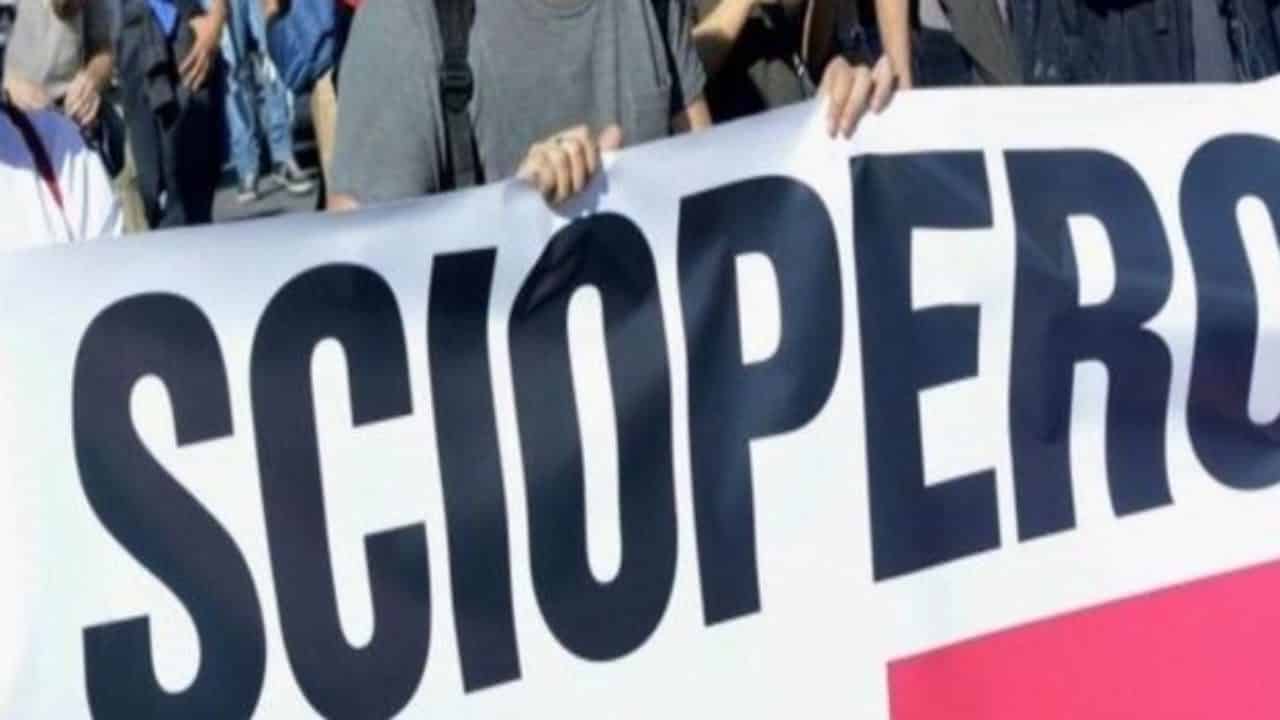di Susanna Camusso, segretaria confederale Cgil
“L’enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate” viene pubblicata nel momento più delicato della crisi economica mondiale. Momento più delicato perché dopo una caduta precipitosa, la parziale stabilizzazione del sistema finanziario, e una decelerazione della discesa della produzione industriale, hanno indotto molti, troppi, a pensare – tirando un sospiro di sollievo – che la “nottata stava passando” e quindi si poteva ripartire con quel modello economico e finanziario che il “ciclone” aveva messo in discussione.
Dileguate le autocritiche degli economisti liberisti, dilatato il tempo per decidere se definire nuove regole mondiali, abbassata la guardia sulla necessità del primato della politica, tornano ad esprimersi i teorizzatori del mercato che si autoregola.
L’Enciclica “Caritas in Veritate”, invece, partendo dalla persona e dalla sua pienezza, rovescia i termini, propone una priorità:
“La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono, che, soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento per tutti”.
Un giudizio netto che ricolloca il lavoro di uomini e donne al centro del governo del mondo. L’insicurezza è generata dall’assenza di lavoro, l’ineguaglianza in un paese o tra i paesi è ciò che mette a rischio non solo la coesione sociale, ma la democrazia. Con nettezza si dice che l’abbassamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori o la rinuncia a meccanismi di redistribuzione del reddito impediscono uno sviluppo di lunga durata.
Quale enorme distanza dai teorizzatori della crescita delle diseguaglianze come ricaduta inevitabile, anzi opportuna, della crescita. Eppure quei teorizzatori hanno dominato per molti anni il pensiero economico.
Se il lavoro e l’eguaglianza tra i paesi sono i motori dello sviluppo, i fenomeni migratori non sono la catastrofe insidiatrice dei paesi ricchi e della loro stabilità. Da qui la necessità di una politica lungimirante che ha la prospettiva di “salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie emigrate, e al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi emigrati”.
Persone, quindi lavoro, quindi diritti, quindi strategie di solidarietà; nessuna indulgenza all’individualismo che il liberismo teorizza ed induce.
L’Enciclica non si limita a tracciare l’analisi della crisi e dei cambiamenti di prospettiva necessari, ne declina le politiche, afferma la solidarietà come strategia essenziale e sottolinea con vigore l’esigenza che le organizzazioni sindacali non si chiudano nelle categorie (potremmo tradurlo con il no alle tentazioni corporative) e guardino oltre i loro iscritti, all’insieme dei lavoratori del proprio e degli altri paesi.
Qui si trova un messaggio ed un’idea che la Cgil ha sempre tradotto nel sindacato confederale generale dei lavoratori. Una organizzazione generale dei lavoratori, potremmo dire del lavoro, non associazione dei soli soci.
Un Sindacato confederale che a partire dal lavoro, dai diritti che dal lavoro sono nati, guarda al lavoratore come persona nella sua interezza. Per questo vi è un filo rosso, che lega i diritti del lavoro a quelli sociali per completarsi in un’idea di cittadinanza e di diritti di cittadinanza, che da completezza alla dignità e all’autodeterminazione delle persone.
Il lavoro connota gran parte dell’identità delle persone, ma non è esclusivo; il riconoscere la pluralità di identità che ognuno porta con sé non deve però mai trascurare che il lavoro porta valori generali. Come non condividere quindi, l’Enciclica quando arriva alla conclusione che non si deve necessariamente sposare la tesi di un avvenuto passaggio dalla centralità del lavoratore alla centralità del consumatore?
La trappola del “consumatore” soggetto al centro delle politiche è la stessa che non fa vedere il “consumo” del mondo, la crescita infinita di beni, l’assenza di una qualità della vita e dello sviluppo, che tralascia la sostenibilità facendosi abbagliare dalla crescita di ricchezza per pochi.
Troppo spesso la politica ha scelto la “scorciatoia” del consumatore, forse pensando di avere individuato il soggetto di riferimento trasversale. Scorciatoia perché non si parte da un soggetto di riferimento, le cui condizioni permeano l’elaborazione di una politica generale, ma da un teorico soggetto “universale”. Così non si leggono più le diseguaglianze, i divari che si allargano, le marginalità crescenti, le vecchie e nuove discriminazioni. Questa “trappola” rende marginale il tema della distribuzione del reddito e della sua eticità, il rapporto tra economia reale e finanza, la distanza tra manager e lavoratori nelle retribuzioni, il valore del lavoro.
Oggi il tema della redistribuzione del reddito, non è solo immaginare, progettare un mondo migliore, non è solo aggredire le cause che portano alla “grande crisi”, è porsi il tema della eguaglianza. Tema dell’eguaglianza che porta in sé quello delle libertà e della democrazia.
La rivoluzione francese incompiuta, ma ancora attuabile.
Certamente l’Enciclica propone una lettura compiuta, non tutta, per me, condivisibile, ma conforta nella convinzione che non siamo condannati al “pensiero unico”, in questo la crisi è un’opportunità, soprattutto se il lavoro torna ad essere pensato, vissuto, descritto con la L maiuscola.